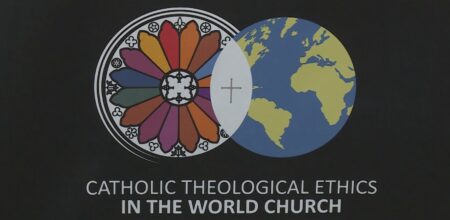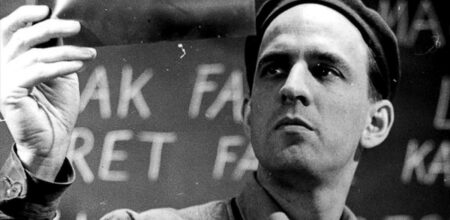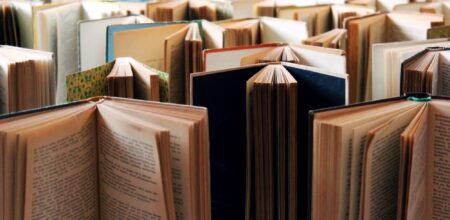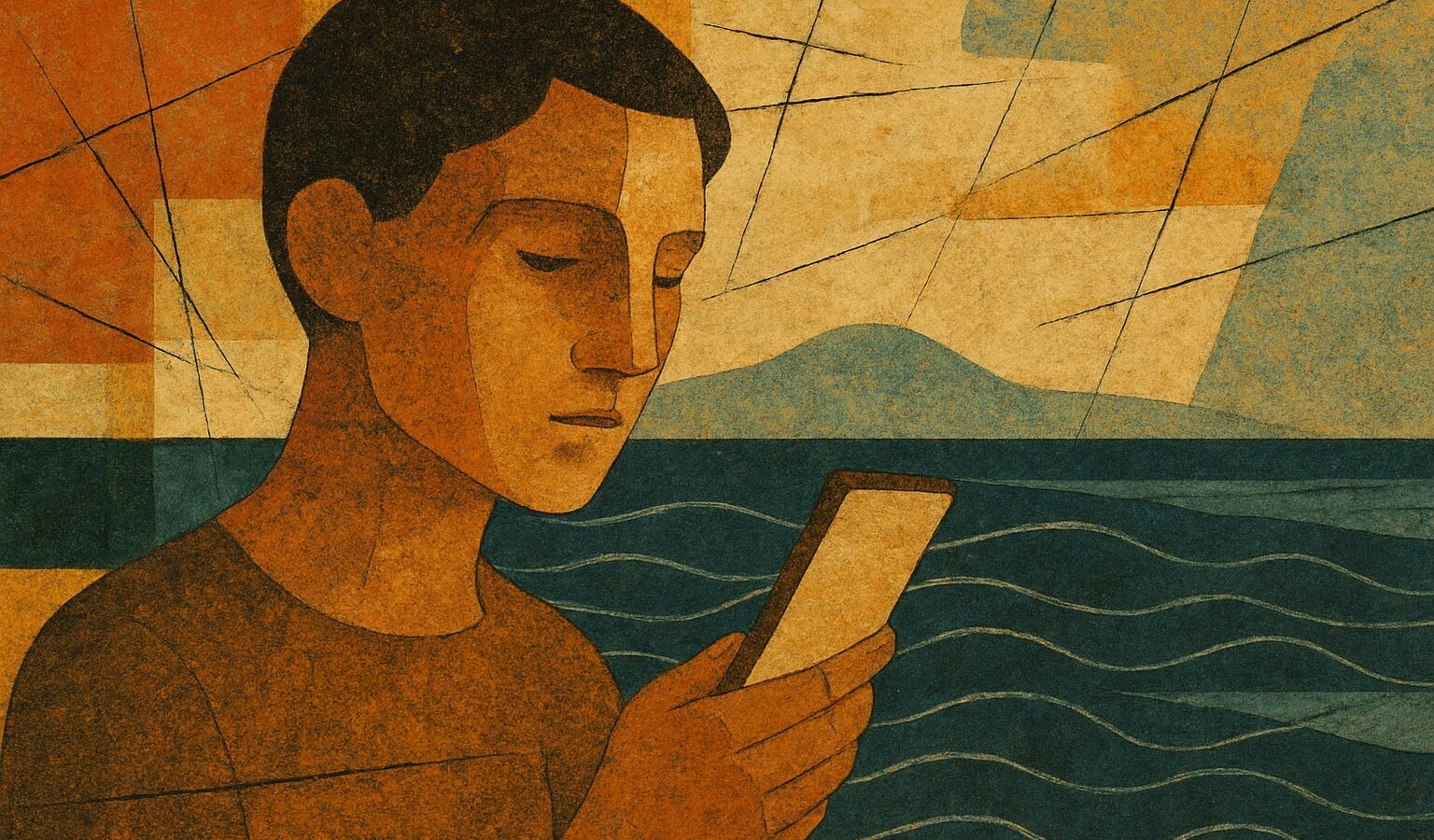
|
|
È raro vedere riconosciuta ai giovani la capacità di gestire il rapido cambiamento antropologico in atto, che porta a vivere il tempo come un eterno presente e lo spazio come una navigazione e non più come un cammino fatto di regole certe1. Eppure, gli argonauti2 digitali – la nuova generazione che ha per bussola lo smartphone – sanno abitare l’era dell’interconnessione, trasformano il deserto delle opportunità in oasi, sono autodidatti, imparano lingue, crescono in società multiculturali e si raccontano attraverso l’esperienza della fotografia e di brevi messaggi. Per loro, la novità è abitare la Rete in modo diverso rispetto alla generazione dei loro genitori3.
È passato mezzo secolo dal 1968. Per paura di perdere il poco che hanno conquistato da soli, i giovani del terzo millennio non rivendicano insieme i loro diritti sociali, ma sono tutt’altro che passivi e defilati. Subiscono lo sfruttamento di lavori malpagati e di affitti proibitivi, tuttavia il loro silenzio è una forma di resilienza, simile a un guscio di protezione. La loro generazione pone interrogativi all’intero sistema educativo e sociale: verso quale meta sono orientati? In quale modo accompagnarli? Quale dialogo è possibile?
La ricchezza che rappresenta la loro età nella società italiana – in termini di idee, vitalità, speranza e progetti – sta purtroppo diminuendo: nel 1991 i giovani fino ai 34 anni erano 26,7 milioni, il 47,1% della popolazione; nel 2017 sono scesi a 20,8 milioni, il 34,3% della popolazione. Che cosa è cambiato e su quali contenuti si possono ritrovare le varie generazioni per camminare insieme e passarsi il testimone?
Sguardi che si incrociano: giovani e adulti
Bisogna riconoscere che l’analisi della situazione dei giovani è in genere condizionata dalla prospettiva dell’adulto. E se i giovani fossero vittima di una narrazione più sbilanciata sulle paure che sulla speranza, più tesa a insegnare che a educare?
Franco Nembrini4 rievoca alcune tesi del mondo antico riguardanti i giovani. Quella di Socrate, datata 470 a.C.: «La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell’autorità e non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono dei tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori. In una parola, sono cattivi». E ancor prima, nel 720 a.C., Esiodo affermava: «Non c’è più alcuna speranza per l’avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile». Infine, dello stesso tenore è un’incisione su un vaso d’argilla babilonese risalente al 3000 a.C.: «Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore. I giovani sono maligni e pigri, non saranno mai come la gioventù di una volta. Quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra cultura».
Piuttosto che sminuire i giovani, i testi citati chiamano in causa la difficoltà ad accogliere il nuovo che avanza, lo scollamento tra genitori e docenti e i limiti del sistema scolastico, che non è più l’unica agenzia pedagogica di riferimento, al fianco della famiglia. Inoltre, invitano a non fermarsi sugli stereotipi, ma a scommettere sulla dimensione educativa, l’unica in grado di formare una civiltà che permetta ai giovani di diventare adulti e di prepararsi per il tempo della responsabilità.
La condizione giovanile, diversa nelle sue istanze storiche, lascia aperta all’età adulta una domanda di senso che non si esaurisce. Lo ribadisce in un suo saggio, in una sorta di esame di coscienza proposto agli adulti, François Gervais: «I giovani hanno bisogno di genitori e si danno loro giochi virtuali. I giovani vogliono comunicare e si dà loro internet. I giovani desiderano imparare e si dà loro un diploma. I giovani rivendicano maggiore libertà e si dà loro un’automobile. I giovani cercano l’amore e si dà loro un preservativo come protezione. I giovani amano pensare e si dà loro un sapere. I giovani sono in cerca di speranza e viene imposta loro la performance. I giovani desiderano scoprire il senso della loro vita e si dà loro una carriera. I giovani sognano la felicità e si danno loro i piaceri del consumismo. I giovani sono complicati? È vero soprattutto quando attraversano quel periodo in cui rivendicano la differenza per aiutarci a non dimenticare mai la nostra gioventù, quel periodo scomodo che noi chiamiamo adolescenza»5.
Si diventa adulti non soltanto per l’anagrafe, ma per scelta. E perché questo avvenga, da «insegnanti» – il cui etimo ricorda un «mettere dentro» – occorre diventare «educatori», e ciò nel senso più alto del termine, del «tirare fuori» risorse, innovazioni e valori. È questo il valore aggiunto delle buone pratiche educative già esistenti in molte famiglie, scuole, oratori, che non omologano i giovani, ma li «lasciano andare».
Ma c’è qualcosa di più, che riguarda la sfera sociale. Per la vita di un giovane sono decisivi la formazione e il lavoro, i crocevia in cui convergono identità e cultura, possibilità concrete e sviluppo della personalità. Da una parte, è vero che non sempre i giovani sono disponibili a svolgere le professioni che le aziende cercano, come quelle di ingegnere, commercialista, fabbro, informatico, saldatore, cuoco, infermiere, esperto di marketing, falegname. Dall’altra parte, essi pagano per corsi di laurea a vicolo cieco e subiscono la svalutazione del costo del lavoro. Il problema della inoccupazione giovanile non si limita all’Italia, ma, per migrare nelle zone europee che cercano manodopera, occorre l’appoggio della scuola, borse lavoro ad hoc e programmi Erasmus di lavoro nell’Ue.
Inoltre, bisogna considerare che scelte di questo tipo porteranno ad altre conseguenze: la domanda di lavoro europea riconfigurerà anche la demografia e aiuterà a rilanciare produzione e produttività; la politica, invece, è chiamata ad agevolare la flessibilità, favorire lo scambio di competenze, permettere ai cittadini di muoversi con più facilità. Diversamente, la precarietà continuerà a spingere i giovani verso forme di lavoro prestato irregolarmente, come quello non protetto, non sicuro e non retribuito, che in molti casi è l’unica chance disponibile. Lo scorso anno, in Italia, i cosiddetti «Neet» – i giovani fra i 18 e i 24 anni che non studiano e non cercano lavoro – erano il 25,7% del totale, mentre la media europea è pari al 14,3%, l’equivalente di 5,5 milioni di ragazzi6.
Tra desideri e realtà
In un recente studio della condizione giovanile elaborato dall’Istituto Toniolo emerge il profilo di un giovane interessato ai grandi temi sociali – come la giustizia, le disuguaglianze, l’ambiente – e disposto a operare per il bene, inteso più come esperienza comune con altri che come fine del proprio agire7. Il «giovane medio» è de-ideologizzato, si concepisce come una monade, ama la solitudine, rimane volentieri nella propria camera, preferisce giocare solo piuttosto che in una squadra. Percepisce che il mondo politico lo considera uno spettatore e non un attore. I pochi che scelgono di impegnarsi, lo fanno grazie all’esperienza del volontariato, che è rimasto l’anticamera più sana per accedere al mondo politico.
La maggior parte dei giovani, però, oltre a essere disillusa, non cresce coltivando una mens politica; i temi pubblici non sono più oggetto di dialogo e di dibattito tra giovani; solo il 10% dei giovani si iscrive al sindacato, mentre 4 giovani su 10 non si sentono rappresentati da alcun partito. I giovani dichiarano di aver votato per il M5S (32%), il centro-destra (46%) e il Pd (32%). La loro disaffezione «provoca una sorta di cortocircuito democratico. I leader politici possono ritenere di non dover rispondere al bisogno di queste categorie, utilizzando i giovani esclusivamente per slogan elettorali. Allo stesso tempo, la politica perde riconoscimento della propria legittimità, non rappresentando più fasce della popolazione che sono il presente e ancor più saranno il futuro del paese»8.
Il linguaggio politico che ha presa sui giovani è quello del racconto e della narrativa, piuttosto che quello dell’argomentazione. Lo storytelling – l’arte di raccontare storie, che utilizza i princìpi della retorica e dell’oratoria, e il suo linguaggio, adottato dal mondo del marketing a partire dagli anni 2000 – è considerato dai giovani il più convincente. Yes we can, America first, Lo mejor está por venir, Le changement c’est maintenant non sono solo slogan, ma incipit di storie che conquistano milioni di giovani. Parole e immagini persuasive, che includono già una visione esistenziale ed emotiva della vita.
È questo aspetto che spesso rende il giovane fruitore e non decodificatore dei messaggi che accoglie: la narrazione di storie-limite, problematiche, rischia di polarizzare il confronto su temi complessi senza dover argomentare o includere soluzioni di mediazione. Se la narrazione diviene l’unico strumento di comunicazione, il soggettivismo rischia di relegare le questioni politiche ed etiche nella sfera personale e privata. Una normatività morale rischia di essere percepita come autoritaria, mentre le narrazioni diventano verità che impediscono alle coscienze di cercare il vero e il bene9.
L’universo narrativo si configura come un esperimento in cui tutto è possibile e dicibile, e la verità non ha peso esistenziale. Anche per questo i giovani sono grati a quei cammini che formano la loro coscienza e forniscono loro un decoder per ascoltare e valutare gli argomenti dei politici, degli intellettuali, dei loro interlocutori. Dei manipolatori dell’opinione pubblica, online e offline.
La vita etica si fonda su esperienze autentiche, non su esperimenti. L’esperienza cambia e fornisce chiavi di lettura alla vita del giovane, mentre l’esperimento, per definizione, può solo essere riprodotto in maniera identica. Compito della generazione adulta è, appunto, quello di favorire esperienze. La formazione politica tradizionale è in ritardo su questo appuntamento: mentre si insiste – troppo – a spiegare un mondo politico che non esiste più, manca la dimensione dell’esperienza.
Il modo di comunicare del giovane nello spazio politico è già un comunicarsi politicamente; la formazione può passare soltanto attraverso la maieutica e l’esperienza, non tramite lezioni frontali. Per i figli della Rete, la fiducia nasce dalle connessioni: è come un grafo che si compone di nodi e di archi e si arricchisce di valore quando ci si collega. Lo afferma anche il fisico Carlo Rovelli: «Pensare il mondo come un insieme di oggetti sembra funzionare sempre meno. Un oggetto esiste come nodo di un insieme di interazioni, di relazioni»10.
È per questo che l’accompagnamento del giovane, per le tradizioni francescana e ignaziana, richiede una formazione continua, personalizzata, con l’aiuto di letture spirituali o studi scelti, esperienze da fare talvolta in mezzo ai poveri – per esempio, in una mensa o in un carcere – e alcuni giorni di preghiera e di silenzio da vivere durante l’anno per avere la possibilità di rileggere la propria vita.
Giovani digitali tra nativi e immigrati
Dire «giovani» oggi non ha un significato univoco: occorre distinguere quelli che sono nati e vivono immersi nel mare della Rete da quelli che vi sono dovuti entrare e nuotano per non affogare. I primi sono i nativi digitali, cresciuti ed educati dalle tecnologie digitali: sono i giovani nati dal 1995 in poi, con la diffusione di massa dei computer a interfaccia grafica e dei sistemi operativi a finestre. I secondi sono definiti «immigrati digitali» per aver dovuto imparare a usare la tecnologia. Si differenziano tra loro per l’approccio mentale che hanno verso le nuove tecnologie: ad esempio, un nativo digitale parlerà della sua nuova macchina fotografica senza definirne la tipologia tecnologica, mentre un immigrato digitale la paragonerà alla macchina fotografica tradizionale con pellicola chimica, e così via.
Per i nativi digitali, l’immersione in Rete è rilevante: in cinque anni essi trascorrono 10.000 ore con i videogames, scambiano almeno 200.000 email, passano 10.000 ore al cellulare, 20.000 ore davanti alla televisione, guardano almeno 500.000 spot pubblicitari, dedicando, però, soltanto 5.000 ore alla lettura11. Questa «dieta mediale» ha prodotto, secondo Marc Prensky, un nuovo linguaggio, un nuovo modo di organizzare il pensiero, che modifica la struttura cerebrale dei nativi digitali. Multitasking, ipertestualità e interattività sono, per Prensky, le principali caratteristiche dei giovani di oggi, che possono contare su un potenziamento digitale e su nuove attività cognitive12.
Qual è la conseguenza di questo cambiamento? I giovani hanno migliori capacità cognitive: la tecnologia digitale integrerebbe la loro memoria attraverso gli strumenti di acquisizione, archiviazione e restituzione dei dati, mentre il potenziamento digitale in ambito cognitivo li renderebbe più competitivi in campi del sapere come la giurisprudenza, la medicina e le discipline umanistiche13.
Occorre poi tener presente un altro elemento antropologico: per i giovani, l’algoritmo e i Big data sono fonti di autorità e rivestono un valore sacrale: sono i nuovi oracoli che essi interrogano per conoscere la verità14. Nella stagione in cui gli algoritmi e le intelligenze artificiali regolano le nostre relazioni, una nuova rivoluzione sta coinvolgendo, soprattutto nella vita dei giovani, il principio di autorità e la comprensione di quali siano le fonti autorevoli.
I sacerdoti che i giovani ascoltano sono i guru dell’high-tech; nella Silicon Valley si va creando una sorta di pseudo-religione universale che legittima una nuova fonte di autorità e ha tutte le componenti dei riti religiosi: dal sacrificio al timore per l’assoluto, fino alla sudditanza a un nuovo motore immobile di aristotelica memoria, che si fa amare ma non ama. Questa nuova fondazione religiosa, la fiducia cieca nella tecnica, la chiamiamo «dataismo», ed è la nuova mitologia del XXI secolo. È questa la dinamica più profonda che trasforma la vita di un giovane.
È noto come nel mondo classico greco e romano fossero i genitori – e talora gli oracoli – a scegliere il destino, anche familiare, dei figli. A partire dall’umanesimo, hanno prevalso i sentimenti. Nella società dataista, sarà l’assistente digitale a scegliere. Non è difficile pensare che si dirà al sistema di intelligenza artificiale: «Hello Marvin, sia Giovanna che Maria mi corteggiano. Mi piacciono entrambe, ma in un modo diverso, è così difficile decidere! Tu conosci tutti i miei dati, cosa mi consigli di fare?». Sarà l’intelligenza artificiale a rispondere: «Beh, io ti conosco dal giorno in cui sei nato. Ho letto tutti i vostri messaggi di posta elettronica, ho registrato le chiamate fatte, i film visti, il tuo DNA e la storia biometrica del tuo cuore. Ho ricostruito le tabelle con livelli di frequenza cardiaca, pressione sanguigna e zuccheri di ogni appuntamento che hai avuto con Giovanna e con Maria. Sulla base di queste informazioni, degli algoritmi e delle statistiche di milioni di coppie di questi ultimi anni, ti consiglio di scegliere Giovanna, con cui avrai una probabilità dell’87% di essere più soddisfatto»15. Il dataismo si fonda su questo nuovo fidarsi e affidarsi.
La stagione del digitale cambia l’intero lessico religioso e genera nuove credenze negli argonauti digitali. È soprattutto la fantascienza – in particolare quella distribuita dalle grandi piattaforme di streaming internazionale – ad assumere il ruolo di mito fondativo di questo nuovo credo. La religione degli argonauti digitali non richiede alcuna storia, perché è basata sui dati. Non ha bisogno della Provvidenza, perché a tutto provvede l’algoritmo. Non chiede di amare, perché saranno i calcoli a indicare l’anima gemella. Cambia, per questi nuovi naviganti, anche l’escatologia, perché il regno dei cieli rischia di essere confuso con il cloud, il (nuovo) cielo dove, grazie a un mind-uploading16, si potranno vivere esistenze infinite.
Podcast | SIRIA. «LA SITUAZIONE ECONOMICA È CATASTROFICA»
Le incognite sul futuro di milioni di rifugiati, le città devastate da anni di guerra e una pace ancora fragile. A raccontarci da Damasco come sta vivendo questo momento di incertezza la popolazione siriana è p. Vincent de Beaucoudrey S.I., direttore del Jesuit Refugee Service in Siria.
La cura delle relazioni «onlife»
Gli argonauti digitali sembrano essere figli di una nuova rivoluzione copernicana. Secondo Luciano Floridi, professore di Filosofia e di Etica dell’informazione all’Università di Oxford e direttore di ricerca all’Oxford Internet Institute, tre rivoluzioni hanno cambiato la nostra visione del mondo e la nostra autocomprensione: la rivoluzione copernicana, la teoria di Darwin sulla selezione naturale e la pretesa di Freud che le nostre azioni quotidiane siano controllate dalla mente inconscia.
Floridi ritiene che siamo di fronte a una quarta rivoluzione: quello che facciamo online e offline si fonde con la nostra vita fisica. La nostra società diventa sempre più una fusione di esperienze fisiche e virtuali: stiamo acquisendo una «personalità onlife», un insieme di online e offline. I giovani sono alla frontiera di questo processo. Gli argonauti digitali vivono relazioni onlife mediate da smartphones e altri devices che lavorano sui dati prodotti da loro stessi. La gratuità dei servizi dei social network, motori di ricerca, sistemi di chat che i giovani utilizzano, rischia di trasformarli in prodotti di mercato che li profila fino a prevederne il comportamento.
Se la grande tradizione del passato, a partire da Socrate, invitava a «conoscere se stessi», ora il nuovo Socrate chiede di conoscere i propri dati, ciò che i gadget digitali trasformano di noi in dati, come i battiti del cuore, la pressione arteriosa, i gusti e le preferenze, e così via. Sono questi i dati elaborati dagli algoritmi che profilano identità e comportamenti. Con Yuval Noah Harari17, possiamo chiederci: «Gli organismi sono davvero soltanto algoritmi, e la vita è davvero soltanto elaborazione dati?». «Che cos’è più importante: l’intelligenza o la consapevolezza?». «Che cosa accadrà alla società, alla politica e alla vita quotidiana quando algoritmi non coscienti ma dotati di grande intelligenza ci conosceranno più a fondo di quanto noi conosciamo noi stessi?». C’è poi una domanda radicale, dalla quale è possibile ripartire: «Che cosa significa non essere schiavi e vivere nella libertà e nella responsabilità verso gli altri?». È questa la questione più delicata, di cui si preoccupa la spiritualità e che riguarda la convivenza civile, sempre più condizionata dalla custodia dei dati e dalla loro proprietà18.
* * *
Il Sinodo sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», in programma dal 3 al 28 ottobre prossimi, ha assunto questi cambiamenti antropologici per aiutare i giovani a vivere la loro vocazione nel mondo e il loro rapporto con il Signore Gesù19. La Chiesa conosce la loro nostalgia di Dio e la loro critica ai linguaggi, ai segni e ai riti. È vero: il giovane tende a dichiararsi incredulo, ma non è polemico. Se si professa credente e la sua fede è solitaria e anonima, può tendere a non mostrarla, ma ricorda la comunità della sua chiesa di origine e le preghiere imparate da piccolo. È diffidente verso la Chiesa intesa come istituzione, ma affascinato dagli uomini e le donne di Chiesa che costruiscono pace, si occupano di giustizia e di ambiente, comunicano semplicemente e danno speranza ai loro giorni. «Quando arrivano i momenti della crisi, quando la vita chiede di prendere posizione davanti alle sue sfide, allora ciascuno pesca nel proprio patrimonio religioso ciò che gli serve, con un’operazione selettiva che, alla lunga, configura esperienze religiose soggettive, emotive, estemporanee»20.
Alla Chiesa i giovani chiedono un upgrade, un aggiornamento che parli alla loro ricerca di fede, tocchi il loro linguaggio e le loro nuove pratiche, li sfidi a creare un nuovo senso di appartenenza comunitario che includa e non si esaurisca in quello che essi sperimentano in Rete. C’è infatti qualcosa in più. «Rispetto al passato, dobbiamo abituarci a percorsi di avvicinamento alla fede sempre meno standardizzati e più attenti alle caratteristiche personali di ciascuno»21, afferma il Documento preparatorio al Sinodo sui giovani. Lo ribadisce anche l’Instrumentum laboris attraversotre parole chiave: riconoscere, interpretare, scegliere22.
La sfida pastorale è quella di accompagnare il giovane alla ricerca dell’autonomia, che rimanda alla scoperta della legge interiore e della chiamata di Dio, per differenziarlo dal «gregge social» a cui si appartiene.
Una seconda sfida è quella di presentare al giovane argonauta – spesso ipnotizzato dall’autorità degli influencer e dai suoi follower virtuali – figure autorevoli che attraverso l’accompagnamento lo portino a riscoprire il proprio progetto personale di vita. Questo cammino richiede di passare dalla solitudine, nutrita dai likes, alla realizzazione di progetti personali e sociali da realizzare in comunità.
La «pastorale di senso» è quella capace di procedere dall’informazione religiosa a quella dell’accompagnamento e dell’esperienza di Dio. Anche nelle comunità cristiane, per esorcizzare le incomprensioni e le paure del mondo adulto nei confronti della Rete occorre che i giovani insegnino i nuovi linguaggi e il loro modo di relazionarsi.
Per la spiritualità francescana, il mondo social dell’argonauta è la fraternitas, il luogo in cui l’esperienza di Dio si fa comunione e condivisione del vissuto; per la spiritualità ignaziana, è la «contemplazione nell’azione», che permette di discernere il gusto del reale – che include la vita buona in Rete – dalla bulimia del virtuale.
La sfida è nota alla coscienza ecclesiale e rimane quella di inculturarsi prima e di evangelizzare poi i giovani del continente digitale, per aiutarli a non confondere i mezzi con il fine, a discernere come navigare in Rete, in modo da crescere come soggetti e non come oggetti, e andare oltre la tecnica per ritrovare un’umanità rinnovata nella relazione con Cristo. È dalla virtù della speranza che nasce la consapevolezza che «le radici profonde non gelano mai», anche se i tempi cambiano rapidamente.
Copyright © La Civiltà Cattolica 2013
Riproduzione riservata
***
1. Cfr F. Occhetta – P. Benanti, «La politica di fronte alle sfide del postumano», in Civ. Catt. 2015 I 572-584.
2. Nella mitologia greca, gli Argonauti erano un gruppo di 50 eroi che, guidati da Giasone, navigarono a bordo della nave Argo, diretti verso le terre della Colchide, per conquistare il vello d’oro di un ariete mandato dal cielo.
3. Cfr A. Romeo, Posto, taggo, dunque sono? Nuovi rituali e appartenenze digitali, Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis, 2017; P. Bignardi – E. Marta – S. Alfieri, Generazione Z. Guardare il mondo con fiducia e speranza, Milano, Vita e Pensiero, 2018.
4. F. Nembrini, «Come è difficile essere padri», conferenza al Centro Culturale di Milano, 1° aprile 2014, in www.centroculturaledimilano.it/ Cfr Id., Di padre in figlio. Conversazioni sul rischio di educare, Milano, Ares, 2017.
5. F. Gervais, Il piccolo saggio. Parole per maturare, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 2014.
6. Fonte Eurostat.
7. Cfr Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2018, Bologna, il Mulino, 2018.
8. Ivi.
9. Cfr F. Occhetta, «Tempo di post-verità o di post-coscienza?», in Civ. Catt. 2017 II 215-223.
10. C. Rovelli, Ogni cosa è informata, 20 marzo 2014, in www.ilsole24ore.com/ Si veda anche L. Floridi, La rivoluzione dell’informazione,Torino, Codice, 2012.
11. Cfr M. Prensky, «Digital Natives, Digital Immigrants», in The Horizon 9/5 (2001) 1-6, in www.scribd.com/ Id., «Digital Natives, Digital Immigrants, part 2: Do They Really Think Differently?», in The Horizon 9/6 (2001) 1-6, in www.twitchspeed.com
12. Cfr Id., «H. Sapiens Digital: From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom», in Innovate 5/3 (2009), in http://www.innovateonline.info/index
13. Prensky preferisce parlare di «potenziamento digitale» piuttosto che di «potenziamento tecnologico», per tre motivi. Anzitutto, perché quasi tutta la tecnologia è digitale o supportata da strumenti digitali. In secondo luogo, perché la tecnologia digitale si distingue dalle altre in quanto è programmabile, capace di essere indotta a fare proprio ciò che si desidera a livelli sempre più precisi. In terzo luogo, perché la tecnologia digitale investe continuamente energie in versioni sempre più piccole di microprocessori, che costituiscono il nucleo di buona parte della tecnologia capace di potenziare la cognizione.
14. Cfr P. Benanti, Oracoli. Tra algoretica e algocrazia, Roma, Sossela, 2018, 48-53.
15. Ivi, 52 s.
16. Il trasferimento della mente o mind-uploading («caricamento della mente») o emulazione del cervello è l’ipotetico processo del trasferimento, o della copia, di una mente cosciente da un cervello a un substrato non biologico.
17. Cfr Y. N. Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro, Milano, Bompiani, 2017, nelle conclusioni.
18. Su questo argomento, cfr M. Kelly – P. Twoney, «I “Big data” e le sfide etiche», in Civ. Catt. 2018 II 446-459.
19. Per approfondire, cfr D. Fares, «Io sono una missione, verso il Sinodo dei giovani», in Civ. Catt. 2018 I 417-431; J. Mesa, «Educazione cattolica, fede e discernimento vocazionale», ivi 2018 II 343-355. Sono alcuni degli articoli della nostra rivista raccolti nel volume monografico della collana «Accènti», dal titolo Giovani, disponibile sul sito www.laciviltacattolica.it
20. P. Bignardi, «Giovani e comunità cristiana: ristabilire la comunicazione», in Avvenire, 26 maggio 2018, 3. Cfr Id., «I giovani tra incredulità e (nuovo) fascino della fede», ivi, 24 maggio 2018, 1-3.
21. XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Documento preparatorio, in www.vatican.va
22. «“Instrumentum laboris” della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi», 19 giugno 2018, in www.synod2018.va/content/synod2018/it.html