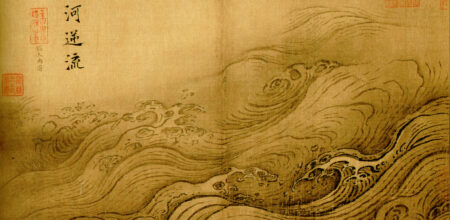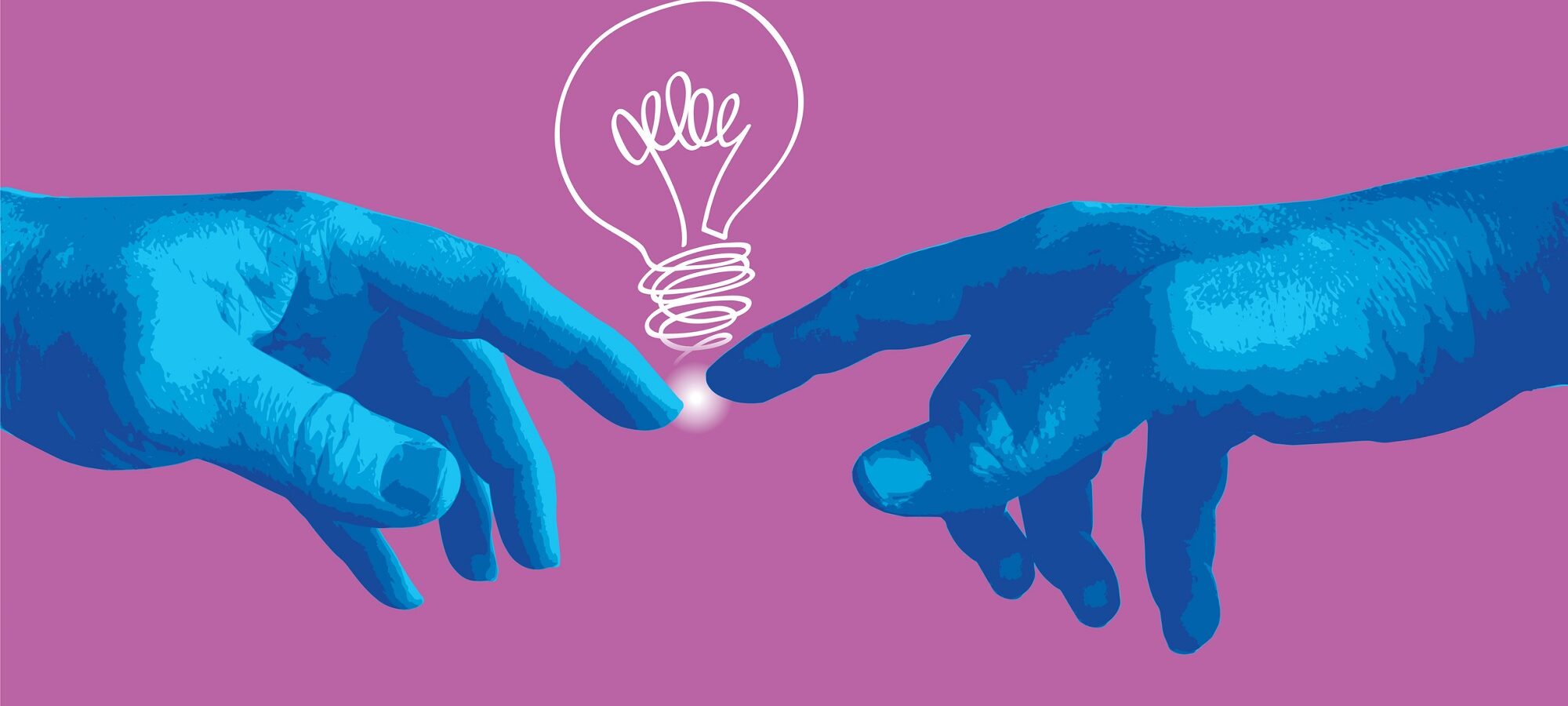
|
|
Negli ultimi quarant’anni, la ricerca scientifica sulla comunicazione ha accordato un’attenzione sempre maggiore alla religione. All’origine dei primi studi in questo settore, che risalgono agli anni Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti, si trovava il fenomeno della «chiesa elettronica» (o telepredicazione), in forte crescita da quando la disponibilità sempre più ampia di canali televisivi via cavo aveva indotto molti predicatori evangelici a rivolgersi a tale strumento per offrire i propri servizi religiosi. Ma di fatto le Chiese cristiane, così come altri gruppi religiosi, avevano abbracciato quegli strumenti di comunicazione fin dal loro sorgere: negli anni Trenta la Bbc e altre emittenti nazionali producevano programmi religiosi domenicali; il Vaticano lanciò la Radio Vaticana sotto la supervisione di Guglielmo Marconi; la Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti chiedeva alle emittenti di concedere spazi gratuiti alle Chiese; predicatori come il vescovo Fulton Sheen e Dwight Moody contavano ascoltatori dappertutto negli Stati Uniti. Eppure tutti questi sintomi di vitalità avevano attirato scarso interesse da parte di coloro che si dedicavano al settore, ancora nascente, della ricerca sulla comunicazione.
Con l’avvento della «chiesa elettronica» le cose sono cambiate. Si è risvegliato un interesse che possiamo spiegare in base a diversi fattori. In primo luogo, un movimento religioso piuttosto controverso – poco in sintonia con i principali gruppi religiosi negli Stati Uniti, al punto che molti lo guardavano con diffidenza – ha assunto un ruolo pubblico preminente nel mondo dell’intrattenimento e in quello della politica. In secondo luogo, l’area accademica degli studi sulla comunicazione ha scorto un campo di ricerca prioritario nell’audience, nella modalità di apprezzamento da parte del pubblico. In terzo luogo, gli approfondimenti in questo settore hanno potuto contare sull’incoraggiamento e sul finanziamento sia di Chiese tradizionali, interessate all’opportunità di svolgere il loro ministero tramite tali canali, sia di una tradizione di ricerca americana che cercava di allargare a nuove fasce di pubblico le proprie indagini su propaganda e motivazione. Infine, alcuni autori hanno contribuito a creare studi e gruppi di ricerca che hanno prodotto pubblicazioni sulla «chiesa elettronica» (Robert Abelman, Stewart Hoover, Peter Horsfield), sul giornalismo religioso (Mark Silk, Yoel Cohen), sul pubblico religioso giovanile (Lynn Schofield Clark) e sulla religione online (Chris Helland)[1].
I ricercatori, per lo più giovani, hanno dato vita a varie associazioni accademiche, fra cui la National Communication Association e l’International Association for Mass Communication Research, che offrono supporto organizzativo ai gruppi di interesse. Nel corso del tempo numerosi studiosi hanno creato altre reti istituzionali di sostegno per i ricercatori. Per esempio, Stewart Hoover, della University of Colorado Boulder, ha fondato il Center for Media, Religion and Culture; Jolyon Mitchell, dell’Università di Edimburgo, ha diretto il Center for Theology and Public Issues; e, più recentemente, Heidi Campbell, della Texas A & M University, ha fondato il network per i nuovi media Religion and Digital Culture Studies[2].
Le prospettive di studio su religione e comunicazione vertono su tre principali ambiti di interesse: 1) l’attività comunicativa prodotta dai gruppi religiosi; 2) i gruppi e i professionisti della comunicazione che si esprimono in tema di religione; 3) i modi per classificare la conoscenza sulla comunicazione religiosa.
Religioni che comunicano
In primo luogo, nello studio su comunicazione e religione rientra l’operato dei gruppi religiosi, tradotto in dichiarazioni d’intenti, documenti politici, valutazione degli sforzi comunicativi e in ogni produzione di questo genere. Nel corso del XX secolo molte Chiese e autorità religiose hanno espresso dichiarazioni in tema di comunicazione, che vanno dalla condanna di determinati contenuti a una cauta approvazione dell’uso dei media. Tra i gruppi più prolifici ricordiamo la Chiesa cattolica, autrice di ricorrenti dichiarazioni in materia (encicliche papali, messaggi per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, documenti del Pontificio Consiglio per la comunicazione sociale, dichiarazioni di Conferenze episcopali o di Istituti religiosi); varie Comunità protestanti e organizzazioni religiose, come l’Associazione mondiale per la comunicazione cristiana; rabbini che formulano opinioni sull’uso della comunicazione; imam che pronunciano giudizi su tali argomenti.
I gruppi religiosi inoltre si sono dati regole in merito, attraverso dichiarazioni che disciplinano il modo in cui gli esponenti di una determinata istituzione possono o devono utilizzare i mezzi di comunicazione. Spesso hanno cercato nella loro visione teologica l’ispirazione per individuare la modalità comunicativa più adatta alla loro specifica concezione di Dio e del mondo. In una religione come il cristianesimo che ha il compito di proclamare il Vangelo fino ai confini della terra, molte Chiese fondano in Mt 28,19-20 la giustificazione per l’uso dei media. Invece, altri gruppi religiosi, come l’islam, pongono restrizioni all’impiego della comunicazione (in particolare riguardo alle immagini), basandole sulla loro lettura del Corano e di vari hadith del Profeta. Anche l’ebraismo pone limiti all’uso delle immagini. Diversa invece è la posizione dell’induismo. Infatti, nel cinema indiano – che non risponde ad alcuna autorità religiosa – s’incontra una serie di film devozionali dedicati al pantheon indù, che evocano risposte religiose anche nelle sale cinematografiche. La ricerca sulla comunicazione ha seguìto e studiato questi materiali, esaminando le posizioni teologiche dei diversi gruppi religiosi per comprenderne meglio gli atteggiamenti nei confronti della comunicazione, ma anche la disponibilità a utilizzare media diversi al servizio degli scopi che si propongono di perseguire.
La religione costituisce un’area di studio molto ampia, e i ricercatori hanno avuto modo di spaziare anche nelle religioni non cristiane, e di indagarne le pratiche comunicative quali si riscontrano nell’ebraismo, nell’islam, nell’induismo, nel confucianesimo, nelle religioni tradizionali africane e così via. Alcuni studi comparativi utilizzano le pratiche contrastanti dei gruppi religiosi come una via per comprendere i loro diversi atteggiamenti nei confronti della comunicazione.
All’interno di ciascun gruppo, la ricerca si concentra generalmente su media specifici. Il cristianesimo, per esempio, si è avvalso di quasi tutti i mezzi di comunicazione: la scrittura, la parola orale, la predicazione, l’arte, la musica, la radio, la televisione, i film e i social media, e questo implica che lo studio richiede un determinato approccio per ogni singolo mezzo di comunicazione. L’ampio uso della comunicazione è invalso anche presso altri gruppi religiosi che adottano i più recenti media digitali (ad esempio, il web) in percentuale crescente e con espressioni simili tra loro. In alcuni campi, gli studi su particolari mezzi di comunicazione si sovrappongono ad altre aree accademiche: è il caso, per esempio, della storia dell’arte (quando si esamina l’espressione religiosa), della retorica (nel confronto tra persuasione e istruzione religiosa) e degli studi sui riti e della musicologia. Non mancano certamente approcci più tipici, come quelli che esaminano la storia dei giornali religiosi o le caratteristiche del pubblico religioso che utilizza i media.
Altri ricercatori studiano le strategie impiegate da gruppi religiosi e Chiese per creare la propria specifica attività di comunicazione. Per esempio, diversi autori si impegnano nello studio, oltre che della telepredicazione, anche di altre forme di divulgazione religiosa. Molti sponsorizzano programmi radiofonici, televisivi o audio e video online. Alcuni hanno prodotto proprie iniziative nel cinema o hanno cercato di influenzare l’industria della comunicazione attraverso festival e premi. Ci sono gruppi religiosi che praticano le pubbliche relazioni e la pubblicità, talvolta finalizzate alla raccolta di fondi per cause particolari, altre volte per attività di evangelizzazione. Per esempio, alcune diocesi della Chiesa cattolica negli Stati Uniti hanno condotto campagne pubblicitarie, in occasione delle festività, per invitare le persone a frequentare le chiese nelle ricorrenze religiose. Nel recente passato, molti gruppi religiosi hanno esteso la propria presenza online a tutto il suo arco espressivo: pagine web di istituzioni, Confessioni o Chiese locali; produzione di filmati in formato digitale; pagine informative; guide alla spiritualità; podcast e così via.
Un’area più specialistica riguarda la categoria della comunicazione di crisi. Talvolta i gruppi religiosi si trovano al centro di dibattiti pubblici suscitati da un evento che li ha coinvolti. L’esempio più noto e più triste è quello degli abusi sui minori. Gli studiosi di comunicazione hanno esaminato il modo in cui diversi di questi gruppi utilizzano tali strategie comunicative e in quali tipi di media, sia confrontando casi diversi sia inserendoli in un contesto teoretico.
Si è analizzata anche l’attenzione che i gruppi religiosi dedicano alla comunicazione interpersonale, ossia a quegli impegni che vengono abitualmente classificati come forme di ministero pastorale e di educazione. Nel primo caso rientrano la consulenza religiosa, il conforto, la direzione spirituale, le visite pastorali e la sensibilizzazione sociale. Il secondo caso si esplica nell’educazione religiosa, impartita sia nel catechismo per bambini sia nelle attività rivolte ad adulti.
Gli studiosi identificano ulteriori modi in cui le persone sperimentano la comunicazione nel contesto religioso: come espressioni di pietà o come socializzazione nell’ambito di un’identità religiosa. Sebbene questo genere di modalità comunicative tradizionalmente sia avvenuto in contesti interpersonali o di gruppo, i ricercatori hanno notato che attualmente prevale sempre più l’esperienza mediata attraverso chat room online, video di YouTube e gruppi nei social media. Questi ambiti vengono esaminati secondo prospettive diverse, ma gli scienziati della comunicazione riscontrano che le attività di pietà e di socializzazione religiosa si verificano in quasi tutte le tradizioni religiose. Si trovano peraltro espressioni tra loro molto diverse, e quindi lo studio si estende ad attività di pellegrinaggio, a luoghi di culto e persino a parchi a tema religioso.
Il caso di studio più noto è quello dell’evangelizzazione televisiva, a cui abbiamo accennato all’inizio. I termini televangelist e televangelism sono entrati nella lingua inglese negli anni Settanta (e da lì sono passati ad altre lingue) come parole che combinano «televisione» ed «evangelismo», allo scopo di fornire una descrizione appropriata della programmazione televisiva basata su servizi religiosi. Attualmente essi costituiscono un termine generico per quasi tutte le trasmissioni religiose. Gli storici della comunicazione hanno seguìto l’evolversi di questo format religioso, che ha finito per trovare ampia diffusione nel mondo e in diversi gruppi. A partire dagli Stati Uniti, la tipologia del telepredicatore si è diffusa – dall’originario stile degli «incontri di risveglio» adottati dai gruppi cristiani evangelici fino ad altre tradizioni cristiane – nell’America centrale e meridionale, perché le Chiese statunitensi dapprima hanno tradotto la loro programmazione in spagnolo e poi hanno formato il clero locale per questo tipo di ministero.
Oggi questo modello è ampiamente diffuso negli Stati Uniti, in Centro America, in Brasile e in Africa, soprattutto tra le Chiese evangeliche e pentecostali, guidate da un ministro carismatico, accompagnato da coristi e danzatori. Lo hanno ripreso diversi predicatori islamici, ispirandosi a volte direttamente ai programmi cristiani. I primi telepredicatori islamici hanno operato in Egitto, poi in diverse parti dell’Africa e in seguito sono approdati negli Stati Uniti e in Inghilterra, con l’aiuto della diffusione online, che ha permesso loro di raggiungere le comunità islamiche in tutto il mondo, anche nei luoghi in cui i governi o l’economia limitavano l’accesso alle trasmissioni. I gruppi islamici sembravano particolarmente predisposti a tale prassi, che poteva considerarsi lo sviluppo di una forma già esistente di predicazione islamica, ossia quella registrata e poi diffusa per mezzo di audiocassette.
Troviamo telepredicatori anche nell’ebraismo, e le loro trasmissioni vengono diffuse sia tramite la televisione via cavo sia tramite canali internet. Allo stesso modo, nell’induismo si conta un numero crescente di predicatori che uniscono vari aspetti della pratica indù con insegnamenti e intrattenimento. In generale, tutte queste varie pratiche di evangelizzazione televisiva presentano caratteristiche simili, che amalgamano in varia misura. Tra esse, la predicazione, la musica religiosa, l’istruzione, l’espressione liturgica, le testimonianze personali, l’intrattenimento (che può assumere la forma di interviste nei talk show, di umorismo o di drammi religiosi), la preghiera, e spesso la raccolta di fondi.
Gruppi esterni che comunicano sulla religione
Assieme allo studio delle pratiche di comunicazione instaurate da gruppi religiosi, un’altra componente della ricerca su comunicazione e religione riguarda i modi in cui quest’ultima appare nei media, cioè come viene vista da gruppi esterni. Dalla constatazione che per giornali e telegiornali la religione costituisce un incessante serbatoio di notizie è scaturita una grande attenzione a essa nel settore accademico. In molti casi, giornalisti specializzati in religione fanno luce sulle attività di Chiese e personaggi religiosi, utilizzando come fonti anche alcuni leader spirituali, tra cui il Papa, il Patriarca greco-ortodosso di Costantinopoli, l’Ayatollah dell’Iran, il Dalai Lama e altre personalità di spicco del cristianesimo, dell’ebraismo, dell’islam e dell’induismo. I giornalisti danno anche conto della persecuzione religiosa in molte parti del mondo. Gli studiosi si concentrano sulla presentazione delle notizie religiose da parte delle testate giornalistiche, sulle possibili fonti di pregiudizi e sul ventaglio degli argomenti presentati.
Anche la programmazione di intrattenimento contiene una grande quantità di contenuti religiosi. Alcune trasmissioni si concentrano specificamente sulla religione, per raccontare la storia di un personaggio religioso o di persone che affrontano problemi religiosi. I materiali più studiati a tale riguardo sono i film. Gli studiosi hanno suddiviso il cinema religioso secondo le loro prospettive di indagine: film che rinviano all’esperienza religiosa, film che suggeriscono un’interpretazione religiosa, film su Cristo (quelli in cui il protagonista interpreta la vita di Cristo), film demoniaci che affrontano il diffondersi del male, film che narrano una ricerca di senso, film che offrono uno spaccato dell’orientamento religioso della società e così via. All’interno di questi studi sul cinema, un’area più specializzata esamina i documentari dedicati ad argomenti religiosi. Un numero minore di studi sulla religione nel cinema affronta temi non cristiani.
Altri programmi di intrattenimento – riguardanti cinema, televisione o media online – che hanno richiamato l’attenzione degli studiosi della comunicazione presentano la religione in un mero ruolo di supporto delle loro storie. In tale contesto, essa fa da sfondo ad altre attività: per esempio, personaggi che si sposano in una chiesa, ebrei che osservano la seduta di shiva (il lutto) per un membro della famiglia morto, o persone intente a una puja (adorazione) in un tempio indù. Tenuto conto dell’ampia portata della religione e della crescente diversificazione delle società e del mondo dello spettacolo, gli studiosi della comunicazione spesso confrontano il modo in cui i vari media descrivono i diversi gruppi religiosi o anche non religiosi. Un’area relativamente nuova riguarda l’ateismo, e alcune ricerche analizzano anche il modo in cui gli atei presentano sé stessi, principalmente sui siti web e nei canali online.
Podcast | SIRIA. «LA SITUAZIONE ECONOMICA È CATASTROFICA»
Le incognite sul futuro di milioni di rifugiati, le città devastate da anni di guerra e una pace ancora fragile. A raccontarci da Damasco come sta vivendo questo momento di incertezza la popolazione siriana è p. Vincent de Beaucoudrey S.I., direttore del Jesuit Refugee Service in Siria.
Numerosi studi esaminano come la religione viene presentata dalle emittenti statali. Molti Paesi proprietari di canali di servizio pubblico, o dove sono attive stazioni di diffusione incaricate di svolgerlo, producono trasmissioni religiose radiotelevisive. Sebbene pochi programmi in Occidente presentino funzioni religiose, molte emittenti occidentali del servizio pubblico offrono una rubrica domenicale che può proporre cerimonie, dibattiti religiosi o anche documentari su gruppi religiosi in un determinato Paese. Negli Stati a maggioranza religiosa, in particolare nel mondo islamico, l’emittente pubblica può trasmettere programmi di preghiere.
Il rapporto tra i media e la religione può comportare vari gradi di complessità. Recenti studi sulla comunicazione hanno proposto concreti modelli teorici dell’interazione tra i media e altre istituzioni e attività sociali. Una teoria abbastanza consolidata – quella della mediatizzazione – sostiene che le persone percepiscono la realtà e le istituzioni sociali attraverso i media (originariamente i media radiotelevisivi, ma oggi più spesso i social media). Nella prospettiva delle industrie della comunicazione, la religione appare come una componente sociale che compete con altre per conquistarsi l’attenzione della gente e, allo stesso tempo, altre istituzioni sociali cominciano ad assumere le funzioni sociologiche della religione mediatizzata.
Oltre alla radiodiffusione e ai social media, vengono prese in considerazione altre forme di pratica religiosa: per esempio, attività rituali, pellegrinaggi o feste. Ognuna di esse comporta molteplici tipi di comunicazione, e come tale è divenuta oggetto di interesse per gli studiosi. Alcuni di essi hanno esaminato argomenti più specialistici, fra cui la creazione di senso da parte delle persone religiose, o la maniera in cui esse comunicano e sviluppano la loro spiritualità, in particolare di fronte alla morte: ogni gruppo religioso si confronta con tale esperienza, ma la comunica in modi diversi.
Parimenti, ogni gruppo si confronta con dimensioni religiose materiali. Questa area di studio, in fase di espansione, esamina gli aspetti concreti della pratica religiosa, vale a dire come essa si manifesta tramite oggetti o luoghi particolari. Molte persone li trovano in aree specificamente dedicate ad essi, come chiese o templi, o li tengono a casa in cappelline o in angoli di preghiera, ma sono sempre più numerosi i musei che raccolgono ed espongono oggetti religiosi. Gli studiosi della comunicazione hanno iniziato a riflettere sullo status di tali oggetti, che talvolta sono strumenti di pratica religiosa attiva, ma altre volte hanno perduto la loro funzione originaria e sono diventati materiale di esposizione nei musei o di studio. Assieme agli operatori museali, essi hanno aperto un dibattito su quali siano gli obblighi dei curatori dei musei nei confronti di tali oggetti: sono tenuti a preservarne il carattere religioso?
Le categorie della ricerca sulla comunicazione applicate alla religione
In terzo luogo, gli studiosi esaminano religione e comunicazione dalla prospettiva di categorie già istituite in precedenza, osservando soggetti diversi. In concreto, l’audience e le attività dell’audience, ossia il punto di vista dei destinatari, costituiscono un classico approccio degli studi sulla comunicazione. Ci si pone allora una serie di domande: da chi è composto il pubblico della comunicazione religiosa? Spesso esso è composto dai telespettatori più anziani e da coloro che sviluppano una relazione sociale con un determinato personaggio religioso. Quali sono le caratteristiche dei componenti del pubblico, in particolare di coloro che, per esempio, preferiscono la telepredicazione ad altri programmi? A volte sono coloro che ritengono la programmazione religiosa meno discutibile rispetto ad altre espressioni mediatiche. Essi guardano la televisione religiosa con una certa apertura anche alle altre tradizioni religiose. Perché le persone scelgono di assistere alle funzioni religiose da casa piuttosto che intervenire di persona? Spesso per motivi di salute o di mobilità, ma altrettanto spesso per comodità. Perché le persone scelgono la religione online? A volte per la diversità di opinioni che vi trovano; a volte perché possono contribuire ai dibattiti in rete; a volte perché sono più libere da vincoli istituzionali. E all’interno della comunicazione religiosa, tra i pubblici di media diversi, come televisione, radio, stampa, online, ci sono differenze? Un’altra domanda che è emersa durante il periodo del Covid-19 riguarda la decisione se tornare o meno a partecipare di persona alle funzioni religiose.
Nella misura in cui lo studio della comunicazione è diventato più sensibile a temi come etnia e sessualità, questi stessi argomenti sono entrati nelle ricerche specificamente dedicate all’ambito religioso. I gruppi religiosi, com’è ovvio, custodiscono insegnamenti che dovrebbero orientare le persone sulla sessualità, ma le persone, a loro volta, manifestano le proprie convinzioni. Come vengono comunicati tali aspetti? Ponendosi nella prospettiva della critica della comunicazione, i ricercatori si interrogano anche sul tema dei pregiudizi all’interno delle religioni e dei gruppi religiosi, ossia sui processi di accettazione o di rifiuto che questi generano all’interno delle pratiche e sulle iniziative che si adottano, rispettivamente, per favorirli o per contrastarli. Questi temi, che molti considerano influenzati da prospettive culturali, toccano in qualche modo l’autorità che è connaturata alla comunicazione religiosa. Ogni gruppo religioso individua una fonte di insegnamento autorevole, attribuendole diversi tipi di potere. Questo a sua volta influisce sulla sua comunicazione e su coloro a cui è permesso di pronunciarsi o di parlare a nome del gruppo religioso.
Oltre a questi approcci più specialistici, gli studiosi hanno applicato alla comunicazione religiosa anche norme etiche non religiose. Tali studi etici sulla comunicazione religiosa attingono a una logica diversa da quella teologica, che si radica nell’etica filosofica, ma spesso anche nelle tradizioni etiche dell’Occidente. Gli approcci etici indipendenti pongono alla religione sfide interessanti. La maggior parte dei gruppi religiosi, quando desidera rivolgersi a un pubblico esterno su argomenti che non riguardano esplicitamente la propria appartenenza, basa la propria autorevolezza mediatica su temi etici. Questo atteggiamento solleva ancora una volta la questione, venuta alla ribalta negli ultimi 10 anni e declinata in termini di etnia e di sessualità: con quale autorità i gruppi religiosi si rivolgono al mondo? Essi possono pronunciarsi autorevolmente riguardo a pratiche comunicative, se parlano solo a nome delle proprie tradizioni? In che modo le pratiche di comunicazione influenzano la percezione dell’autorità dei gruppi religiosi? La mediatizzazione della comunicazione non attribuisce l’autorità nel mondo dei media alla religione, bensì agli stessi custodi dei media. E che cosa costituisce l’autorità in un mondo in cui l’apparire mediatico, in quanto tale, sembra conferire legittimità?
Molte di queste domande hanno ricevuto nuova forza con la comparsa della religione nella rete digitale. La natura del mondo online ha ridotto le barriere e i costi di accesso e ha dilatato la portata dei materiali, dei produttori di contenuti e dei pubblici. Ha anche consentito alle persone di cercare le informazioni che più le attraggono, senza alcun tipo di guida o di controllo. Sebbene i gruppi religiosi producano propri contenuti sul web, la «qualità della produzione» oscilla e potrebbe non piacere agli utenti occasionali.
Alcuni ricercatori, seguendo Christopher Helland, operano una distinzione tra online religion e religion online: la prima si riferisce all’attività religiosa che si svolge online (come la diretta streaming di Messe o momenti di preghiera), mentre la seconda rinvia all’utilizzo di internet per sostenere attività del mondo reale (come avviene, per esempio, con la pubblicazione dei bollettini parrocchiali o dei calendari e orari degli appuntamenti). Essendo un’area ancora in qualche modo nuova e in continua evoluzione, essa sembra proporsi come un campo privilegiato per future indagini.
Conclusione
La ricerca sulla comunicazione ha visto crescere vivacemente l’interesse per la religione, alimentato dall’espansione del mondo online e dalla crescente visibilità di gruppi non occidentali e non cristiani nel mondo dei media. Questo ha spinto gli studiosi di comunicazione a riconoscere i propri pregiudizi religiosi, così come quelli inerenti alla sfera mediatica. Molti ricercatori hanno confinato le loro indagini su religione e comunicazione entro una sorta di posizione sociologica «neutrale»; altri hanno asserito che un impegno religioso personale rende più facile comprendere il mondo della comunicazione e della religione «dall’interno». Ma forse possiamo rintracciare il maggiore impulso alla crescita di quest’area di ricerca nella volontà che anima un numero sempre maggiore di studiosi: lavorare insieme al di là dei confini nazionali e religiosi[3].
Copyright © La Civiltà Cattolica 2023
Riproduzione riservata
***
-
Cfr R. Abelman – S. M. Hoover (edd.), Religious Television: Controversies and Conclusions, Norwood, Ablex Publishing Corporation, 1990; Y. Cohen, Spiritual News: Reporting Religion Around the World, New York, Peter Lang, 2018; C. Helland, «Online Religion as Lived Religion: Methodological Issues in the Study of Religious Participation on the Internet», in Heidelberg Journal of Religions on the Internet 1 (2005) 1-16; P. G. Horsfield, Religious Television: The American Experience, New York, Longman, 1984; L. Schofield Clark, From Angels to Aliens: Teenagers, the Media, and the Supernatural, New York, Oxford University Press, 2003; M. Silk, Unsecular Media: Making News of Religion in America, Champaign, University of Illinois Press, 1995. ↑
-
Cfr Center for Media, Religion and Culture (www.colorado.edu/cmrc); Centre for Theology and Public Issues (hctpi.div.ed.ac.uk); Network for New Media, Religion, and Digital Cultural Studies (www.digitalreligion.tamu.edu). ↑
-
Per approfondire gli argomenti trattati in questo articolo, cfr Y. Cohen – P. Soukup (edd.), The Handbook on Religion and Communication, New York, Wiley, 2023. ↑