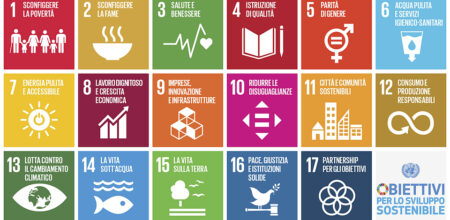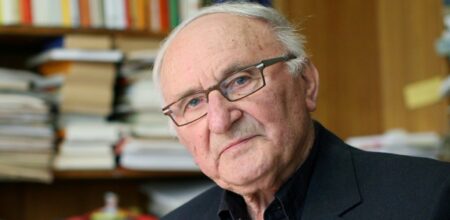Se c’è una parola che dice in sintesi la situazione globale che il mondo sta sperimentando, questa è «crisi». Nel suo discorso alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, papa Francesco l’ha evocata ben 46 volte. «Questo Natale – ha affermato – è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria, della crisi economica sociale e persino ecclesiale che ha colpito ciecamente il mondo intero. La crisi ha smesso di essere un luogo comune dei discorsi e dell’establishment intellettuale per diventare una realtà condivisa da tutti».
Già, perché «crisi» sembrava essere fino a poco fa la parola chiave dei discorsi di élite capaci di articolare la critica colta della condizione attuale. La crisi richiamava spesso la sua specificazione «esistenziale» che, invece di renderla concreta, la proiettava nell’indefinita astrazione. Nel 2020 questa crisi ha certamente perso ogni carattere astratto e ha preso il volto del lockdown, del conteggio dei morti, dell’economia a picco. Il 27 marzo, in piena pandemia, il Pontefice ha pregato in una piazza San Pietro deserta e così ha raccolto simbolicamente tutta la crisi del mondo, rivelandola in un luogo destinato a essere invece simbolo di presenza e di unità.
La crisi come motore dell’azione
Nel suo discorso alla Curia, Francesco ha voluto mettere in evidenza il significato e l’importanza dell’essere in crisi. Ha riconosciuto innanzitutto che «la crisi è un fenomeno che investe tutti e tutto. È presente ovunque e in ogni periodo della storia, coinvolge le ideologie, la politica, l’economia, la tecnica, l’ecologia, la religione». Dunque, è una esperienza umana fondamentale ed è «una tappa obbligata della storia personale e della storia sociale». Non la si può evitare, e i suoi effetti sono sempre «un senso di trepidazione, angoscia, squilibrio e incertezza nelle scelte da fare».
Già si comprende come la crisi sia un motore dell’azione e delle scelte, anche perché destabilizza e prepara nuovi equilibri. Richiede – come ricorda la radice etimologica del verbo greco krinō, dal quale deriva la parola italiana – quel tipico lavoro di setaccio che pulisce il chicco di grano dopo la mietitura.
La crisi in questo senso compie la storia, la quale non prende forma se non attraversa tempi di crisi, appunto. Francesco ricorda la Bibbia, che è popolata di «personaggi in crisi», i quali però proprio attraverso di essa compiono la storia della salvezza: Abramo, Mosè, Elia, Giovanni Battista, Paolo di Tarso e lo stesso Gesù, in particolare durante le tentazioni e poi nell’«indescrivibile crisi nel Getsemani: solitudine, paura, angoscia, il tradimento di Giuda e l’abbandono degli Apostoli», fino alla «crisi estrema sulla croce».
Francesco ha una visione evangelicamente dialettica della storia: è come se dicesse che se non c’è crisi non c’è vita. In questo senso la crisi evoca la speranza. Da qui il suo messaggio: in tempi di crisi occorre essere realisti, e «una lettura della realtà senza speranza non si può chiamare realistica. La speranza dà alle nostre analisi ciò che tante volte i nostri sguardi miopi sono incapaci di percepire».
E questo perché? Perché «Dio continua a far crescere i semi del suo Regno in mezzo a noi». Allora chi guarda alla crisi senza farlo alla luce del Vangelo «si limita a fare l’autopsia di un cadavere». Il tempo della crisi è un tempo dello Spirito, e il Vangelo stesso mette in crisi. Perciò, «davanti all’esperienza del buio, della debolezza, della fragilità, delle contraddizioni, dello smarrimento», a ben vedere si comprende «che le cose stanno per assumere una nuova forma, scaturita esclusivamente dall’esperienza di una Grazia nascosta nel buio».
Distinguere la crisi dal conflitto
Francesco distingue nettamente la crisi dal conflitto distruttivo. Questo è un tema forte della visione del Pontefice. Il conflitto, infatti, «crea sempre un contrasto, una competizione, un antagonismo apparentemente senza soluzione fra soggetti divisi in amici da amare e nemici da combattere, con la conseguente vittoria di una delle parti». La logica del conflitto cerca sempre una frattura tra parti opposte. Per esempio, la Chiesa, letta con le categorie di conflitto, genera divisioni tra «destra» e «sinistra», «progressisti» e «tradizionalisti». In tal modo frammenta e polarizza. Il conflitto irrigidisce e alla fine porta a imporre «una logica uniforme e uniformante, così lontana dalla ricchezza e pluralità che lo Spirito ha donato alla sua Chiesa».
Francesco definisce la Chiesa come un «Corpo perennemente in crisi», dove la novità «germoglia dal vecchio e lo rende sempre fecondo» senza contrapporsi a esso.
Il Papa, quindi, auspica la crisi in un passaggio molto importante del suo discorso: «Difendendoci dalla crisi, noi ostacoliamo l’opera della Grazia di Dio che vuole manifestarsi in noi e attraverso di noi. Perciò, se un certo realismo ci mostra la nostra storia recente solo come la somma di tentativi non sempre riusciti, di scandali, di cadute, di peccati, di contraddizioni, di cortocircuiti nella testimonianza, non dobbiamo spaventarci, e neppure dobbiamo negare l’evidenza di tutto quello che in noi e nelle nostre comunità è intaccato dalla morte e ha bisogno di conversione. Tutto ciò che di male, di contraddittorio, di debole e di fragile si manifesta apertamente ci ricorda con ancora maggior forza la necessità di morire a un modo di essere, di ragionare e di agire che non rispecchia il Vangelo. Solo morendo a una certa mentalità riusciremo anche a fare spazio alla novità che lo Spirito suscita costantemente nel cuore della Chiesa».
La crisi come tempo di Grazia
La «riforma», quindi, non risponde alla logica del conflitto ma a quella della crisi, che implica un superamento, un passo avanti: «Si deve smettere di pensare alla riforma della Chiesa come a un rattoppo di un vestito vecchio, o alla semplice stesura di una nuova Costituzione apostolica. La riforma della Chiesa è un’altra cosa», ed è frutto della Grazia. La crisi non si risolve mettendo toppe nuove su vestiti vecchi. Dunque, bisogna vivere la crisi come un tempo di grazia: è movimento, e fa parte di un cammino. Il conflitto, invece, è un girovagare senza scopo: è rimanere nel labirinto, sprecando energie. Il Pontefice, parlando di se stesso, ha concluso così il suo discorso alla Curia: «Per favore, pregate sempre per me perché io abbia il coraggio di rimanere in crisi».
Non sarà «crisi», dunque, la parola chiave per intendere la vita e la riforma della Chiesa che ci attende nel 2021? Non sarà necessaria l’accoglienza spirituale della crisi, senza timori né tentativi di camuffamento, per conferire alla Chiesa – universale e locale – il movimento giusto per essere sempre più evangelica?
Copyright © 2021 – La Civiltà Cattolica
Riproduzione riservata