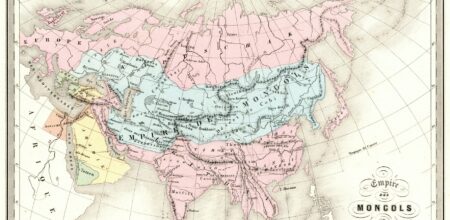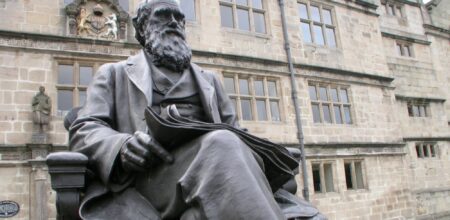|
|
Due eventi hanno riacceso il dibattito sulla laicità in Italia negli ultimi tempi: da una parte, il dibattito parlamentare sul disegno di legge Zan; dall’altra, la raccolta firme per avanzare la richiesta di referendum sul fine vita. Si sono levate voci a favore e voci contrarie, abbiamo assistito a prese di posizione di bandiera per cercare un’identità politica distintiva su temi che invece avrebbero bisogno di cercare aperti percorsi di convergenza. Altre volte si sono manifestate opinioni sincere che faticano a trovare spazi di incontro, perché dietro si nascondono barriere ideologiche o fondamentaliste.
Il disegno di legge n. 2005, proposto dal deputato del Pd Alessandro Zan, dopo il voto alla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, è ora oggetto di un vivace dibattito al Senato. Il titolo della proposta, «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità», annuncia una tematica importante e assai delicata. Al suo interno sono compresi il rispetto delle diversità e della dignità di ogni persona, la tutela dei più deboli e il contrasto alle discriminazioni. Tuttavia il dibattito che è stato aperto ha sollevato alcuni punti che stridono con altri diritti, come, ad esempio, la libertà di espressione del pensiero o la libertà educativa. D’altra parte, i temi affrontati dalla proposta di legge sollevano e stimolano una riflessione sulla costruzione identitaria, sul processo di conoscenza del sé e sull’interazione con il proprio corpo. La storia di oggi evidenzia che il rapporto tra natura e cultura non può essere dato più per scontato, e allo stesso tempo che ricorrere a soluzioni improvvisate potrebbe essere inefficace.
La paura di rinviare ancora la decisione di voto sul decreto ha indotto i proponenti e le forze che sostengono il disegno di legge a chiudere la finestra a possibili modifiche e a chiedere di votare il pacchetto senza cambiamenti, mentre le altre forze hanno aumentato l’ostruzionismo, presentando oltre 1.000 emendamenti. Il percorso parlamentare è stato rimandato all’autunno.
In seguito, ad agosto ha conquistato spazio nelle pagine della cronaca politica la campagna di raccolta firme per il referendum «Eutanasia legale. Liberi fino alla fine». Il 16 agosto 2021 un articolo di Cesare Zapperi sul Corriere della Sera titolava: «Eutanasia legale, raccolte le 500 mila firme per il referendum». Il comitato promotore annunciava che, attraverso la raccolta firme tradizionale e quella online, in un mese e mezzo era stata superata la quota necessaria indicata dall’art. 75 della Costituzione per avanzare la proposta.
Anche in questo caso, non sono mancate alcune osservazioni sui contenuti di una legge che chiede di abrogare una parte dell’art. 579 del Codice penale, che prevede le pene per l’omicidio del consenziente, esclusi i minorenni e le persone psichicamente inferme o coloro a cui il consenso sia stato estorto con violenza o con inganno. I promotori si sentono sostenuti dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, che ritiene parzialmente incostituzionale l’articolo 580 del codice penale. Tuttavia Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, ha chiaramente affermato, sulle colonne di Avvenire: «[La sentenza della Consulta] è precisa: a fronte di un’ipotesi di reato per Marco Cappato per aiuto al suicidio di dj Fabo, la Corte ritiene parzialmente incostituzionale l’articolo 580 del Codice penale nella misura in cui non contempla quattro circostanze in cui l’aiuto al suicidio andrebbe depenalizzato. Ricordo le quattro circostanze: la persona è affetta da patologie irreversibili, prova sofferenza intollerabile, è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale ed è capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Attenzione, ricordiamolo, la Corte non reputa incostituzionale il reato di aiuto al suicidio in generale, giudica incostituzionale la punizione dell’aiuto in presenza di queste quattro circostanze» («Caos giuridico in vista. Flick: “Eutanasia, un referendum ambiguo”», in Avvenire, 21 agosto 2021).
Nell’intervista si sollevavano, inoltre, alcuni dubbi formali e sostanziali, come, ad esempio, il riferimento all’articolo differente del Codice penale, la richiesta della Corte di una parziale depenalizzazione dell’aiuto al suicidio e non la totale depenalizzazione dell’omicidio del consenziente (cfr ivi).
D’altro canto, l’adesione alla proposta di referendum abrogativo ha stimolato le forze politiche rappresentate in Parlamento, che si sono affrettate a evidenziare l’esistenza di un progetto di legge in discussione: una testimonianza è l’appello del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a riprendere il cammino del testo base presente in Commissione Giustizia.
Ancora una volta nel dibattito pubblico sono riemerse le richieste di distinguere i campi di intervento dello Stato e quelli della Chiesa. La continua formulazione di leggi su questioni delicate, dove è difficile delimitare i confini delle scelte, sottolinea la complessità del dialogo e solleva interrogativi sui modi di comprendere la laicità e sulle modalità con le quali essa si declina in Italia.
Le ambiguità della laicità
I temi sull’etica e sulla vita diventano uno dei crinali su cui misurare il significato odierno di laicità e affrontare le sue ambiguità, perché aprono una frattura nel principio di separazione dei poteri tra Stato e Chiesa. Tale principio è uno dei tratti distintivi della laicità. Ha conosciuto un lungo percorso e nel tempo ha assunto significati con sfumature differenti. Una delle sue tappe principali è stato il trattato di Westfalia, e uno dei suoi punti di approdo successivi è l’autonomia tra le istituzioni ecclesiali e politiche. Oggi, nei dibattiti politici, quando si invoca la laicità, spesso si rivendica proprio l’autonomia dello Stato: lo si vuole libero nelle sue decisioni dalle interferenze delle comunità di fede.
La separazione dei poteri ha portato anche alla formulazione di un’idea neutra di laicità. In questo caso lo Stato dovrebbe garantire l’equidistanza rispetto a visioni ideologiche o religiose che favorirebbero l’una o l’altra parte. Però la neutralità rischia di portare a una sterilizzazione culturale, dove parte delle motivazioni – quelle legate a sistemi di credenze, di tradizioni, di costumi – dovrebbe rimanere confinata nello spazio privato, mentre solo alcune – quelle legate alla razionalità o alle evidenze scientifiche – avrebbero la capacità di reggere il confronto nello spazio pubblico. Ma nello spazio vuoto, che viene riempito da ragioni diverse, si sviluppano pressioni di potere, emergono zone di influenza dei vari esperti e delle varie correnti culturali e comunità di appartenenza.
D’altronde, nella neutralità rimane il gioco dei poteri delle diverse realtà e organizzazioni che vivono in una società plurale: la possibilità di condizionare il comportamento della gente attraverso la formazione degli obblighi nell’ordinamento giuridico e/o attraverso quella dell’indicazione delle norme morali. L’atmosfera asettica da laboratorio non è riproducibile nella vita concreta e nelle relazioni. E la conflittualità tra la priorità di un valore su un altro, uscita dalla porta, rientra dalla finestra.
La società democratica si alimenta della partecipazione dei cittadini, che non sono neutrali e non sono monadi. Ognuno di noi si confronta con valori, con princìpi, con tradizioni, con innovazioni culturali e scientifiche, con le proprie comunità di appartenenza (familiare, religiosa, civile, lavorativa). Dentro questa cornice passano il nostro discernimento e la nostra capacità di scelta. Quindi, laicità non può essere neutralità vuota, ma spazio pieno di confronto. È all’interno di esso che si giocano la libertà di manifestare il proprio pensiero o di credere in una religione, di dare ragione delle proprie speranze.
Un secondo approccio alla laicità può aiutare ad arginare i limiti della neutralità: esso chiede di vedere la realtà con lo sguardo dell’osservatore critico, per ricercare la verità con la capacità di intercettare i pregiudizi, di riconoscere gli stereotipi, di essere consapevoli della caducità delle conoscenze e di essere prudenti nell’accogliere le innovazioni. Il filosofo francese Edgar Morin invita a rinnovare il significato per rispondere alle nuove sfide della storia: «All’origine della laicità nata dal Rinascimento sta la problematizzazione che interroga il mondo, la natura, la vita, l’uomo, Dio. […] La nostra laicità dell’inizio del secolo ha potuto credere che la scienza, la ragione, il progresso avrebbero portato le soluzioni a tutti questi interrogativi. Oggi non bisogna più problematizzare solo l’uomo, la natura, il mondo, Dio, ma si devono problematizzare anche il progresso, la scienza, la tecnica, la ragione. La nuova laicità deve problematizzare la scienza, rivelandone le profonde ambivalenze; deve problematizzare la ragione, opponendo la razionalità aperta alla razionalità chiusa; deve problematizzare il progresso, che dipende non da una necessità storica, ma dalla volontà cosciente degli umani. Così una laicità rigenerata creerebbe forse le condizioni di un nuovo Rinascimento» (E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Milano, Raffaello Cortina, 1999, 108).
Così il fine vita o il processo di conoscenza di sé diventano una cartina al tornasole per verificare lo stato di maturazione della laicità in Italia, perché toccano insieme grandi temi e la vita delle persone. Da un lato, essi mostrano i progressi delle tecniche scientifiche e delle cure mediche che aumentano la possibilità di assistere le persone malate e rendono sempre più difficile determinare i limiti tra percorso terapeutico e accanimento e cure palliative; dall’altro, i percorsi di acquisizione di conoscenza di sé, di socializzazione e di individualizzazione sono sempre più articolati e mettono in discussione i modelli di ordine di genere, così come le organizzazioni sociali li hanno storicamente costruiti, e interrogano il rapporto delle persone con il proprio corpo in modi non scontati.
Dentro queste periferie esistenziali il dialogo dovrebbe essere uno spazio all’interno del quale poter accogliere la pluralità e le differenze e iniziare a costruire itinerari comuni possibili. In questi casi, forse, non sono le leggi precise e specifiche a essere le più utili, perché esse tracciano confini definiti, delimitano e circoscrivono le azioni.
Per una laicità del dialogo
Quando si valorizza la dimensione critica della laicità, non è più possibile alzare argini e confinare alcune posizioni. È importante promuovere il dialogo nella ricerca di una continua approssimazione alla verità. Si può prendere atto di una società plurale e multiculturale e di una specificità italiana, che parla di una Repubblica fondata su un Patto costituzionale, di un Concordato con la Chiesa, delle diverse intese stipulate con altre comunità religiose presenti sul territorio nazionale. Un percorso storico che riconosce la presenza nello spazio pubblico delle religioni, nel rispetto della storia e della tradizione del Paese, che ne dovrebbe valorizzare il contributo culturale e non soltanto quello sociale sostenuto da associazioni, scuole, centri assistenziali e sociosanitari di ispirazione confessionale.
Il nostro tempo propone la crescita di una società pluralista, che mette a costante confronto i credenti cattolici, i credenti di altre fedi, gli atei e gli agnostici. Serve un contesto che alimenti l’incontro delle diverse appartenenze e identità. Abitiamo una società che proietta l’incontro-scontro non soltanto sui grandi temi e ideali, ma nella pratica quotidiana. La laicità critica e dialogante può favorire un’atmosfera culturale che superi l’ottocentesca opposizione tra civile e religioso, che sia in grado di andare oltre l’idea che privatizzare la propria confessione di fede sia un tassello essenziale alla neutralità dello Stato (cfr C. C. Canta – A. Casavecchia – M. S. Loperfido – M. Pepe, Laicità in dialogo. I volti della laicità nell’Italia plurale, Caltanissetta, Sciascia, 2011).
Per facilitare il dialogo costruttivo serve una laicità capace di costruire uno spazio di convivenza in cui si sperimenti un riconoscimento reciproco, che possa comporre la concretezza del linguaggio scientifico con le proposte di orizzonte di senso per la vita. Una laicità del dialogo è una sfida aperta e imprevedibile, nella quale non si rinuncia alle proprie caratteristiche identitarie, ma le si proietta in avanti.
D’altronde il dialogo è uno stile, come ha evidenziato papa Francesco durante il Convegno ecclesiale di Firenze: «Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare di ricavare la propria “fetta” della torta comune. Non è questo che intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori per tutti. Molte volte l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non dobbiamo temerlo né ignorarlo, ma accettarlo. Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. […] La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze culturali possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media… La Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità. Del resto, le nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un dialogo e di un incontro tra culture, comunità e istanze differenti. Non dobbiamo aver paura del dialogo: anzi è proprio il confronto e la critica che ci aiuta a preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia» (Francesco, «Discorso in occasione dell’“Incontro con i rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa Italiana”», Firenze, 10 novembre 2015, in www.vatican.va).
Copyright © La Civiltà Cattolica 2021
Riproduzione riservata