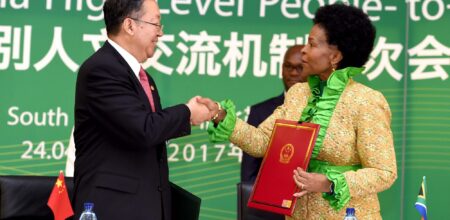|
|
«Un vescovo fatto Vangelo»: così monsignor Agostino Superbo, postulatore della causa di beatificazione, definisce don Antonio Bello, parafrasando una sua definizione di vescovo. «Vorrei essere – diceva infatti don Tonino all’inizio del ministero episcopale – un vescovo fatto popolo, un vescovo elevato alla dignità di popolo»[1]. A chi gli chiedeva le componenti della sua formazione umana, religiosa e pastorale, egli rispondeva con semplicità e immediatezza: «Il Vangelo e gli ultimi»[2].
Sono passati 25 anni dalla sua morte, causata da un tumore. Un’esistenza breve (58 anni) ma intensa, semplice ma provocatoria, sobria ma ricca di amore per i poveri e i diseredati, umile e aperta a tutti: di lui oggi possiamo dire con verità che la sua vita e la sua opera di pastore sono state un’esegesi vivente del Vangelo.
Il vescovo di Molfetta non si è fatto mai chiamare né «Monsignore» né «Eccellenza», ma semplicemente «don Tonino», e così firmava le lettere pastorali e i documenti. Lui è rimasto sempre il presbitero della Chiesa pugliese. Il suo nome era, ed è ancora per tutti «don Tonino»
Luigi Santucci, un mese dopo la morte, nell’introduzione a un libro di don Tonino, Maria, donna dei nostri giorni, dava un accurato elenco delle sue virtù: «Soavità, tenerezza, stupori di vibrante poeta; ma poi forza, passione, coraggio anticonformista. Virtù, codeste ultime, che più me lo hanno fatto stimare e amare per la generosa baldanza con cui da anni egli denuncia e affronta le infamie della nostra società; le fiacchezze e i ritardi della nostra Chiesa; […] la sua opzione radicale nei confronti degli ultimi e dei poveri, l’impegno per la pace e la nonviolenza»[3].
Sono già stati messi in luce gli aspetti più significativi della biografia di don Tonino: «Il sacerdote, il vescovo, il terziario francescano, il pacifista, il salentino, il molfettese, lo studioso mariano, il mistico, lo scrittore, il poeta, l’utopista, l’impegnato, l’eccentrico»[4]. Ma qual è oggi la sua eredità spirituale?
La Chiesa del grembiule
In uno dei suoi primi scritti, don Tonino definisce la Chiesa che annuncia il Vangelo come «la Chiesa del grembiule». E spiega: «Forse a qualcuno può sembrare un’espressione irriverente, e l’accostamento della stola con il grembiule può suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio.
«Sì, perché, di solito, la stola richiama l’armadio della sacrestia, dove, con tutti gli altri paramenti sacri, profumata d’incenso, fa bella mostra di sé con la sua seta e i suoi colori, con i suoi simboli e i suoi ricami. […] Il grembiule, invece, ben che vada, se non proprio gli accessori di un lavatoio, richiama la credenza della cucina, dove, intriso di intingoli e chiazzato di macchie, è sempre a portata di mano della buona massaia. […] Eppure è l’unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo. Il quale Vangelo, per la Messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì Santo non parla né di casule né di amitti, né di stole né di piviali. Parla solo di questo panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi con un gesto squisitamente sacerdotale. […]
«La cosa più importante, comunque, non è introdurre il grembiule nell’armadio dei paramenti, ma comprendere che la stola e il grembiule sono quasi il diritto e il rovescio di un unico simbolo sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono come l’altezza e la larghezza di un unico panno di servizio; il servizio reso a Dio e quello offerto al prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe semplicemente calligrafica. Il grembiule senza la stola sarebbe fatalmente sterile»[5].
«La Chiesa del grembiule» per don Tonino è semplicemente «la Chiesa»: egli stesso ammette che può essere «un’immagine un po’ discinta, un po’ civettuola; però è l’immagine più vera della Chiesa. La Chiesa che si piega davanti al mondo, in ginocchio; che diventa povera, povera di potere. Pauper (povero) in latino non s’oppone a dives (ricco), si oppone a potens (potente). Ecco perché non dobbiamo più avere i segni del potere, ma il potere dei segni. […] Avere in casa degli sfrattati non significa risolvere il problema degli sfrattati, ma porre dei segni verso cui tutti dovranno andare; tutti come comunità cristiana»[6].
La Chiesa povera è l’unico modo per essere vicini a ogni uomo, per essere presi sul serio e divenire credibili. Come ha insegnato il Signore Gesù, il quale «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). La salvezza non viene da qualcuno che ha tutto e ci dona qualcosa, ma da uno che si è fatto uomo, ci ha donato tutto se stesso, fino ad abbassarsi al nostro livello, e partendo dal nostro livello più basso ci rialza, ci rinnova, ci redime.
«La Chiesa del grembiule» è anche l’immagine del pastore che dà al Vangelo realtà storica ed evidenza profetica; che rende presente il mistero di Cristo nella società, in dialogo con i fratelli e con il mondo, secondo le parole del Vangelo: «Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,43-45).
L’espressione «Chiesa del grembiule» è divenuta oggi l’icona del magistero e dell’opera di don Tonino, da cui emergono due aspetti fondamentali del pastore: don Tonino è l’uomo di Dio e il servo degli uomini.
L’uomo di Dio
Il primo insegnamento che il vescovo di Molfetta ci ha lasciato consiste nell’essere stato un uomo di preghiera, un contemplativo. Nelle numerose lettere pastorali, molto attese dalla sua gente perché imprevedibili e mai scontate, la preghiera risuona con frequenza: «Sperimento tutti i giorni che, quando mi sono intrattenuto a lungo con il Signore e gli ho confidato tutti i problemi pastorali e personali che mi travagliano, le difficoltà mi si risolvono tra le mani come un cubetto di ghiaccio che si scioglie al sole»[7]. Una preghiera non facile, perché talora significava anche «combattere con Dio. Di notte. In uno sconvolgente “a tu per tu”. Quasi per strappargli il segreto della felicità. Quella felicità che inseguiamo tutta una vita»[8].
La preghiera era la sua guida e dava il significato alla sua missione pastorale: gli permetteva di mettere le mani sul «timone della storia. […] Il vescovo, infatti, è, nella Chiesa locale, il responsabile supremo di quel grosso “affare” spirituale che si chiama preghiera. […] Ha il compito fondamentale di promuovere rapporti tra il popolo e il Signore e, quindi, di suscitare e animare sul territorio un intenso spirito di orazione. Ciò significa che il Signore chiederà conto a me se in diocesi si prega poco o si prega male»[9].
L’uomo di Dio, attento alla preghiera del proprio popolo, la scopre nei punti più reconditi e impensabili. La sua sensibilità sa scovare anche ciò che non appare: «Mi accorgo che, in fatto di preghiera, c’è un sommerso incredibile, le cui proporzioni sono difficilmente quantificabili. Quanta gente ho trovato che medita quotidianamente la Parola di Dio. Quanti giovani vivacissimi, sul più bello, mi hanno invitato a recitare con loro la liturgia delle ore. Quanti ammalati ho trovato, nelle mie visite pastorali, che sono divenuti i candelabri viventi perennemente accesi davanti al Signore e poi… chi sa quanta gente c’è, apparentemente lontana da Dio, che prega senza neppure saperlo!»[10].
Don Tonino, il contemplativo unito profondamente a Dio, ci insegna a impegnarci di più nella «lettura» della terra che non in quella del cielo. Occorre guardare le vicende umane più umili, il mondo oppresso dal dolore e dalla fatica, la gente comune che ha perso la speranza, gli atei che si sono dati da fare per i fratelli, non sapendo che in questo modo vivevano il Vangelo.
In questa luce «terrena» don Tonino scruta con attenzione anche le pagine del Nuovo Testamento che presentano la Madre di Gesù. Nel libro Maria, donna dei nostri giorni si rivolge alla Madonna, definendola «donna feriale»: «[Tu vivi] a Nazaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere, tra gomitoli di lana e rotoli della Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo spessore della tua naturale femminilità, gioie senza malizia, amarezze senza disperazioni, partenze senza ritorni»[11].
Il servizio della Chiesa
Don Tonino ci ha insegnato un’altra caratteristica della «Chiesa del grembiule»: una Chiesa che è «serva». Questo ce l’ha indicato il Signore nella lavanda dei piedi. Egli fa un atto che nemmeno uno schiavo ebreo faceva, perché non era dignitoso. Il compito di lavare i piedi era riservato agli schiavi stranieri. «Un sacerdote difficilmente potrà essere portatore di annunci credibili se […] non è disponibile a lavare i piedi di tutti gli altri […]. Perché gli uomini accettano il messaggio di Cristo, non tanto da chi ha sperimentato l’ascetica della purezza, quanto da chi ha vissuto le tribolazioni del servizio. La logica della lavanda dei piedi è eversiva»[12]. «Il cristiano autentico – dice don Tonino in un’altra occasione – è sempre contro corrente, non per posa, ma perché sa che il Vangelo non è omologabile alla mentalità corrente»[13]. «Ha il compito di essere “la coscienza critica del mondo”»[14].
La prospettiva di don Tonino è nella linea di papa Giovanni XXIII e del Vaticano II: scrutare i segni dei tempi e avere il coraggio di essere disponibili a quanto ci viene richiesto. La vocazione della Chiesa è il servizio dell’uomo, soprattutto dei poveri, dei più deboli, dei piccoli, degli ultimi, dei diseredati, ai quali lo stesso Signore volle dimostrarsi particolarmente unito[15]. È questa la missione dei discepoli.
Don Tonino ha parlato più volte della necessità di una Chiesa «estroversa», cioè non autoreferenziale, «in uscita» (come direbbe oggi papa Francesco), dedita al servizio del mondo. Con un segno che deve qualificare l’azione cristiana: «Pensare globalmente e agire localmente»[16]. E lui è stato il primo a darne un esempio: ha aperto il palazzo vescovile agli sfrattati; ha accolto quanti bussavano alla sua porta; è stato vicino agli operai che lottavano per una più umana giustizia, ma soprattutto ai malati di AIDS e alle prostitute; ha difeso la causa dei disabili, dei disoccupati, dei primi immigrati dall’Albania.
Emerge qui anche il profondo spessore umano che ha animato costantemente il servizio di don Tonino e che lo ha reso credibile e vicino alla gente comune: il pastore è stato segno visibile di una Chiesa dal volto umano, desiderosa di essere accanto all’esistenza più umiliata degli uomini[17].
Va ricordata una lettera che, in occasione della Giornata per l’emigrazione, egli scrisse al «fratello marocchino». L’inizio era una richiesta di scuse per averlo chiamato così, perché forse non aveva nulla a che fare col Marocco: noi – diceva – chiamiamo «marocchini» tutti gli infelici che, coperti di tappeti, vanno in giro a venderli. Poi continuava: «Perdonaci, se non abbiamo saputo levare coraggiosamente la voce per forzare la mano dei nostri legislatori. Ci manca ancora l’audacia di gridare che le norme vigenti in Italia, a proposito di clandestini come te, hanno sapore poliziesco, non tutelano i più elementari diritti umani, e sono indegne di un popolo libero come il nostro. Perdonaci, fratello marocchino, se noi cristiani non ti diamo neppure l’ospitalità della soglia. […] Un giorno, quando noi incontreremo il nostro Dio, questo viandante sulle strade della terra, ci accorgeremo con sorpresa che egli ha… il colore della tua pelle». Infine, concludeva: «Se passi da casa mia, fermati»[18].
Don Tonino ha considerato gli ultimi non tanto come destinatari privilegiati della sua pastorale, ma come protagonisti della storia della salvezza: proprio i poveri, i diseredati, gli umiliati, gli immigrati sono la presenza di Cristo in mezzo a noi, perché il Signore Gesù si è identificato con loro («Tutto ciò che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»: Mt 25,40). Da loro ci viene la salvezza.
Il servizio della comunione
Il servizio del pastore è segnato dalla comunione e dalla solidarietà: «Siamo chiamati ad essere “servi della comunione”. Questa deve essere la nostra brillante carriera»[19]. Come nella prima Chiesa i cristiani erano «un cuor solo ed un’anima sola» (At 4,32), così deve essere lo stile della comunità. Si tratta di «orientare in modo concorde l’azione delle diverse componenti ecclesiali (parrocchie, associazioni, sacerdoti, laici) verso la costituzione di quella “Chiesa eucaristica” di cui parlano i vescovi nel documento Eucarestia, comunione e comunità, e verso la collocazione di segni e di gesti credibili»[20].
Don Tonino ha vissuto il momento cruciale dell’unione di quattro diocesi – Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo di Puglia –, con gli inevitabili strascichi. Ma l’esortazione alla comunione ha determinato il clima da ricreare insieme nella vita della nuova diocesi. Un’ecclesiologia di comunione, secondo il Concilio: tenendo presente che nella Chiesa non vi sono due categorie di cristiani – il clero e i laici –, ma, come afferma la Lumen gentium, «comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia dei figli, comune la chiamata alla perfezione» (n. 32). Ne segue che la gerarchia non si colloca al di sopra, ma all’interno del popolo di Dio. In tal modo l’ecclesiologia di comunione bandisce ogni forma di «clericalismo».
È interessante, per don Tonino, il fondamento teologico trinitario del servizio di comunione: Padre, Figlio e Spirito Santo non vivono l’uno accanto all’altro, ma l’uno per l’altro. Di qui l’ingegnosa formula «matematica», per aiutarci a scalfire il mistero di un solo Dio in tre persone: «Non parlo di uno più uno più uno, perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa sempre “uno”. In Dio ogni persona vive per l’altra. È una specie di marchio di famiglia […], così che, anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è manifestato come l’uomo per gli altri»[21]. La Trinità insomma ci provoca alla comunione, fa di noi «un volto rivolto verso l’altro»[22], nel senso che chi vive per l’altro crea unità ed è testimone del Vangelo.
Questa comunione si distingue per un segno particolare: la gioia e la speranza. Egli afferma: «Dobbiamo servire il mondo, ma da risorti. Di servizio se ne compie, nella Chiesa, e tanto anche. A volte fino all’esaurimento. Ci schieriamo con i poveri, facciamo mille sacrifici, aiutiamo la gente […], ma non con l’anima dei risorti, bensì con l’anima degli stipendiati. E non sempre col nostro servizio annunciamo Cristo speranza del mondo. Annunciamo più noi stessi e la nostra bravura, che lui! Appariamo non di rado un’organizzazione che incute rispetto, spesso anche paura, soggezione. Ma non siamo i viandanti entusiasti che insieme agli altri dirigono i propri passi verso Cristo risorto»[23].
Infine – egli nota – «la Chiesa non deve mai collocarsi come un assoluto. L’assoluto è il suo Signore Gesù Cristo. La Chiesa è serva umile: quanto più, starei per dire, si toglie di mezzo, meglio è: per far risplendere Lui, Gesù Cristo, lo sposo che arriva. Un giorno lei, la Chiesa, sarà introdotta alle nozze con l’Agnello: e solo allora ci sarà gloria anche per essa. Prima no. Ogni anticipazione della gloria sarebbe appropriazione indebita»[24].
Il testimone della nonviolenza e della pace
Un altro grande insegnamento del vescovo di Molfetta è stato il suo essere testimone della nonviolenza e della pace. Non solo nella terra del Salento, ma anche nella Chiesa italiana, soprattutto da quando fu nominato presidente del movimento «Pax Christi». Allora il suo impegno venne alla ribalta.
Nel 1991, la Guerra del Golfo era particolarmente sentita a Molfetta, poiché quattro concittadini, operai in Iraq, erano stati presi in ostaggio dal regime iracheno. In quella circostanza, così delicata e sofferta, don Tonino ebbe il coraggio di ribadire il rifiuto della guerra, e di ogni guerra, nella linea di Giovanni Paolo II. Quando gli Usa minacciarono di dichiarare guerra, egli cercò la solidarietà dei vescovi italiani per lanciare un appello alla ragione. Pare che nessuno abbia risposto. L’Italia poi si schierò nell’alleanza contro Saddam Hussein. Allo scoppio del conflitto, don Tonino affermò anche che la guerra era stata dichiarata per ragioni subdole, perché erano in gioco gli interessi petroliferi nella regione.
L’anno seguente, quando il tumore lo aveva già gravemente colpito, don Tonino si impegnò per la Marcia dei Cinquecento a Sarajevo, con l’ideatore dell’impresa, don Albino Bizzotto, con il gruppo «Beati i Costruttori di Pace» di Padova e diversi parlamentari. Vi partecipò di persona insieme a monsignor Luigi Bettazzi, suo amico. Tra tante difficoltà, trattative, rimandi e dinieghi, nonostante i blocchi dell’esercito e dei paramilitari, sotto la mira dei cecchini i Cinquecento riuscirono nell’impossibile: raggiungere Sarajevo sotto assedio, di notte, proprio in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani. Fu un segno di speranza per la popolazione martoriata, che viveva nell’incubo della fame e della morte. Don Tonino in quell’occasione ebbe a proclamare, durante un’assemblea, il valore della nonviolenza e della pace fra le diverse etnie: «Siamo qui, allineati sulla grande idea della nonviolenza attiva […]. Gli eserciti di domani saranno questi: uomini disarmati. Abbiamo sperimentato che ci sono alternative alle logiche della violenza…»[25]. Al ritorno a Molfetta, egli scrisse: «Non siamo andati a Sarajevo per risolvere il problema della guerra, ma “per testimoniare a quella gente la nostra solidarietà, per dire che l’Europa non si è dimenticata di loro, per dire che c’è nel mondo gente che ama la pace e che ci sono oggi alternative nuove alla difesa armata della guerra”»[26].
Fu un viaggio simbolico, ma aprì la strada a iniziative di cooperazione e aiuti alle popolazioni balcaniche, reinventando la solidarietà umana nella ricerca della pace. Poiché si era vicini al Natale, don Tonino immaginò che i Cinquecento fossero i magi, giunti da Erode, in cerca del Bambino Gesù. Dove trovarlo? «Ecco, l’abbiamo trovato nelle persone che abbiamo abbracciato lungo la strada. Nei fanciulli che ci venivano incontro per darci la mano e un sorriso di speranza. Nei vecchi commossi per la nostra audacia. Nel giovane soldato piangente alla nostra partenza. Nei capi religiosi della città e nelle autorità civili, che ci hanno implorato di interessare il mondo, indifferente, come la città di Betlemme, alle sofferenze dei poveri»[27].
Quattro mesi dopo, il 20 aprile 1993, don Tonino concludeva il suo doloroso calvario.
«Se un giorno ti faranno santo…»
Quello che segue è un episodio accaduto a Milano poco tempo prima. Don Tonino era stato invitato dal cardinale Martini a parlare nel Duomo. Al ritorno, a un sacerdote milanese che lo accompagnava chiese un parere sul suo arcivescovo, di cui si iniziava a esaltare l’impegno biblico per la diocesi. Ecco il sunto della conversazione nelle parole e nelle reazioni di don Tonino: «Il sacerdote ha risposto: “Al cardinale Martini, se gli togli la Bibbia dalle mani, non sa fare altro” […]. Quanto avrei voluto che l’avessero detto di me! […] Se mi togli la parola del Vangelo dalle labbra, non mi rimane nient’altro»[28].
Ecco l’eredità di don Tonino oggi: il presbitero del Vangelo, il profeta forte della sua debolezza, il povero per il servizio dei poveri – che sono presenza di Cristo nella storia –, l’uomo che vede nella politica la carità più alta per la pace.
Alla sua morte, il capo storico del Pci a Molfetta, Sandrino Fiore, scrisse: «A parte la grande apertura umana, era il suo rigore intellettuale che lo portava a scrutare dentro la storia con profonda acutezza profetica, anche nei suoi passaggi più terribili ed epocali. Ora don Tonino non è più. Lasciatemi dunque che io mi rivolga a lui direttamente: Caro don Tonino, […] grazie per avermi fatto conoscere il “tuo” Dio. E se un giorno ti faranno santo, sarò con te, perché i santi come te posso toccarli con mano, stringerli tra le braccia e sentirli vicini»[29].
Il viaggio di papa Francesco a Molfetta è il riconoscimento della Chiesa per una vita donata agli ultimi di «un vescovo fatto Vangelo».
Copyright © La Civiltà Cattolica 2018
Riproduzione riservata
***
«A bishop became Gospel»: so Msgr. Augustine Superbo, postulator of the cause of beatification, defines Don Tonino Bello, bishop of Molfetta. It has been 25 years since his death, caused by cancer. A short but intense life (58 years), simple but provocative, sober but rich with love for the poor and the dispossessed: his life as a pastor was a living exegesis of the Gospel. «The Church of the apron» (which is the only «vestment» worn by Jesus at the Last Supper) is the expression coined by Don Tonino to indicate service to the brothers, the love for the least, the courage to denounce social injustice, the choice of nonviolence and peace. The Church must abandon the signs of power to embrace the power of the signs, to be a credible face of the Gospel in the world.
***
[1]. D. Amato, Tonino Bello. Una biografia dell’anima, Roma, Città Nuova, 2013, 5.
[2]. Ivi, 185 s.
[3]. L. Santucci, «La confidenza di un vescovo», in A. Bello, Maria, donna dei nostri giorni, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1993, 6.
[4]. G. Minervini, «Relazione al Convegno nazionale: “Don Tonino Bello, vescovo secondo il Concilio” (24-26 aprile 2003)», in T. Dell’Olio, «Stola e grembiule. Don Tonino Bello, vescovo», in Aggiornamenti Sociali 55 (2004) 107.
[5]. V. Salvoldi, «Introduzione: “E chi mi ascolta?”», in La Chiesa del grembiule. Sulle orme di don Tonino Bello, Padova, Messaggero, 1999, 7 s.
[6]. A. Bello, Scritti di pace, Molfetta (Ba), Mezzina, 1997, 146 s.
[7] . D. Amato, Tonino Bello…, cit., 93.
[8] . Ivi, 95.
[9] . Ivi, 93.
[10]. Ivi, 93 s.
[11]. A. Bello, Maria, donna dei nostri giorni, cit., 13.
[12]. Id., Omelie e scritti quaresimali, Molfetta (Ba), Mezzina, 1994, 358.
[13]. D. Bona, «Il Vangelo della pace», in La Chiesa del grembiule…, cit., 119.
[14]. Ivi.
[15]. Cfr il Decreto conciliare Presbiterorum Ordinis, n. 6.
[16]. D. Amato, Tonino Bello…, cit., 151.
[17]. Cfr A. Picicco, Nel riverbero di cento ideali. Spessori di umanità nel magistero del vescovo Tonino Bello, Terlizzi (Ba), Ed. Insieme, 2012, 15-21.
[18]. A. Bello, Articoli, Corrispondenze, Lettere, Notificazioni, Molfetta (Ba), Mezzina, 2003, 286-288.
[19]. Id., Scritti vari, interviste, aggiunte, ivi, 2007, 75.
[20]. Id., Omelie e scritti quaresimali, cit., 102.
[21]. Ivi, 337.
[22]. Ivi.
[23]. Id., Scritti vari…, cit., 77.
[24]. Ivi.
[25]. Id., Scritti di pace, cit., 340.
[26]. S. Paronetto, Tonino Bello Maestro di nonviolenza. Pedagogia, politica, cittadinanza attiva e vita cristiana, Milano, Paoline, 2012, 183 (la citazione è tratta da A. Bello, Scritti di pace, cit., 532).
[27]. A. Bello, Scritti di pace, cit., 344.
[28]. D. Amato, Tonino Bello…, cit., 171 s.
[29]. Ivi, 221 s.