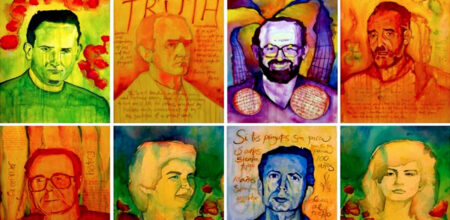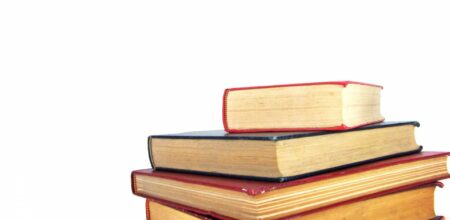|
|
La santità è la scelta di un’amicizia. Ogni via di santità sottintende un’opzione che si rinnova a ogni passo. Scrive papa Francesco: «Prima di ogni legge e di ogni dovere, quello che Gesù ci propone di scegliere è un seguire, come quello degli amici che si seguono, si cercano e si trovano per pura amicizia» (Christus vivit [CV], n. 290). E anche: «Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo» (Gaudete et exultate [GE], n. 15).
Ma è proprio vero che si sceglie di essere santi? Fatichiamo a porre la santità nei termini di un’opzione radicale. È difficile, infatti, dire «no» alla santità in maniera diretta, definitiva ed escludente. La nostra ragione pratica ci impedisce di scegliere il male in quanto male. È più probabile che il «no», in effetti, sia un «sì» rimandato all’infinito, un «sì, ma…», un «sì» condizionato. Sembrerebbe non realistico scegliere qualcosa che supera le nostre possibilità. Più ancora: dire «scelgo di essere santo» suona pretenzioso. Ma se è così, è perché l’immagine che abbiamo della santità non è evangelica1.
La scelta di essere santi, come mostra bene il Pontefice, non è in primo luogo nostra, ma di chi ci ha creati: «Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi “per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità” (Ef 1,4)» (GE 2). Chi ci ha donato l’esistenza, ci ha sognati santi. Ed è importante che questa santità si realizzi attraverso l’amore, non attraverso altre qualità straordinarie.
L’amore di cui parla la Lettera agli Efesini è, da una parte, l’amore che Dio ci dona e, dall’altra parte, il nostro amore, quello che possiamo dare noi così come siamo. Non si tratta di un amore eroico, tantomeno di un amore standard o stereotipato, ma di semplice amore personale, quello di Dio e il nostro, ciascuno per come è: quello di Dio è infinitamente misericordioso e creativo; quello nostro è piccolo e vacillante, ma pur sempre amore.
Il presupposto ignaziano della scelta
Alla fine della seconda settimana degli Esercizi spirituali (ES) sant’Ignazio pone una sezione composta da 20 numeri: sono le norme su come «fare elezione», cioè scegliere e riformare il proprio genere e stato di vita (ES 169-189).
È un «documento pratico», come lo chiama Miguel Ángel Fiorito, che lo distingue dalle contemplazioni e meditazioni (documenti tematici) e dalle regole di discernimento (documenti normativi)2. Sant’Ignazio parla delle condizioni che si richiedono per fare una scelta buona e sana: i tempi e la materia della scelta.
Il tempo (che potremmo intendere anche come stato d’animo interiore) è una condizione soggettiva in cui ci si trova, senza poter scegliere. Può darsi che sia un tempo di lotta spirituale, in cui si sperimentano consolazioni e desolazioni; può essere un tempo tranquillo, in cui ci si può servire della propria intelligenza per ragionare in pace su ciò che Dio ci chiede; e può essere un tempo in cui Dio con la sua grazia ci fa vedere la missione a cui ci chiama in maniera chiara e irresistibile.
Noi ora qui ci soffermeremo sulla materia della scelta. Si tratta di una condizione più oggettiva, sulla quale possiamo scegliere. Come sappiamo, la materia della scelta dev’essere una cosa «indifferente o buona in sé – dice sant’Ignazio – e che sia approvata dalla santa madre Chiesa gerarchica» (ES 170). Non si sceglie tra cose buone e cose cattive: si sceglie in chiave evangelica ciò che è migliore, ciò che permette di amare di più.
La materia della scelta è qualcosa di radicalmente personale
In realtà quest’orientamento generale non basta per scegliere, soprattutto se si tratta di decidere la riforma della propria vita. Per la materia della scelta, Ignazio pone, a chi fa gli Esercizi, un’altra condizione più personale e pratica, che deve accettare. L’esercitante dev’essere disposto a rivedere qualsiasi situazione di fatto in cui si trovasse per esserci arrivato «non in modo limpido o pienamente per amore di Dio» (ES 150; 174). Pertanto, se la prima condizione della materia è la sua generica indifferenza, la seconda sarà, per così dire, la sua «radicalità personale». Di questo parleremo a proposito della «santità» considerata come «materia di scelta».
Ciascuno deve trovare e scegliere l’elemento concreto – la materia – in cui Dio lo chiama a essere santo oggi. E a tale riguardo, c’è subito una tentazione di cui dobbiamo essere consapevoli. È quella che più di ogni altra svigorisce il desiderio di santità che il nostro Creatore ha scritto nei nostri cuori: la tentazione di considerare questa scelta in termini astratti.
Negli Esercizi tutto è concreto. Nella prima settimana, di preparazione remota alla scelta, Ignazio ci invita a concentrarci sulla radice della nostra vita: siamo creati e siamo peccatori. Creati non «in generale», ma ciascuno come figlio prediletto. Peccatori non «in generale», ma ciascuno come figlio prodigo o figlio ipocrita. Nella seconda settimana degli Esercizi, che è di preparazione prossima alla scelta e riforma della propria vita, Ignazio ci porta alla radice della richiesta di Cristo, alla sua bandiera, cioè alla nuda concretezza della croce. Il Signore chiama a seguirlo radicalmente in povertà e umiltà. Ne saranno segno concreto le umiliazioni subite o scelte per amore di Gesù umiliato. E nella terza settimana, quella della scelta o riforma di vita, sant’Ignazio ci invita ad andare alla radice del nostro stato attuale di vita, per scegliere quale sarà la materia concreta della nostra santità personale.
Possiamo affermare che questa santità si identifica con la beatitudine che il Signore ci propone ogni giorno come stile di vita, e con l’opera di misericordia che in ogni situazione ci viene proposta affinché decidiamo di metterla in pratica. È la «semplificazione evangelica» che papa Francesco opera costantemente, affermando che per essere santi bastano le beatitudini e quel protocollo della santità che troviamo in Mt 25, nel brano sul Giudizio finale.
Il realismo del «qui e ora»
Le beatitudini e le opere di misericordia hanno la grazia del «qui e ora». Mentre le si mette in pratica, ogni beatitudine e ogni opera di misericordia creano le proprie opportunità (kairoi) e aprono il proprio spazio – quello del Regno – affinché possiamo realizzarle pienamente.
Il Papa ce ne presenta un esempio stupendo, quello del card. François-Xavier Nguyên van Thuân: «Quando era in carcere, rinunciò a consumarsi aspettando la liberazione. La sua scelta fu: “Vivo il momento presente, colmandolo di amore”; e il modo con il quale si concretizzava questo era: “Afferro le occasioni che si presentano ogni giorno, per compiere azioni ordinarie in un modo straordinario”» (GE 17).
L’accento posto sul «momento» e sulla situazione sociale e culturale in cui ciascuno vive aiuta a far sì che la chiamata universale a essere santi entri in dialogo con la mentalità attuale, senza paura della cosiddetta «società liquida». Alcuni temono che le scelte fatte in modo «provvisorio» e «inculturato» siano più deboli, ma ciò non è del tutto vero. In questo caso forse la struttura concettuale s’indebolisce nelle sue caratteristiche universali astratte, ma si rafforza la libertà della persona, che è ciò che più importa. La libertà dell’amore che si traduce in opere conta più delle idee e degli schemi mentali con cui le cose vengono proposte o espresse. Per esempio, è un luogo comune affermare che i giovani non s’impegnano per tutta la vita. Questo è un falso problema. I condizionamenti culturali non esistono da oggi, ma ci sono sempre stati. Un tempo, però, si privilegiava la stabilità, mentre oggi si dà più importanza al cambiamento. In realtà, il Vangelo ci sfida sempre a vivere entrambe queste dimensioni della vita. Lo stesso Signore, che chiama a seguirlo senza condizioni, esorta i suoi discepoli a scegliere sempre di nuovo, a rinnovare la loro scelta di fronte a ogni situazione critica.
Dio ci vuole santi nella totalità della nostra vita
Quando il Papa ci indica come modello la vita di quanti hanno «scelto di essere santi», ha presente un aspetto di cui è bene che teniamo conto anche noi. Ci dice: «Questo è un forte richiamo per tutti noi. Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il posto che ciò occupa nella tua missione. E permettigli di plasmare in te quel mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi» (GE 23). Si tratta di essere sempre aperti – scegliendo sempre di nuovo la santità – al fatto che Dio ci vuole santi nella totalità della nostra vita. È questa la missione a cui è chiamato ciascuno di noi.
A questo discernimento del Papa soggiace il criterio secondo il quale il tutto è superiore alle parti. Dio ci fa santi «totalizzando» e non «frammentando», sia alla fine della nostra vita sia in ogni circostanza. Ne sono un esempio i sacramenti. Ogni volta che mi confesso, viene purificata tutta la mia vita con un atto di misericordia, che perdona tutti i miei peccati particolari e santifica tutto me stesso, non soltanto una parte di me. Lo stesso vale per la comunione: ogni volta che mi comunico faccio un’alleanza totale con il Signore; non entra in comunione con lui soltanto una parte di me stesso. L’amore ha la capacità di totalizzare la nostra vita in ogni atto, e lo fa sia quando gli diciamo «sì» nei nostri voti (matrimoniali o di vita consacrata), sia ogni volta che gli diciamo i molteplici piccoli «sì» delle opere di misericordia.
Il potere totalizzante e inclusivo di ogni beatitudine messa in pratica
Nel capitolo della Gaudete et exultate intitolato «Alla luce del Maestro» Francesco formula le espressioni «totalizzanti» della santità che incarna le beatitudini.
«Essere poveri nel cuore, questo è santità» (GE 70), afferma il Papa. E concretizza quell’«essere poveri in spirito» in ciò che Ignazio dice nel Principio e fondamento: «Non desiderare da parte nostra più la salute che la malattia, più la ricchezza che la povertà, più l’onore che il disonore, più la vita lunga piuttosto che quella breve, e così in tutto il resto (ES 23)» (GE 69). L’uomo deve preferire la volontà di Dio alla propria, spossessarsi di sé per essere aperto a ciò che Dio possa volere e, nel frattempo, mettere tutto il resto tra parentesi. Chi sceglie «ciò che Dio possa volere» sceglie di essere santo attraverso l’amore.
«Reagire con umile mitezza, questo è santità» (GE 7). Scegliere di essere santi vuol dire scegliere di reagire con mitezza. Si sceglie come reagire. Forse non è stato scelto il primo movimento dell’ira; ma poi si sceglie se moderarla o lasciarle briglia sciolta. Ed è qui che si gioca la santità. Afferma il Signore: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita» (Mt 11,29). Non dobbiamo essere duri e disprezzare gli altri; invece, quando guardiamo i limiti e i difetti degli altri con tenerezza e con mitezza, senza sentirci superiori, possiamo dare loro una mano ed evitiamo di sprecare energie in lamentele inutili. Per santa Teresa di Lisieux, «la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti altrui, non stupirsi assolutamente delle loro debolezze» (GE 72).
«Saper piangere con gli altri, questo è santità» (GE 76). Vediamo tante volte piccoli e innocenti soffrire e piangere. Basta guardarli negli occhi, guardare la loro situazione, e scorrono anche in noi lacrime di compassione. E si sceglie di aprirsi o di chiudersi a quelle lacrime, a quella pietà e a quella tenerezza di cuore.
«Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità» (GE 79). Cercare è «scegliere di cercare». Quella di lottare per la giustizia è un’opzione: l’opzione in favore dei più poveri, di quelli a cui non è resa giustizia.
«Guardare e agire con misericordia, questo è santità» (GE 82). Il nostro sguardo è «selettivo», lo sappiamo. Ciascuno di noi sceglie, «soggettivamente», che cosa vuole guardare. E ne consegue ciò che egli vede «oggettivamente». L’oggettività non è un’evidenza che s’imponga da sola. Ci sono cose che non si vedono a meno che ci si fermi a contemplarle a lungo, che ci si immedesimi nella situazione dell’altro. Per questo diciamo che «guardare con misericordia» è una scelta. E da questo sguardo nasce il sentimento di compassione, e poi l’agire con misericordia.
«Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità» (GE 86). Anche la purezza del cuore è un’opzione, che va sempre rinnovata. Bisogna scegliere di rinnovare la purezza dello sguardo, perché niente è più «influenzabile» del nostro sguardo. Esso prima osserva tutto ciò che è bello e buono per ogni senso, e poi muove il nostro cuore, che si affeziona ai beni che gli risultano apprezzabili. Scegliere che Gesù «ci lavi i piedi e ci mantenga il cuore puro» è scegliere di essere santi.
«Seminare pace intorno a noi, questo è santità» (EG 89). Seminare è scegliere: si sceglie la semente da seminare e il terreno dove seminarla. Anche seminare guerra è una scelta. Seminare non è una fatalità: lo sono le semine che si ereditano, non quelle che tocca fare a ciascuno.
«Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è santità» (GE 94). Anche qui c’è una scelta di vita. Dobbiamo fare attenzione: qui non si dice «accettare il Vangelo», ma «la via del Vangelo». La prima scelta suonerebbe astratta; invece, accettare la via che ogni giorno si apre davanti a noi è una scelta concreta e possibile.
Noi riconosciamo che le beatitudini sono le «scelte profonde» di Gesù. Egli ci invita a farle a nostra volta, come stile di vita e modo di sentire che scegliamo per soddisfare il «grande protocollo», – quello del capitolo 25 di Matteo –, con il quale verremo giudicati.
Questa scelta è più profonda dei risultati di ogni particolare azione, che potrà avere, e certamente avrà, i suoi «più» e i suoi «meno». Scegliere per la totalità delle beatitudini e delle opere di misericordia è l’opzione profonda, quella di Gesù e quella nostra dopo di lui: «Il testo di Matteo 25,35-36 non è un semplice invito alla carità: è una pagina di cristologia, che proietta un fascio di luce sul mistero di Cristo. In questo richiamo a riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di Cristo, i suoi sentimenti e le sue scelte più profonde, alle quali ogni santo cerca di conformarsi» (GE 96).
Scegliere di essere più santi è un’opzione che possiamo concepire soltanto se Gesù ci tende la sua mano e ci fa stare in sua compagnia in modo sempre più amichevole e intimo, finché giungiamo a non poter vivere lontani da lui, dalla sua presenza, dai suoi consigli, dal suo perdono e dalla sua parola. Scegliere di essere più santi ha il suo senso pieno in Cristo, e si capisce soltanto a partire da lui. Afferma Francesco: «In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i misteri della sua vita. […] La contemplazione di questi misteri, come proponeva sant’Ignazio di Loyola, ci orienta a renderli carne nelle nostre scelte e nei nostri atteggiamenti» (GE 20).
Esaminare come ci trasformiamo
Se essere santi viene concepito come una missione, non si tratterà più di un semplice «fare opere sante esteriori», ma piuttosto di «essere santificati dallo Spirito in tal modo che questa santità riverberi in opere». E implica «lasciarsi trasformare da Cristo».
Tale trasformazione ha uno strumento prezioso di verifica: la pratica abituale del bene, accertata nell’esame di coscienza. «Siamo liberi, con la libertà di Gesù, ma Egli ci chiama a esaminare quello che c’è dentro di noi – desideri, angustie, timori, attese – e quello che accade fuori di noi – i “segni dei tempi” – per riconoscere le vie della libertà piena: “Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono” (1 Ts 5,21)» (GE 168).
Questo «vagliare ogni cosa» non è tuttavia un esercizio scrupoloso, autoreferenziale, un guardare a se stessi, ma è un esaminarsi per «uscire» da se stessi verso l’amore di Dio e degli altri.
Ci sono tre grandi ambiti in cui il «vagliare ogni cosa» allarga il cuore. Il primo è quello delle novità di Dio. È importante esaminare bene «quando compare una novità nella propria vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio o una novità ingannatrice dello spirito del mondo o dello spirito del diavolo» (GE 168).
Il secondo ambito è lasciare che il Signore ci esamini, come fece con Pietro, sull’amore e sull’amicizia. Non dimentichiamo che «prima di ogni legge e di ogni dovere, quello che Gesù ci propone di scegliere è un seguire, come quello degli amici che si seguono, si cercano e si trovano per pura amicizia. Tutto il resto viene dopo, e persino i fallimenti della vita potranno essere un’inestimabile esperienza di questa amicizia che non si rompe mai» (CV 290).
Il terzo ambito è quello dell’umiltà. Afferma il Papa: «L’umiltà può radicarsi nel cuore solamente attraverso le umiliazioni. Senza di esse non c’è umiltà né santità. Se tu non sei capace di sopportare e offrire alcune umiliazioni non sei umile e non sei sulla via della santità» (GE 118). «Non mi riferisco solo alle situazioni violente di martirio, ma alle umiliazioni quotidiane di coloro che sopportano per salvare la propria famiglia, o evitano di parlare bene di sé stessi e preferiscono lodare gli altri invece di gloriarsi, scelgono gli incarichi meno brillanti, e a volte preferiscono addirittura sopportare qualcosa di ingiusto per offrirlo al Signore: “Se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio” (1 Pt 2,20)» (GE 119).
La migliore versione di me «per gli altri»
In questi tre ambiti – le novità evangeliche, l’amicizia e l’umiltà – si gioca la scelta ultima, cioè la scelta di «essere la migliore versione di me per gli altri». Afferma Francesco: «Questa vocazione missionaria riguarda il nostro servizio agli altri. Perché la nostra vita sulla terra raggiunge la sua pienezza quando si trasforma in offerta» (CV 254). E aggiunge: «Per realizzare la propria vocazione è necessario sviluppare, far germogliare e coltivare tutto ciò che si è. Non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, ma di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio essere: “Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione”. La tua vocazione ti orienta a tirare fuori il meglio di te stesso per la gloria di Dio e per il bene degli altri» (CV 257).
***
1. Cfr N. Steeves, «San John Henry Newman: fede, santità e immaginazione», in Civ. Catt. 2019 IV 163-176.
2. Fiorito utilizza questo «schema mentale», come lo chiama, per studiare analiticamente gli Esercizi senza romperne l’unità (cfr M. A. Fiorito, «Apuntes para una teología del discernimiento de espíritus [segunda parte]», in Ciencia y Fe 20 [1964] 83). Sulla figura di Fiorito e sulla sua influenza su papa Bergoglio, cfr J. L. Narvaja, «Miguel Ángel Fiorito. Una riflessione sulla religiosità popolare nell’ambiente di Jorge Mario Bergoglio», in Civ. Catt. 2018 II 18-29.