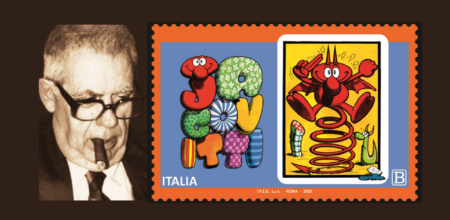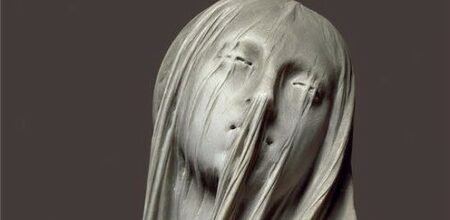|
|
Nei trattati di cristologia si mettono soprattutto in evidenza i titoli di gloria che caratterizzano la figura di Gesù: Figlio di Dio, Cristo, Salvatore del mondo. Meno visibili sono i titoli ingiuriosi che gli hanno affibbiato i suoi avversari. In effetti, volendo raccoglierli tutti, troviamo che Gesù è stato accusato di essere impostore, malfattore, mangione e beone, indemoniato, pazzo, blasfemo, sobillatore, di padre ignoto, samaritano. Anche questo fa parte di quello «svuotamento» al quale Cristo si è sottoposto, «umiliandosi fino alla morte, e alla morte di croce» (Fil 2,8).
Per non rimanere nel generico, vediamo nel dettaglio gli insulti che Gesù ha ricevuto, e come i suoi primi discepoli lo hanno imitato in questo suo abbassamento.
Quell’impostore!
Nei Vangeli, Gesù introduce quasi sempre la sua parola con l’espressione: «In verità, io vi dico», per evidenziarne l’importanza e la veracità. Questa espressione compare circa 30 volte in Matteo, 9 volte in Marco, 10 in Luca. Nel Vangelo di Giovanni, per 25 volte la parola è raddoppiata: «In verità, in verità io vi dico», ma è il concetto stesso di verità (alētheia) ad essere centrale nel Quarto Vangelo1. Gesù viene presentato come «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14), perché «la grazia e la verità vennero per Gesù Cristo» (Gv 1,17). Gesù invita a «fare la verità» (Gv 3,21), perché Dio, il Padre, deve essere adorato «in spirito e verità» (Gv 4,23-24). Conoscere la verità rende liberi (cfr Gv 8,32). Gesù si presenta come «un uomo che vi ha detto la verità», e per questo cercano di ucciderlo (Gv 8,40). Egli afferma solennemente: «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) e promette di inviare «lo Spirito della verità» (Gv 14,17; 15,26; 16,13).

Pregando per i suoi discepoli, chiede al Padre: «Consacrali nella verità. La tua parola è verità» (Gv 17,17), e vuole che essi siano «consacrati nella verità» (Gv 17,19). Davanti a Pilato, afferma: «Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» (Gv 18,37), e Pilato gli risponde in modo ironico: «Che cos’è la verità?» (Gv 18,38).
Persino alcuni avversari di Gesù riconoscono apertamente la sua veracità: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità» (Mc 12,14; cfr Lc 20,21). E anche uno scriba gli riconosce questa qualità: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità» (Mc 12,32).
Tuttavia, dopo la crocifissione e la sepoltura, i capi del popolo hanno il coraggio di accusare Gesù di impostura: «Signor Procuratore, ci siamo ricordati che quell’impostore (planos), mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni risorgerò”» (Mt 27,63). Un impostore è «uno che proferisce menzogne» (Pr 14,25), e «chi proferisce menzogne è testimone falso» (Pr 14,5), perché induce in inganno. Per questo i farisei non avevano accettato la testimonianza di Gesù, ritenendola falsa: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera» (Gv 8,13). In realtà, è il diavolo che, «quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44). Nel diavolo, infatti, «non c’è verità» (Gv 8,44), mentre lui, Gesù, dice la verità, ma non gli credono (Gv 8,45.46)2. Già durante il suo ministero Gesù era contestato nella sua veracità: «E si faceva un gran mormorare di lui tra la folla; gli uni dicevano: “È buono!”; altri invece dicevano: “No, ma inganna (plana) la gente!”» (Gv 7,12). È stata certamente una delle più grandi sofferenze morali di Gesù quella di essere preso per un impostore, un mentitore; Lui che è la Verità e che ha detto sempre il vero: «Se dicessi che non conosco [il Padre mio], sarei come voi un mentitore (pseustēs)» (Gv 8,55).
Al seguito di Gesù, anche gli apostoli sono mandati ad annunciare la buona notizia del Regno (cfr Lc 9,2), e questo annuncio è indissociabile dalla verità. L’apostolo Paolo è stato inviato per proclamare «la verità del Vangelo» (Gal 2,5; 2,14; Col 1,5) e a diffonderlo «con parola di verità» (2 Cor 6,7). Consapevole della fragilità umana, egli afferma di esercitare il suo ministero senza comportarsi «con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità» (2 Cor 4,2). Egli dice infatti: «Non abbiamo alcun potere contro la verità, ma per la verità» (2 Cor 13,8). Eppure anche lui è stato accusato di essere un «impostore», come i falsi profeti e i falsi apostoli3: «Siamo ritenuti impostori (planoi), eppure siamo veritieri (alētheis)» (2 Cor 6,8). Questa accusa rivolta a Paolo è forse una di quelle «spine nella carne» (cfr 2 Cor 12,7) che più lo hanno fatto soffrire.
Se non fosse un malfattore…
I Vangeli mostrano Gesù che, nell’annunciare il regno dei cieli, operava guarigioni, liberava dei demoni e, in una parola, faceva del bene. Prese da ammirazione per la bontà che usciva dalla sua persona, le folle dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!» (Mc 7,37). E poiché Gesù faceva il bene anche di sabato, è stato accusato di violare il comandamento. Egli però ribadiva che «è lecito in giorno di sabato fare del bene» (Mt 12,12), osservando che lo sdegno contro di lui era mal posto: «Voi vi sdegnate contro di me perché di sabato ho guarito interamente un uomo» (Gv 7,23). Infatti, fare il bene è proprio di Dio. Come diceva Paolo ai pagani di Listra: «Dio non ha mai cessato di dar prova di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori» (At 14,17).
Già il salmista invitava a ricordare Dio come un benefattore: «Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici» (Sal 103,2), e si chiedeva: «Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto?» (Sal 116,12). Gesù ha fatto vedere «molte opere buone (kala erga) da parte del Padre» (Gv 10,32) e associava il suo operare a quello del Padre: «Il Padre mio opera sempre e anch’io opero» (Gv 5,17). Facendo una sintesi dell’attività di Gesù, Pietro dice che egli «passò facendo del bene e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui» (At 10,38). Anche Matteo sintetizza il ministero di Gesù citando il profeta Isaia: «Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie» (Mt 8,17).
Bisognava allora essere accecati dall’invidia per presentare Gesù tutto al contrario di un benefattore, per dire davanti a Pilato: «Se costui non fosse un malfattore (kakon poiōn), non te l’avremmo consegnato» (Gv 18,30). E, in effetti, Gesù è giustiziato «con altri due malfattori (kakourgoi)» (Lc 23,32), adempiendo così la profezia di Is 53,12, citata da Gesù stesso: «Perciò vi dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: “E fu annoverato tra i malfattori (anomōn)”» (Lc 22,37). I Vangeli riportano che sono stati crocifissi due criminali, uno alla destra, uno alla sinistra, e Gesù nel mezzo (cfr Mt 27,38 e par.). La storicità di questo particolare può essere ben difesa, pensando che esso non è stato un gesto di riguardo per il condannato, ma di scherno. Probabilmente infatti gli altri due crocifissi facevano parte di quei rivoltosi che si erano macchiati di omicidio (cfr Mc 15,7). Barabba era uno di questi (cfr At 3,14), ma viene liberato su richiesta del popolo e Gesù ha preso il suo posto (cfr Mc 15,15). Visto il motivo ufficiale della condanna («Gesù Nazareno Re dei Giudei»), i soldati avranno detto: «Bene, allora mettiamo il re nel mezzo!».
Gesù aveva avvisato i suoi discepoli che avrebbero ricevuto una sorte simile, ma che non dovevano angustiarsi per questo, bensì rallegrarsi: «Beati voi quando […], mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia» (Mt 5,11). Dire male di uno significa designarlo come un malfattore, pur sapendo di mentire. I discepoli di Gesù hanno dovuto mettere in conto di poter essere condannati ingiustamente come malfattori. Questa è la sorte che è toccata a Paolo, il quale a causa del Vangelo ha dovuto «portare le catene come un malfattore (kakourgos)» (2 Tm 2,9).
«Ecco un mangione e un beone!»
Secondo i Vangeli di Matteo e Luca, Gesù ha iniziato il suo ministero pubblico con un digiuno di quaranta giorni (cfr Mt 4,2; Lc 4,2). Il digiuno era una delle pratiche tipiche della religiosità giudaica, e Gesù non la critica, ma invita solo a evitarne l’ostentazione (cfr Mt 6,16-18). Egli comunque non ne ha fatto una norma per la sua comunità, tant’è vero che si è attirato delle critiche: «I discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano: perché i tuoi discepoli non digiunano?» (Mc 2,18). Gesù ha risposto in modo enigmatico, dicendo che i suoi discepoli avrebbero digiunato «quando sarà loro tolto lo sposo» (Mc 2,20), alludendo alla sua morte di croce. In realtà, Gesù e i suoi discepoli sono presentati spesso seduti a tavola presso amici o dietro invito (cfr Mc 2,15 e par.; Lc 7,36), tanto che il Signore si è attirato l’accusa di essere «un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori» (Mt 11,19). Ma come il medico va dove ci sono i malati, così Gesù andava dove c’erano i peccatori (cfr Mt 9,12).
Cristo però non si è fermato a questo. Entrando in merito alla spinosa questione dei cibi puri o impuri, egli ha preso una posizione decisamente innovativa, dichiarando che «non è ciò che entra nell’uomo dal di fuori che lo rende impuro», «ma ciò che esce dal cuore», «dichiarando così puri tutti gli alimenti» (Mc 7,18-20)4. È probabile che questa lezione non sia stata subito recepita, perché i discepoli, da buoni giudei, hanno continuato a osservare quelle regole alimentari. Così Pietro, quando ha avuto la visione della tovaglia piena di animali ed è stato invitato a mangiarne, ha esclamato: «No, davvero, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di profano e di impuro» (At 10,14). Solo allora Pietro ha compreso che non si potevano discriminare le persone in base agli alimenti, perché Dio purifica i cuori di tutti «con la fede» (At 15,9). Comunque i giudeo-cristiani al concilio di Gerusalemme hanno ottenuto che si vietasse a tutti di cibarsi «di carni soffocate e del sangue» (At 15,20).
Paolo ha dovuto affrontare il problema delle carni provenienti da sacrifici idolatrici, e lo ha risolto dando libertà di coscienza (cfr 1 Cor 10,25; Rm 14,1-4). In ogni caso, la sua posizione è chiara e rispecchia quella di Gesù: «Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17). Dunque, «sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio» (1 Cor 10,31). Tuttavia, la vita dell’apostolo non è stata un confortevole adagiarsi nelle comodità, ma ha comportato «disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità» (2 Cor 11,27), così come lo stare «nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni» (2 Cor 6,5).
«E chi è tuo padre?»
Il Vangelo di Marco, ritenuto il più antico, non si interessa dell’origine umana di Gesù. Dice che ha una madre, di nome Maria (cfr Mc 5,3), che ha «fratelli e sorelle» (Mc 3,31-35), ma non parla mai del padre. L’unico padre che Gesù conosce è quello che nella preghiera chiama «Abbà, Padre!» (Mc 14,36). Gesù parla del Figlio dell’uomo che verrà «nella gloria del Padre suo» (Mc 8,38), e invita i discepoli a pregare «il Padre vostro che è nei cieli» (Mc 11,25).
Neppure di Giovanni il battezzatore è indicato il padre (cfr Mc 1,4)5, come invece è il caso di molti discepoli: Giacomo e Giovanni sono «figli di Zebedeo» (Mc 1,19-20; 3,17; 10,35); Levi è detto «figlio di Alfeo» (Mc 2,14); c’è anche un Giacomo, «figlio di Alfeo» (Mc 3,18). Invece, non si sa chi sia il padre dei fratelli Simone e Andrea (Mc 1,29)6. Di Giacomo il minore e di Ioses è indicata solo la madre, Maria (cfr Mc 15,40; 15,47); e in Mc 6,3 Giacomo e Ioses sono indicati come «fratelli» di Gesù, e quindi è chiaro che sono cugini. Inoltre, in Mc 16,1 Giacomo è chiamato figlio di Maria, confermando quanto detto prima. In conclusione, i dati forniti da Mc sulle varie paternità non sono sistematici, e quindi non si può ricavare nulla dal silenzio sul padre (vero o legale) di Gesù, se non che probabilmente al tempo del ministero pubblico quel padre era già morto.
Neppure il Vangelo di Giovanni si interessa direttamente del padre terreno di Gesù, ma sempre del Padre celeste, chiamato volentieri da Gesù «Padre mio» (cfr Gv 2,16 ecc.). Tuttavia, è riferita l’opinione della gente che egli fosse figlio di Giuseppe: «E dicevano: “Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come, dunque, può dire: Sono disceso dal cielo”?» (Gv 6,42). In effetti, questa allusione a una provenienza celeste poteva destare il sospetto di un’origine poco chiara: «Gli dissero allora: “Dov’è tuo padre?”. Rispose Gesù: “Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio”» (Gv 8,19). Ritroviamo qui il doppio livello di comprensione, tipico del Quarto Vangelo: i giudei gli chiedono del padre terreno, ma Gesù parla del Padre celeste. A questo punto, l’allusione malevola diventa esplicita: «Gli risposero allora: “Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!”» (Gv 8,41), ossia, come faranno in un’altra occasione, essi intendono dire: «Costui non sappiamo di dove sia» (Gv 9,29). La reazione di Gesù a questa insinuazione è piena di amarezza: «Perché non comprendete il mio linguaggio? […] Se dico la verità, perché non mi credete?» (Gv 8,42.46).
Forse per allontanare questa calunniosa interpretazione dell’origine terrena di Gesù, gli evangelisti Matteo e Luca hanno riportato in dettaglio il racconto del suo concepimento verginale, visto rispettivamente dalla parte di Giuseppe (Mt 1,18-25) e di Maria (Lc 1,26-38). Rimane il fatto che si è diffusa tra i giudei la calunnia di un’origine irregolare di Gesù7. Questa infamia si riversava evidentemente anche sulla madre. Luca la chiama «vergine» (Lc 1,27), e Matteo, citando Isaia – «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio» (Mt 1,23) –, sembra insinuare un duplice prodigio, sia nel concepimento sia nel parto. In ogni caso, la tradizione cristiana ha sempre sostenuto il concepimento verginale di Gesù e la prerogativa di Maria «sempre vergine»8.
«È impazzito!»
Durante la predicazione in Galilea, Gesù era così preso dalla folla che lui e i suoi discepoli «non avevano neppure il tempo di mangiare» (Mc 3,20). Allora i suoi, cioè quelli del suo clan, sono voluti andare a prenderlo, «perché dicevano: “È fuori di sé (exestē)» (Mc 3,21). Solo Marco cita questo particolare, che non è facile da spiegare e che si potrebbe tradurre con: «È impazzito!». Ciò denota che, almeno all’inizio, Gesù non è stato seguìto dai suoi familiari; anzi, come dice il Quarto Vangelo, «neppure i suoi fratelli credevano in lui» (Gv 7,5). Da questa incomprensione va però esclusa la madre, Maria, che troviamo con altre discepole ai piedi della croce (cfr Gv 19,25-27).
In un detto riportato da Matteo, definire qualcuno un «pazzo» è giudicato molto severamente: «Chi poi dice al fratello: “Stupido” (rhaka), dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo” (mōre), sarà destinato al fuoco della Geènna» (Mt 5,22). Nel Vangelo di Giovanni, un insulto simile è rivolto a Gesù dai giudei, i quali, fraintendendo le sue parole sulla volontà di «deporre la sua vita» (Gv 10,17-18) e interpretandole come un’aspirazione al suicidio, dicevano: «Ha un demonio ed è impazzito (mainetai)» (Gv 10,20). Essere pazzi equivaleva a essere indemoniati. Nel territorio dei gerasèni ce n’era uno che si aggirava nudo tra i sepolcri, gridando e percuotendosi con pietre. Dopo che Gesù lo ha liberato, gli abitanti di quella regione hanno visto «l’indemoniato seduto, vestito e sano di mente» (Mc 5,15).
A Cesarea, dopo aver ascoltato la testimonianza di Paolo, il procuratore Festo lo ha preso per pazzo: «Disse a gran voce: “Sei pazzo (mainēi), Paolo! La troppa scienza ti ha dato al cervello!”. Ma Paolo, “non sono pazzo (mainomai) ‒ disse ‒, eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge”» (At 26,24-25).
«Hai un demonio!»
La calunnia più grave che Gesù abbia mai ricevuto è senza dubbio quella di essere un indemoniato. Ne parlano tutti e quattro i Vangeli. Secondo Marco, l’accusa proveniva dagli scribi, che dicevano: «È posseduto da Beelzebùl», e: «Scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni» (Mc 3,22). Ciò equivaleva a designare il Figlio dell’uomo come «Satana» (cfr Mc 3,23). Gesù ha risposto a questa calunnia con una serie di argomentazioni che mostrano l’assurdità di una tale accusa (cfr Mc 3,24-27) e ha concluso con una sentenza solenne – «In verità, io vi dico» – che riguarda la bestemmia «contro lo Spirito santo», considerata un «peccato irremissibile» (Mc 3,28-29). Essi dicevano infatti: «Ha uno spirito impuro» (Mc 3,30). Questa dichiarazione sul «peccato irremissibile», riportata anche da Mt 12,31-32 e da Lc 12,10 con delle varianti, è una delle parole più dure che Gesù abbia mai pronunciato9.
Una tale accusa compare anche nel Quarto Vangelo. L’affermazione della folla: «Tu hai un demonio! Chi cerca di ucciderti?» (Gv 7,20), più che un giudizio temerario, sembra un modo per dire: «Tu sei pazzo!». Ma nel drammatico scontro del capitolo 8 l’accusa diventa esplicita: «Non diciamo con ragione noi che sei un Samaritano10 e hai un demonio?» (Gv 8,48). Avere un demonio significa esserne posseduti. Gesù ha risposto: «Non sono posseduto da un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate» (Gv 8,49). Al che, quelli ribadiscono: «Ora sappiamo che hai un demonio!» (Gv 8,52). Questa ingiuria ritorna in occasione di alcune parole di Gesù sull’offerta della propria vita (cfr Gv 10,17-18) che creavano dissenso: «Molti di essi dicevano: “Ha un demonio ed è impazzito; perché lo state ad ascoltare?”. Altri invece dicevano: “Queste parole non sono di un indemoniato (daimonizomenou); può forse un demonio (daimonion) aprire gli occhi dei ciechi?”» (Gv 10,19).
Se Gesù è il Santo, guidato sempre dallo Spirito Santo, e quindi inaccessibile al peccato (cfr Eb 4,15; Gv 8,46), non è così per i suoi discepoli, che sono invitati a vegliare e a pregare per non cadere sotto la tentazione (cfr Mc 14,38). Purtroppo, uno degli apostoli ha ceduto: «Allora Satana entrò in Giuda, detto Iscariota, che era uno dei Dodici» (Lc 22,3). Il Quarto Vangelo conferma: «Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui» (Gv 13,27). Satana, invero, aveva cercato di far cadere anche Pietro: «Simone, Simone, ecco, Satana ha cercato di vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,31-32). Già prima Pietro aveva rischiato di diventare «Satana», quando aveva cercato di distogliere Gesù dalla via tracciatagli dal Padre: «Lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini» (Mc 8,33). Anche Paolo mette in guardia contro i «falsi apostoli, operai fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo: ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce» (2 Cor 11,13-14).
«Ha bestemmiato! Sobilla il popolo!»
L’accusa di bestemmia viene rivolta a Gesù dapprima quasi sommessamente, in un contesto privato, dopo che egli, stando in casa, ha perdonato i peccati a un paralitico: «Alcuni scribi pensavano in cuor loro: “Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?”» (Mc 2,7; cfr Mt 9,3)11. Per la legge giudaica, la bestemmia era un reato gravissimo, meritevole di morte12. Tuttavia non c’è stata allora nessuna conseguenza immediata, ma tale accusa, aggiunta a quella di sedersi a mensa con i peccatori (Mc 2,15-17), di non praticare il digiuno (Mc 2,18-22), di non vigilare sull’osservanza del sabato (Mc 2,23-28) e infine di guarire in giorno di sabato (Mc 3,1-5), ha provocato di fatto una tacita condanna a morte: «Allora i farisei, usciti subito con gli erodiani, tennero consiglio contro di lui per farlo morire» (Mc 3,6).
L’occasione però per rendere ufficiale questa condanna c’è stata dopo l’arresto di Gesù e il processo davanti al sinedrio. Alla domanda del sommo sacerdote: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?» (Mc 14,61), Gesù ha risposto affermativamente, usando il linguaggio apocalittico (cfr Mc 14,62). L’affermazione di essere lui il Messia investito da Dio come giudice escatologico viene percepita come blasfema. A questo punto è scattata l’imputazione ufficiale: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?», a cui è seguita la condanna: «Tutti sentenziarono che era reo di morte» (Mc 14,63-64; cfr Mt 26,57-68). Da quel momento Gesù è stato trattato come un reo, oggetto di sputi e di percosse (Mc 14,65; Mt 26,67-68).
Il Quarto Vangelo non riporta questa fase del processo, ma afferma praticamente la stessa cosa in un altro contesto. Durante la festa della Dedicazione, Gesù ha pronunciato nel Tempio alcune parole che appaiono blasfeme ai giudei, i quali subito hanno raccolto pietre per lapidarlo, dando al loro gesto una giustificazione prettamente religiosa: «Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, fai te stesso Dio» (Gv 10,33). Gesù è rimasto meravigliato: «A colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: “Tu bestemmi!”, perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”?» (Gv 10,36). La bestemmia sta nel fatto che «fai te stesso Dio». C’era dunque l’intenzione di far morire Gesù a causa della blasfemia, ma misteriosamente in quella circostanza «egli sfuggì dalle loro mani» (Gv 10,39).
L’occasione propizia è avvenuta dopo il suo arresto e la sua condanna da parte del sinedrio. Tuttavia i giudei, non essendo autorizzati ad applicare la pena di morte («A noi non è consentito mettere a morte nessuno», Gv 18,31), si sono rivolti al governatore Ponzio Pilato. Non potendo esibire l’accusa di bestemmia – che non era reato per i romani13 –, hanno addotto un motivo politico, presentando Gesù come un pericoloso sobillatore del popolo. È il Vangelo di Luca che sottolinea bene questa accusa: «Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo Re» (Lc 23,2). E i giudei hanno insistito, sottolineando l’estensione dell’attività di Gesù: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui» (Lc 23,5). Pilato lo ha compreso bene: «Mi avete portato quest’uomo come sobillatore del popolo»(Lc 23,13), ma, dopo averlo interrogato sul suo essere «re» (cfr Gv 18,33-38), si è reso conto che non vi era nulla di perseguibile e che il vero movente dell’accusa era l’invidia (cfr Mt 27,18). Il compromesso viene trovato attorno al titolo di «re», titolo messianico per i giudei, titolo politico per Pilato14. Così alla fine, suo malgrado, Pilato ha decretato la condanna a morte di Gesù, ma, non avendo tra le mani nessun reato da addurre, l’ha giustificata come usurpazione del titolo di re (cfr Gv 19,12-16)15.
All’inizio della Chiesa, anche gli apostoli sono stati arrestati, perché la loro predicazione aveva troppo successo e quindi disturbava l’ordine pubblico (cfr At 4,1-22), con il pericolo di dare origine a gruppi eversivi (cfr At 5,34-42). Il caso di Stefano è singolare: accusato di aver pronunciato «espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio» (At 6,11), viene lapidato, senza l’intervento dell’autorità romana. Paolo stava per subire la stessa sorte, quando viene salvato da un tribuno romano (cfr At 21,31-33). Come per Gesù, anche in questo caso i giudei, per ottenere dai romani la condanna capitale, hanno dovuto mettere da parte i motivi religiosi (cfr At 24,20-21) e ricorrere all’accusa di sedizione. Perciò hanno ingaggiato un avvocato romano di nome Tertullo, che ha formulato questa precisa accusa: «Abbiamo scoperto che quest’uomo è una peste, fomenta continue rivolte tra tutti i giudei che sono nel mondo ed è a capo della setta dei Nazorei» (At 24,5). E Paolo, per salvarsi dai giudei che lo volevano morto (cfr At 23,12), ha fatto appello a Cesare (cfr At 25,9-12).
Podcast | SIRIA. «LA SITUAZIONE ECONOMICA È CATASTROFICA»
Le incognite sul futuro di milioni di rifugiati, le città devastate da anni di guerra e una pace ancora fragile. A raccontarci da Damasco come sta vivendo questo momento di incertezza la popolazione siriana è p. Vincent de Beaucoudrey S.I., direttore del Jesuit Refugee Service in Siria.
Oltraggiato, non rispondeva
Che Gesù sia stato ricoperto di insulti, soprattutto al momento della sua passione, risulta non soltanto dai Vangeli, ma anche dal resto del Nuovo Testamento. Marco sottolinea una serie di vilipendi che hanno accompagnato la crocifissione di Gesù: «I passanti lo insultavano (eblasphēmoun) […]; ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi si facevano beffe di lui (empaizontes); e anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano (ōneidizon)» (Mc 15,29-32; cfr Mt 27,39-44). Luca aggiunge nello scherno anche i soldati (Lc 23,36). La cosa notevole è che Gesù non ha mai risposto a quegli insulti, come ricorda la Prima lettera di Pietro: «Oltraggiato (loidoroumenos), non rispondeva con oltraggi» (1 Pt 2,23). Parimenti, anche l’apostolo Paolo doveva essere stato a conoscenza di tali oltraggi, perché scrive, citando il Sal 68,10: «Cristo infatti non cercò di piacere a sé stesso, ma come è scritto: “Gli insulti (oneidismoi) di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me”» (Rm 15,3).
Anche in questo caso, Gesù ha predetto la stessa sorte ai suoi discepoli: «Beati voi quando vi insulteranno (oneidisōsin)» (Mt 5,11). Luca rincara la dose: «Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno (oneidisōsin) e respingeranno il vostro nome come scellerato (ponēron), a causa del Figlio dell’uomo» (Lc 6,22). E questa beatitudine è ripresa da Pietro: «Beati voi, se venite insultati (oneidizesthe) per il nome di Cristo» (1 Pt 4,14).
Conclusione
La spiritualità cristiana, soprattutto quella medievale, si è molto soffermata su queste «ingiurie» ricevute da Cristo, facendone oggetto di meditazione, nel contesto della imitatio Christi. Così molti autori, accogliendo l’invito della Lettera agli Ebrei, hanno tenuto fisso lo sguardo su Gesù, che «in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l’ignominia» (Eb 12,2). All’inizio dell’evo moderno, sant’Ignazio di Loyola si è presentato quale erede di questa spiritualità: «Per imitare e assomigliare più attualmente a Cristo nostro Signore, voglio e scelgo […] ignominie con Cristo pieno di esse piuttosto che onori; e desidero essere stimato insensato e folle per Cristo, il quale per primo fu ritenuto tale, piuttosto che saggio e prudente in questo mondo» (Esercizi spirituali, n. 167). È significativa l’insistenza con la quale Ignazio ritorna su questo tema: «Io voglio e desidero ed è mia ferma determinazione […] imitarti nel sopportare ogni ingiuria e vituperio» (ivi, n. 98)16.
Copyright © 2023 – La Civiltà Cattolica
Riproduzione riservata
***
1. Cfr I. de la Potterie, La verità di Gesù. Studi cristologia giovannea, Torino, Marietti, 1973.
2. Nell’Apocalisse di Giovanni, il Diavolo o Satana è presentato come «l’ingannatore (ho planōn) di tutta la terra abitata» (Ap 12,9; cfr 20,10). Ma anche chi nega la realtà dell’Incarnazione, «costui è l’impostore (ho planos) e l’anticristo» (2 Gv 7).
3. L’invito a guardarsi dall’inganno dei falsi profeti e dei falsi cristi è costante nei Vangeli (cfr Mt 24,4-5; Mc 13,5; Lc 21,8). C’è il pericolo che persino gli eletti rimangano ingannati (cfr Mt 24,24). Anche Paolo mette spesso in guardia dall’inganno, soprattutto in campo morale (cfr 1 Cor 6,9; 15,33; Gal 6,7).
4. Questa non è una parola di Gesù, ma una deduzione dell’evangelista, ovvero della prima comunità. Ma la cosa è talmente contrastante con la mentalità giudaica che non può essere uscita dalla mente di un discepolo.
5. Ma Lc 1,13 dice che Giovanni è figlio di Zaccaria.
6. Ma Mt 16,17 chiama Simon Pietro «figlio di Giona o Giovanni» (Gv 1,42).
7. Origene, Contro Celso I, 32, riporta l’opinione di un giudeo secondo il quale la madre di Gesù sarebbe stata ripudiata dal falegname che l’aveva desiderata in sposa, in quanto «era rimasta incinta di un soldato di nome Pantera». Quanto questa diceria fosse diffusa tra i giudei è cosa discussa. Cfr E. Norelli, «La tradizione sulla nascita di Gesù nell’Alethès lògos di Celso», in L. Perrone (ed.), Discorsi di verità, Paganesimo, giudaismo e cristianesimo a confronto nel «Contro Celso» di Origene, Roma, Augustinianum, 1998, 133-169.
8. Anticamente, solo alcuni eretici hanno pensato che Gesù fosse nato dall’unione di Maria con un uomo, Giuseppe, e che Maria avesse avuto da lui altri figli.
9 . Non è qui il caso di elencare tutte quelle varianti. È comunque una sentenza che ha fatto molto discutere i commentatori. Così la spiega la Bibbia di Gerusalemme (Bologna, EDB, 2009): «Attribuire al demonio ciò che è opera dello Spirito Santo, significa sottrarsi alla luce della grazia divina e al perdono che ne proviene. Un simile atteggiamento colloca per necessaria conseguenza al di fuori della salvezza. Ma la grazia può cambiare questo atteggiamento; diventa allora possibile un ritorno alla salvezza» (p. 2400).
10. È l’unica volta che si trova questo epiteto, considerato come un insulto. Infatti i samaritani per composizione etnica e per religione erano considerati «spuri» dai giudei.
11. La bestemmia o blasfemìa non era solo un insulto rivolto direttamente contro Dio, ma anche qualsiasi affermazione che intaccasse la signoria e l’unicità di Dio.
12. Cfr Lv 24,16: «Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte: tutta la comunità lo dovrà lapidare. Straniero o nativo della terra, se ha bestemmiato il Nome, sarà messo a morte».
13. Per il diritto romano, deorum iniuriae diis curae: «Che delle ingiurie agli dèi si occupino gli dèi».
14. Cfr G. Jossa, La condanna del Messia, Brescia, Paideia, 2010, 195-198.
15. Sarebbe simile alla adfectatio regni, cioè al reato previsto dal diritto romano che consisteva nell’attentare alla costituzione repubblicana, cercando di restaurare la monarchia.
16. Ignazio immagina che sia Gesù stesso a invitare i suoi «servi e amici» «al desiderio di obbrobri e disprezzi» (cfr Esercizi spirituali, n. 146). E in un colloquio con la Madre del Signore, le fa chiedere di «ottenere grazia dal suo Figlio e Signore di essere ricevuto sotto la sua bandiera, […] nel sopportare obbrobri e ingiurie, per più imitarlo in essi» (ivi, n. 147). E in una nota aggiuntiva, propone di «desiderare ingiurie e obbrobri ed essere umiliato in tutto con Cristo, per rivestirsi della sua livrea e imitarlo in questa parte della sua croce» (Direttorio autografo, n. 23). Questa «imitazione di Cristo», propria degli Esercizi spirituali, che sono aperti a tutti, diventa l’aspirazione specifica dei compagni e seguaci di Ignazio, il quale chiede loro di «desiderare con tutte le forze possibili quanto Cristo nostro Signore ha amato e abbracciato», e quindi chiede loro se sono pronti «a subire ingiurie, false testimonianze, affronti, ed essere ritenuti e stimati pazzi (senza però darne occasione alcuna), spinti dal desiderio di rassomigliare e di imitare in qualche misura il nostro Creatore e Signore Gesù Cristo, rivestendosi della sua veste e divisa» (Costituzioni della Compagnia di Gesù. Esame generale, n. 44).