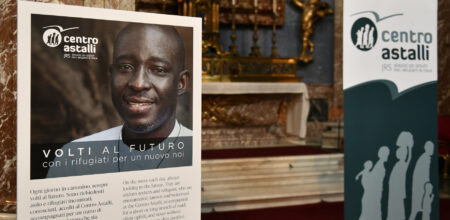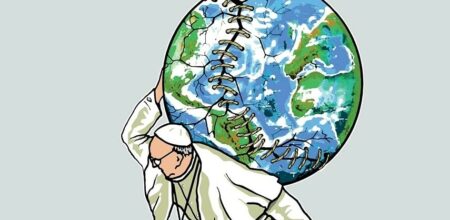|
|
Per secoli, e dal tempo della stesura dei Vangeli, i cristiani hanno cercato di esprimere come il mistero di Dio si manifestava nella persona di Gesù, che essi riconoscevano come Cristo, e come Gesù, volto perfettamente somigliante al Padre, rivelava la natura intima di Dio, il Dio unico d’Israele. Questo non era un compito facile, in quanto mancavano parole e concetti. Come mantenere la sostanza della fede monoteista, pur riconoscendo una forma di complessità all’interno stesso della divinità? Come mantenere l’affermazione della perfetta umanità di Gesù – «egli ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana», dice la Preghiera eucaristica IV –, senza per questo indebolire la confessione della sua divinità?
Questo delicato lavoro teologico era – e continua a essere – indispensabile e fondamentale. Pur restando fedele ai Concili e alla tradizione della Chiesa, ciascuna generazione cristiana ha il compito di esprimere con parole proprie, nel proprio contesto culturale, la sostanza della fede cristiana: Dio ha rivelato l’essenza del suo essere, si è comunicato perfettamente e totalmente nella persona di Gesù di Nazaret. Per non ripetere, senza troppo comprenderle, formule sempre più antiche, dobbiamo ribadire in continuazione la meraviglia che proviamo di fronte al mistero – in fondo inesprimibile, ma che dobbiamo cercare di tradurre in parole il meno goffamente possibile – di Gesù Cristo.
Molti sono gli approcci e i procedimenti possibili. A noi sembra che, per affrontare tale compito, occorra sempre ripartire dall’uomo Gesù, dall’evento Cristo. E non solo da quello che egli era, ma anche da come egli stesso si comprendeva con le sue parole e i suoi riferimenti. Dobbiamo ripartire dalla cristologia di Gesù.
Gesù, un ebreo praticante
Gesù ha pensato la propria identità a partire dalle risorse che erano a sua disposizione nell’ambito della sua fede e del suo contesto culturale, il pio giudaismo galileo di lingua aramaica. Un giudaismo ricco di tradizioni e pratiche rituali, che disponeva dei salmi e del culto sinagogale, basato sulla lode e sulla lettura delle Scritture. Essere uomo, infatti, vuol dire sempre pensare la propria individualità, il senso della propria vita e il proprio destino in un dato contesto religioso e culturale. Questo è costitutivo di ogni essere umano. Ci si deve dunque interrogare sui testi, sulle preghiere e sulle credenze che hanno formato, per così dire, «la grammatica» a partire dalla quale si è sviluppata gradualmente la fede personale di Gesù[1]. Più scopriamo il mondo religioso e culturale del I secolo, più ci avviciniamo a Gesù.
Il ritrovamento dei manoscritti di Qumran è stato una tappa importante in questo cammino di riscoperta della varietà dei gruppi ebraici dell’epoca. Abbiamo acquisito anche maggiore consapevolezza della ricchezza della produzione religiosa scritta durante il cosiddetto «periodo intertestamentario». Alcuni temi teologici erano diventati molto significativi, come quello della persecuzione dei profeti, e così veniamo informati sul mondo teologico a cui Gesù aveva accesso. Egli si recava nella sinagoga, e non ha mai smesso di farlo. Saliva al Tempio per le feste, e non ha mai smesso di andarci. Aveva imparato a leggere e conosceva le Scritture, che era in grado di citare[2]. Sia le Beatitudini sia la preghiera del «Padre nostro» hanno molti punti in comune con testi biblici e preghiere ebraiche dell’epoca. Riconoscerlo non significa affatto negare l’originalità di esse, ma al contrario riuscire a vederla meglio. È così che Gesù appare unico per il posto che ha dato all’insegnamento con le parabole, come pure unico nel suo modo di riunire in sé la figura di taumaturgo-esorcista e quella di rabbino insegnante. Gesù era profondamente inserito nel suo pio ambiente ebraico della Galilea, e questo gli ha fornito sia i suoi schemi di pensiero sia i suoi primi discepoli.
La relazione con Giovanni Battista
In secondo luogo, occorre sottolineare un fatto indiscutibile e importante: Gesù si è definito inizialmente in relazione alla persona di Giovanni Battista, una figura storica evidente. Nel seguito della sua vita non ha mai negato questo rapporto e si è sempre riferito a esso. Questo è un elemento che potrebbe essere utilizzato maggiormente a livello cristologico; la sua ricchezza, infatti, è stata a lungo sottovalutata. Gesù non ha lesinato le sue lodi per Giovanni: «In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista» (Mt 11,11a). È estremamente rivelatore il fatto che Gesù abbia iniziato la sua vita pubblica andando a trovare il Battista. Egli ascoltava ciò che Dio voleva dire a Israele, e cercava dove potesse manifestarsi l’azione divina. Lo cercava fuori di sé, in un movimento di decentramento che continua a destare la nostra meraviglia.
Se ci fu un tempo in cui la richiesta di Gesù di farsi battezzare da Giovanni, come un ebreo tra gli altri, mettendosi in mezzo ai peccatori, rappresentava un motivo di imbarazzo per i cristiani, oggi questo fatto ci appare sempre più come un segno dell’umiltà e del decentramento di Gesù. Egli sapeva discernere i segni dei tempi, i segni dell’azione di Colui che egli chiamava suo Padre, e questa azione passava attraverso Giovanni. L’opera di Gesù è inseparabile da quella di Giovanni e incomprensibile senza il legame con lui.
Gesù riprenderà il messaggio di Giovanni e sceglierà i suoi primi discepoli tra quelli del Battista. Non rinuncerà mai al suo legame con Giovanni e al fatto che il primo criterio per giudicare il suo tempo consisteva nel riconoscere che Giovanni era stato mandato da Dio. Lo ripeterà dopo il suo ingresso finale a Gerusalemme, quando, interrogato sulla sua autorità, la collocherà nel prolungamento di quella di Giovanni: «E, mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: “Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farle?”. Ma Gesù disse loro: “Vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi”. Essi discutevano fra loro dicendo: “Se diciamo: ‘Dal cielo’, risponderà: ‘Perché allora non gli avete creduto?’. Diciamo dunque: ‘Dagli uomini’?”. Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: “Non lo sappiamo”. E Gesù disse loro: “Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose”» (Mc 11,27-33). Pertanto, non si può riconoscere Gesù senza riconoscere Giovanni. E nessuno potrà ormai annunciare Gesù senza parlare di Giovanni. I due Vangeli più recenti – quelli di Luca e di Giovanni – non sminuiscono il ruolo del Battista, come ci si potrebbe aspettare con il passare del tempo, ma al contrario lo rivalutano ancora di più.
Gesù però ha scoperto il proprio cammino e non ha copiato quello di Giovanni. Ha iniziato il proprio cammino andando verso «le pecore perdute della casa d’Israele» (Mt 15,24). Si è dedicato al tempo stesso a guarire e istruire le folle che venivano a lui e a formare un gruppo di discepoli, che ha scelto simbolicamente in numero di dodici, per esprimere con un gesto eloquente che stava parlando a tutto Israele. E ha cominciato a parlare di sé usando, ripetutamente e in modo un po’ misterioso, l’espressione «Figlio dell’uomo». L’aveva fatto mai qualcuno prima di lui? Cosa dice questa espressione dell’identità di Gesù e del suo rapporto con il Padre?
L’enigma del Figlio dell’uomo
Per chiarire questo enigma, ci è di aiuto uno scritto che, fino a poco tempo fa, ci era pervenuto solo nella sua versione etiope: il libro di Enoch. Ora sappiamo che ne esisteva un’antica versione aramaica, perché frammenti di questo libro sono stati trovati nelle grotte di Qumran. Perché il libro di Enoch è così suggestivo? Perché ci parla della posterità del tema del Figlio dell’uomo, che è così importante per avvicinarsi all’autocomprensione di Gesù. Infatti, se ci atteniamo agli scritti biblici propriamente detti, solo il libro di Daniele evoca questa figura originale, fortemente associata all’umanità nel suo stesso nome e che tuttavia mostra attributi divini, in particolare quelli di cavalcare le nubi del cielo e di giudicare la terra (cfr Dn 9,13; Enoch 46,2-3).
Come afferma lo storico delle religioni Daniel Boyarin, «ebrei all’epoca di Gesù aspettavano un Messia al tempo stesso umano e divino, il Figlio dell’Uomo, un’idea derivata da Dn 7»[3]. Lo studioso mostra chiaramente che alcuni redattori del libro di Daniele non erano d’accordo con l’individualizzazione della figura del Figlio dell’uomo e s’impegnarono per la sua relativa cancellazione. Il dibattito è continuato all’epoca di Gesù, probabilmente in circoli ristretti e devoti. Il capitolo 48 del libro di Enoch è una bella anticipazione di molti temi che si troveranno nei Vangeli. Ciò che è frustrante per noi è il fatto che non sappiamo nulla degli eventuali gruppi religiosi che stanno dietro a tale letteratura, mentre abbiamo un’idea più chiara dell’esistenza degli abitanti di Qumran e della comunità più ampia che difendeva quel luogo.
Detto questo, anche se vari studiosi sostengono che un certo numero di esseni sarebbe diventato cristiano dopo il 70 – e la cosa sembra probabile, dato che la comunità cristiana condivideva con loro così tante attese –, tuttavia non ne abbiamo alcuna documentazione archeologica o testuale. Un punto interessante e suggestivo per un lettore dei Vangeli è il fatto che il libro di Enoch evoca la figura del Figlio dell’uomo, ma senza identificarla con Enoch. Tale identificazione avviene solo alla fine del libro, nei capitoli 70 e 71 (cfr Enoch 71,14).
Ciò non vuol dire che Gesù non porti alcuna novità. Con lui arriva un’affermazione inaudita e nuova: egli è, qui e ora, l’atteso Figlio dell’uomo. Ciò che faceva parte della speculazione escatologica viene detto che si compie «oggi». Osserva Boyarin: «In contrasto con Enoch, che sarà il Messia-Figlio dell’uomo negli ultimi giorni, Gesù lo è già. In contrasto con il Figlio dell’uomo che viene sulle nubi, che è una visione per il futuro, i Vangeli e i credenti che si riferiscono a lui dicono che Gesù è venuto. Il Vangelo proclama che gli ultimi giorni sono già adesso. Tutte le idee sul Cristo sono antiche: la novità è Gesù»[4]. Possiamo anche notare che i Vangeli conservano il tema del Figlio dell’uomo che viene sulle nubi del cielo in una cornice escatologica, ma è chiaro che qui si tratta della seconda venuta – quella che avverrà nella gloria – di Gesù Figlio dell’uomo (cfr Mc 13,26).
Per secoli gli israeliti hanno discusso su chi sarebbe stato il Messia, sul suo possibile legame con la discendenza di Davide, sui suoi rapporti con il misterioso «Figlio dell’uomo» di Daniele o con il non meno enigmatico «Servo» evocato da Isaia. Gesù si è inserito in questa discussione e ha scelto la sua chiave di lettura. Allo stesso tempo, la sua decisione di seguire il Battista mostra che egli era attento non soltanto alle Scritture e alle profezie del passato, ma anche, e soprattutto, al presente, a ciò che Dio voleva dire al suo popolo «qui e ora».
La sintesi di Gesù
Sebbene sia molto difficile, se non impossibile, distinguere con certezza ciò che nei Vangeli risale al Gesù storico da ciò che proviene dall’opera teologica delle prime comunità e degli evangelisti, tuttavia è possibile fare alcune osservazioni[5]. Dal materiale raccolto dalla tradizione emerge chiaramente che Gesù ha preso le distanze dal titolo di «Messia». In Marco, egli accetta questo titolo solo alla fine del suo cammino, quando viene interrogato dal Sommo Sacerdote (cfr Mc 14,62). D’altra parte, si rivela molto chiaramente la sua preferenza per il titolo «Figlio dell’uomo», che appare espresso solo da lui e che quasi subito scomparirà dalla tradizione cristiana: infatti, esso è totalmente assente in Paolo.
Perché a Gesù piaceva tanto questo termine enigmatico? Possiamo formulare un’ipotesi osservando il modo abituale in cui egli si esprime. Gesù usa volentieri il linguaggio parabolico per evocare ciò che è al centro del suo messaggio: il regno di Dio. La scelta di questo stile indica che egli intende lasciare ai suoi ascoltatori la libertà di interpretazione e si rifiuta di prescrivere o di ordinare alla maniera di un sovrano o di un inviato che si fregerebbe di un «titolo». Nelle Scritture, infatti, l’uso delle parabole spetta ai personaggi secondari o senza potere (cfr Gdc 9 o 2 Sam 12). Ora, sia in aramaico sia in ebraico, il titolo «Figlio d’uomo» o «Figlio dell’uomo» è ambigua. Può essere un modo abituale di riferirsi a un semplice essere umano. Dio si rivolge così al profeta Ezechiele, senza che il titolo sembri avere un valore onorifico (cfr Ez 2,1; 3,1 ecc.). Questa espressione ritorna in un passo importante per Gesù, nella descrizione del pastore mandato da Dio per prendersi cura delle sue pecore (cfr Ez 34)[6]. Ma essa forse può riferirsi alla misteriosa figura escatologica presentata da Daniele. Tutto si gioca in un piccolo articolo che può passare inosservato: «Figlio d’uomo» o «Figlio dell’uomo»? Questa è la domanda che Gesù pone ellitticamente ai suoi interlocutori.
L’uso di tale espressione consente quindi a Gesù di mostrare una relativa discrezione della sua persona, pur lasciando ascoltare – a chi ha orecchi per ascoltare – l’intensità della relazione unica che lo lega a Dio. Inoltre, è sorprendente il fatto che Gesù usi questa espressione alla terza persona. Egli rivela così una cristologia di ambiguità volontaria e di discrezione. «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!» (Mc 4,9). La scelta di Gesù del titolo «Figlio dell’uomo» non soltanto indica il suo desiderio di sfuggire a etichette troppo facili (come quella di «Messia»), sovradeterminate da aspettative molto – troppo – «politiche», ma esprime anche, più degli altri titoli, la sua convinzione di essere unito in modo assolutamente unico e inseparabile a Dio, tanto questa figura è associata all’autorità stessa di Dio, al suo giudizio e al suo trono. Gesù quindi non può essere separato dallo Spirito Santo e da Dio, e la sua persona può essere messa in relazione con il Giudizio finale: «Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi» (Lc 9,26).
I dati dei Vangeli indicano che Gesù ha effettuato una sorta di «triangolazione» fra tre termini delle Scritture di Israele che qualificano un personaggio salvifico che si presenterà in futuro. C’è innanzitutto il termine «Messia», che Gesù accetta quando Pietro lo riferisce a lui (cfr Mc 8,29; Mt 16,16 e Lc 9,20), ma che egli riqualifica subito, spiegando così la sua missione: «Il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto» (Mc 8,31). C’è poi l’espressione «Figlio dell’uomo», che si ricollega al libro di Daniele (cfr Dn 7,13-14). Tuttavia un problema nasce dal fatto che in nessuna parte del libro di Daniele si fa menzione di eventuali sofferenze che tale personaggio, che cavalca le nubi del cielo e a cui viene conferita la regalità, dovrebbe sopportare. Il legame tra le sofferenze e il Messia-Figlio dell’uomo sembra dovuto all’aggiunta di un terzo termine: quello del «Servo sofferente», descritto dal profeta Isaia nel quarto canto del Servo (cfr Is 52,13–53,12). Di lui si dice che, «quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo». E ancora: «Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità» (Is 53,10-11). In questa figura enigmatica risaltano due elementi molto importanti: il Servo non offre la sua vita solo per Israele, ma anche per la moltitudine degli uomini; e, d’altra parte, il suo cammino passa attraverso l’accettazione volontaria della sofferenza e della morte.
Sorge allora una domanda: Gesù è stato il primo a fare una lettura messianica di tale personaggio? Dopo la scoperta dei manoscritti di Qumran, alcuni hanno creduto di vedere un’allusione a questo testo biblico nel modo in cui il «Maestro di giustizia» – colui che si suppone sia stato il fondatore di questo movimento di rinnovamento sacerdotale d’Israele – concepiva il suo ruolo. I testi però sono ambigui, e non sembra che quella persona abbia conosciuto una morte violenta. La novità della cristologia originale di Gesù si trova pertanto non nell’ereditare i tre termini – tutti e tre tratti dalle Scritture e dalla loro rilettura contemporanea –, ma nella loro singolare combinazione.
Se si riconosce la possibilità che Gesù stesso abbia fatto il collegamento fra queste tre figure, fra queste tre rappresentazioni della Scrittura in attesa di un loro compimento, si può forse avere un’idea dei mezzi di cui si è servito per fare tale collegamento? In primo luogo, egli ha certamente meditato a lungo sui passi della Scrittura che si prestavano a una lettura di tipo messianico. In secondo luogo, essendo inserito nel cuore della realtà ebraica della terra d’Israele di allora, Gesù poteva conoscere speculazioni del suo tempo, di cui testimonia la letteratura enochica, e alcuni scritti intertestamentari, come il libro dei Giubilei (che sembra citato in Lc 11,49 e Mt 23,34). In terzo luogo, Gesù era convinto che il destino di tutti i profeti, di tutti i messaggeri di Dio, fosse quello di essere perseguitati dallo stesso popolo a cui erano stati inviati, secondo il tema teologico, molto diffuso all’epoca, della «persecuzione dei profeti». D’altronde, non c’è bisogno di essere dotti per capire che i potenti cercano sempre di mettere a tacere coloro che si fanno paladini dei piccoli e dei senza voce. La morte violenta del suo maestro Giovanni Battista, ordinata dal re Erode, non poteva che confermare Gesù in questa convinzione teologica.
Da qui possiamo trarre una prima conclusione: se è vero che tutti gli evangelisti hanno sviluppato una propria strategia narrativa e scelto di mettere in risalto alcuni testi biblici piuttosto che altri, pur volendo affermare indiscutibilmente la divinità di Gesù, resta il fatto che essi sono rimasti sostanzialmente fedeli all’ermeneutica biblica originale del loro maestro. Ossia, gli evangelisti fanno di Gesù innanzitutto un «Figlio dell’uomo», un uomo rivolto verso i piccoli e gli ultimi della società, che non antepone una pretesa identità divina – identità certamente confessata senza riserve dalla fede degli evangelisti –, tanto è impegnato ad affermare che tutti gli esseri umani sono «figli di Dio»[7]; un servo che ha voluto offrire la propria vita per tutti, per le «pecore perdute della casa d’Israele» (Mt 15,24), certo, ma anche per «le moltitudini» (cfr Is 53,11-13); insomma, un ebreo profondamente credente, esperto delle Scritture e che aveva compreso nella preghiera di essere l’Inviato degli ultimi tempi, un Figlio dell’uomo che accetta la missione del Servo sofferente prima di essere il Figlio dell’uomo che viene «sulle nubi con grande potenza e gloria» (Mc 13,26).
Il fatto stesso che i primi cristiani abbiano abbandonato molto presto questo titolo – che essi non comprendevano più veramente – è un argomento forte a favore della sua storicità. È attingendo alle fonti della tradizione vivente di Israele che Gesù ha compreso la propria missione e la propria vita. Per definirsi e presentarsi ai suoi fratelli, egli ha fatto alcune scelte originali, ma che si inscrivevano nelle potenzialità sia dei testi biblici sia delle realtà e delle convinzioni spirituali degli ebrei del suo tempo.
Gesù si è mostrato diffidente verso gli appellativi definitivi al suo riguardo, ed estremamente riluttante a vedersi conferire titoli o etichette. Questi infatti lo tradivano almeno quanto lo rivelavano. Egli ha chiaramente scelto di valorizzare un sistema di riferimenti incrociati, basato sulla coerenza tra le sue parole e le sue azioni. Voleva che i suoi insegnamenti e le sue guarigioni parlassero più forte delle tante voci, anche positive, che circolavano su di lui. Voleva che coloro che lo incontravano decidessero da soli chi egli fosse per loro. Gesù era al tempo stesso un uomo tra gli uomini, un israelita tra i suoi fratelli e qualcuno che pensava di svolgere un ruolo determinante nel piano salvifico di Dio e di vivere in una relazione unica con questo Padre-Abbà. Riconoscere che Dio agiva per mezzo di lui significava necessariamente essere molto vicini al Regno: «Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio» (Lc 11,20).
La cristologia del Figlio dell’uomo
Qual è l’importanza di questa cristologia del Figlio dell’uomo? Certamente essa ci aiuta a diventare sempre più consapevoli del fatto che Gesù era radicato nel patrimonio religioso e testuale del popolo ebreo. Ma la posta in gioco è ancora più grande. Ne va della natura stessa della fede cristiana. Il rischio, per il cristianesimo, è di diventare una «religione» come le altre, con i suoi riti e i suoi dogmi, dimenticando che si tratta fondamentalmente di un rinnovamento spirituale all’interno di una religione esistente; che l’uomo che ne è all’origine non ha avuto affatto l’idea o il desiderio di «fondare una religione», ma di incarnare una nuova tappa nel piano di un Dio – il Dio d’Israele – il cui progetto lo precedeva.
Il cristianesimo è un movimento escatologico, radicale, spirituale. Lo si è anche considerato un isaianismo, una presa sul serio delle promesse del profeta Isaia, o piuttosto dei discepoli di questo profeta. Ma non è solo in Isaia che Gesù trova la sua ispirazione: egli fa una rilettura e una sintesi – al tempo stesso estremamente personale e profondamente radicata – dell’insieme delle Scritture.
Come il popolo cristiano costituisce una sorta di «popolo al quadrato», tanto è composto da esseri umani provenienti da tutti i popoli della Terra e senza che venga soppressa la loro appartenenza culturale, così il cristianesimo costituisce una «religione al quadrato», una religione che ha senso solo in quanto esprime il desiderio di fare di più, di vivere della carità stessa di Dio. Come indica questa frase – terribilmente esigente, quando ci si pensa – del primo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 5,20). Il cristianesimo presuppone un’interiorizzazione della Torah, la convinzione che è giunto il tempo di vivere come il Messia, imitando le qualità stesse di Dio: il perdono, il dono di sé, l’uscita radicale da se stessi. Presuppone un impegno spirituale totale. Vuole essere una rivoluzione all’interno e a partire da una religione, e non un’altra religione.
In sostanza, ai cristiani piacerebbe avere una religione come quella di tutti gli altri: una religione per così dire «tranquilla», basata sull’osservanza di un certo numero di regole e sulla pratica di un certo numero di riti. Ma il fuoco spirituale che Gesù incarnava ha poco a che vedere con questa realtà prosaica. In effetti, c’è una grande difficoltà: come mantenere una tensione escatologica, un’esigenza spirituale radicale, un amore per tutto Israele (simboleggiato dai Dodici apostoli), e al tempo stesso la convinzione che è giunto il momento per l’apertura dei tesori della conoscenza dell’unico, vero Dio a tutti i confini della Terra? «Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio» (Lc 13,29).
Durante la sua vita, Gesù si era limitato a visitare pochi villaggi nella sua regione di Galilea, con qualche incursione – soprattutto in occasione delle feste – in Giudea, e con alcuni rari soggiorni in terra pagana (forse per sfuggire in qualche modo alla pressione della folla). Ma la sua convinzione era che il Padre agiva per la salvezza dell’intera sua creazione, e non solo per il bene di Israele. Il che, del resto, in un contesto messianico escatologico, non avrebbe veramente senso. Gesù invita a entrare in una relazione unica con Colui che egli chiama «Abbà», «Padre», e che cambia il senso di tutta la nostra vita. Ormai, «chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà» (Mc 8,35).
Il modo in cui Gesù collega una cristologia «bassa», della discrezione, giocando sull’espressione ambigua «Figlio dell’uomo», con una cristologia «alta», escatologica, sottolineando il suo legame unico con il Padre, apre una prospettiva per la Chiesa di oggi: essa non deve esitare a passare attraverso l’umanità del Cristo per evidenziarne la credibilità umana e spirituale, senza però rinunciare in alcun modo al fatto che questo stesso Gesù si riconosceva legato in modo unico ed eccezionale al disegno del Padre per il presente e per il futuro dell’intera umanità. Che questo Figlio dell’uomo doveva essere giustamente riconosciuto come Signore e Figlio di Dio.
Podcast | SIRIA. «LA SITUAZIONE ECONOMICA È CATASTROFICA»
Le incognite sul futuro di milioni di rifugiati, le città devastate da anni di guerra e una pace ancora fragile. A raccontarci da Damasco come sta vivendo questo momento di incertezza la popolazione siriana è p. Vincent de Beaucoudrey S.I., direttore del Jesuit Refugee Service in Siria.
Conclusione
La cristologia di Gesù è un’opera che non finirà mai. Ma cercare, oggi come ieri, di capirla sempre di più è uno dei compiti di ogni futura cristologia. Si resta ammirati per la libertà spirituale di un uomo incredibilmente libero chiamato Gesù: un uomo che ha preso radicalmente sul serio il suo nome – «Dio salva» –, senza però metterlo mai in risalto; un uomo che, per esprimere il cuore della sua fede più intima e personale, ha scelto il termine «Abbà» che, per quanto aramaico, apriva a un’esperienza universale di ogni essere umano che si riconosce figlio. Gesù ci mostra così che soltanto se ci si riceve totalmente da Dio si può ricevere totalmente se stessi. La sua cristologia è un percorso di umanizzazione in quanto è un percorso di fede. La sua massima attenzione per gli altri derivava da questa sua totale abnegazione.
La sua scelta dell’espressione «Figlio dell’uomo» riflette la sua profonda umiltà e, più ancora, il suo assoluto decentramento da se stesso. Questo è ciò che una cristologia successiva ha rischiato di occultare, mettendo direttamente in bocca a Gesù stesso affermazioni che confessano la sua identità divina. Affermazioni vere nell’ordine della fede, ma pericolose per il riconoscimento onesto e sincero della sua umanità. Gesù è un uomo che, per parlare di sé, ha scelto volutamente un’espressione aperta, dinamica, enigmatica, che spettava ai suoi ascoltatori determinare, grazie allo Spirito che veniva loro donato: un’espressione che aveva il grande pregio di collocare Gesù al tempo stesso al livello di uomo, di ogni uomo, e al livello di Dio. Siamo felici di poter ancora riflettere su di essa con rinnovata intensità.
[1]. Cfr H.-U. von Balthasar, La foi du Christ, Paris, Aubier, 1968;
J. Guillet, La foi de Jésus Christ, Paris, Mame-Desclée, 1980 (in it., La fede di Gesù Cristo, Milano, Jaca Book, 1982).
[2]. Cfr Mc 2,25; 4,12; 7,6; 10,7.19; 11,17; 12,10.26.36; 14,27. È possibile che alcune citazioni risalgano ai primi apostoli e agli evangelisti, ma sarebbe sorprendente che questo sia il caso di tutti i riferimenti fatti dal Gesù dei Vangeli.
[3]. Cfr D. Boyarin, Le Christ juif, Paris, Cerf, 2013, 92.
[4]. Ivi, 121.
[5]. Per le considerazioni seguenti, cfr M. Rastoin, «Comment les trois premiers évangélistes ont-ils nommé Jésus?», in R. Dupont-Roc – A. Guggenheim (edd.), Après Jésus. L’invention du christianisme, Paris, Albin Michel, 2020, 355-362.
[6]. È sorprendente che, in questo capitolo, Dio parla talvolta di mandare un pastore come Davide (cfr Ez 34,23) e talvolta di venire di persona (cfr Ez 34,11).
[7]. Cfr M. Rastoin, «Jésus: Un “Fils de l’Homme” tourné vers les “Fils de Dieu”. Un nouveau regard sur Mt 11,27 et Lc 10,22», in Nouvelle Revue Théologique 63 (2017) 355-369.