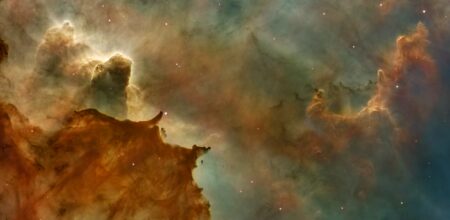|
|
P. Stan Swamy (Stanislaus Lourduswamy) è un gesuita indiano. Ha 83 anni e ha dedicato la vita allo sviluppo integrale degli adivasi[1] in varie aree dell’India settentrionale. Nativo del Tamil Nadu, ha scelto di servire le missioni settentrionali ed è entrato nella Provincia dei gesuiti di Jamshedpur. Da quasi 20 anni è a Ranchi, un fulcro della vita e del mondo degli adivasi, cattolici e non cattolici.
I missionari gesuiti belgi, venuti a operare in quest’area, verso il 1880 iniziarono a fornire conoscenze e assistenza legale agli adivasi. Ne seguì che questi iniziarono a vincere cause sul diritto alla terra contro i proprietari nei tribunali locali (quella zona era in mano agli inglesi, come gran parte dell’India); e migliaia di loro iniziarono ad abbracciare il cattolicesimo. Sebbene sia meno nota, la fioritura di questa missione è paragonabile a quella realizzata da san Francesco Saverio in Giappone. Constant Lievens (1856-93), detto «l’apostolo di Chotanagpur», ha operato in questi territori soltanto per sette anni, prima di soccombere alla tubercolosi. Per lui è in corso la causa di beatificazione.
Nel campo oggi noto come «tutela dei diritti territoriali», i missionari gesuiti hanno svolto un ruolo importante nella promulgazione del Chotanagpur Tenancy Act (1908) e di altre misure analoghe in tutto il Paese. In sintesi, secondo queste leggi «britanniche», gli adivasi detengono i diritti di proprietà sulla terra, e ai non adivasi è vietato possedere o acquistare terreni nelle «aree definite» in cui gli adivasi costituiscono la maggioranza. Queste leggi territoriali hanno molto aiutato gli adivasi a mantenere la proprietà delle loro terre e, pur riviste e attenuate, sono tuttora in vigore. Ma in quest’epoca, caratterizzata dalle privatizzazioni e dalle multinazionali, con il pretesto dello sviluppo sia il governo federale sia le aziende tentano di cambiare le leggi, al fine di impadronirsi dei territori degli adivasi, che sono ricchi di minerali e di altre risorse naturali.
Ci siamo dilungati in questa introduzione per aiutare i lettori a capire l’operato di p. Swamy e i motivi del suo arresto. Egli difende gli adivasi, li aiuta a far valere la loro dignità e i loro diritti e a esercitare la responsabilità, schierandosi al loro fianco nel contrastare quei processi di «sviluppo» che finirebbero per distruggerne la cultura e l’esistenza.
L’arresto di p. Swamy
L’8 ottobre 2020 p. Swamy è stato arrestato, nella città di Ranchi, dalla National Investigation Agency (Nia, un’agenzia federale che ha un grande potere). È accaduto a Bagaicha, centro di ricerca e formazione dei gesuiti dedicato all’istruzione e all’emancipazione degli adivasi. La notizia è riecheggiata in India e in diverse parti del mondo. La stampa locale e mondiale ha riferito gli eventi; diversi canali televisivi vi hanno dedicato dibattiti e talk show. Sono apparsi molti comunicati di condanna, che chiedevano il rilascio di p. Swamy: a firmarli, tra gli altri, sono stati la Conferenza episcopale cattolica indiana (Cbci), vari Consigli episcopali degli Stati, uffici e istituzioni dei gesuiti, eminenti politici e intellettuali e, più recentemente, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).
In tutta l’India si sono svolte – e ancora si svolgono – manifestazioni in forma pacifica, alcune molto affollate nonostante i timori e le restrizioni dovuti al Covid-19. Esponendo striscioni con la scritta «StandwithStan», i manifestanti – laici, membri del clero e religiosi, arcivescovi e vescovi, politici e parlamentari, studiosi, attivisti per i diritti, scrittori, poeti, storici, adivasi e cittadini comuni – si sono uniti in un appello per l’immediata scarcerazione di p. Swamy.
Nonostante p. Swamy avesse collaborato con le agenzie investigative – per prima cosa gli avevano sequestrato il laptop e altri documenti, poi nel luglio e agosto 2020 erano passati a un interrogatorio che si è protratto per 15 ore in una sequenza di cinque sessioni –, nonostante la sua età avanzata e le malattie di cui soffre, e nonostante fossero stati loro ricordati gli attuali divieti di viaggio imposti per il Covid-19, l’8 ottobre i funzionari della Nia hanno prelevato p. Swamy e il giorno successivo lo hanno portato a Mumbai. Un tribunale speciale ha ordinato che rimanesse in custodia fino al 23 ottobre. Ma il 22 ottobre la sua richiesta di libertà provvisoria è stata respinta e la sua detenzione è stata prolungata. P. Swamy è stato trattenuto insieme ad altre 15 persone sotto indagine: attivisti per i diritti umani, avvocati, scrittori, giornalisti ecc.
Sono tutti accusati di essere coinvolti nell’incidente di Bhima-Koregaon. Il 1° gennaio 2018, un numeroso gruppo di dalit («oppressi», definiti in passato «intoccabili») si era riunito in quella località per celebrare il secondo centenario della vittoria dei loro antenati contro i membri delle caste superiori. Ma la commemorazione è sfociata nella violenza, causando un morto e vari feriti. Le 16 persone incarcerate sono accusate di incitazione alla violenza, in forma diretta o indiretta, attraverso scritti, discorsi e azioni di supporto. P. Swamy ha negato di essere stato a Bhima-Koregaon, così come di aver saputo che quell’evento avrebbe avuto luogo e di averlo sostenuto in alcun modo. Lo stesso hanno fatto gli altri imputati, affermando che si trattava di un’accusa inventata per comprometterli poiché avevano messo in discussione le politiche del governo.
C’è un’altra accusa che accomuna p. Swamy e gli altri imputati: quella di avere legami con i maoisti. Si tratta in concreto dei naxaliti, un gruppo armato e violento, dedito alla guerriglia, che afferma di lottare per riscattare i poveri, combattendo le disuguaglianze e le ingiustizie. Secondo gli accusatori essi sono antinazionalisti. P. Swamy ha respinto l’accusa che gli è stata rivolta, affermando di avere sempre rispettato la Costituzione indiana, di essersi impegnato per garantire i diritti umani e territoriali degli adivasi in conformità con le leggi nazionali e di essersi sempre avvalso, per le sue proteste, di mezzi gandhiani non violenti.
L’impegno di p. Swamy a favore degli adivasi
Quale scopo aveva l’impegno di p. Swamy, probabile motivo del suo arresto? Egli stesso ha descritto la sua vita e la sua missione in un articolo intitolato «Se mi schiero per i diritti degli adivasi divento un deshdrohi?»[2], ripubblicato su The Wire.in il 9 ottobre 2020: «Negli ultimi due decenni mi sono identificato con il popolo adivasi e con la sua lotta per una vita dignitosa e rispettosa di sé. Da scrittore, ho cercato di analizzare i diversi problemi che essi si trovano ad affrontare. In questo percorso ho espresso chiaramente il mio dissenso, alla luce della Costituzione indiana, riguardo a diverse politiche e leggi emanate dal governo. Ho messo in dubbio la validità, la legalità e la giustizia di diverse azioni del governo e della classe dirigente».
Perché l’azione di p. Swamy mette a disagio i detentori dell’autorità, del potere e della ricchezza? Egli mostra che la Costituzione indiana conferisce agli adivasi uno status e dei privilegi particolari, richiama le sentenze della Corte suprema che ne favoriscono le ragioni e sostiene cause nei tribunali per liberare migliaia di giovani adivasi che oggi sono in prigione perché privi di sostegno e di assistenza legale.
In parole povere, p. Swamy difende gli adivasi e dà fastidio ai potenti, ai proprietari terrieri e alle aziende. In un videomessaggio diffuso pochi giorni prima del suo arresto, ha dichiarato di essere consapevole di ciò che stava facendo e del prezzo che gli sarebbe costata quella sua posizione: «Quello che mi sta succedendo non è un caso isolato. È un processo più ampio che si sta verificando in tutto il Paese. Tutti sappiamo che autorevoli intellettuali, avvocati, scrittori, poeti, attivisti, leader studenteschi vengono imprigionati soltanto perché hanno espresso dissenso o hanno messo in questione i poteri forti che operano in India. Quindi siamo parte del processo. In un certo senso, sono felice di far parte di questo processo, perché non ne sono uno spettatore silenzioso ma un componente attivo, sono in gioco e pronto a pagarne il prezzo, quale che sia».
P. Swamy può rallegrarsi del fatto che molte persone, in India e all’estero, chiedano la sua liberazione. Si può dire, in questa situazione, che i cattolici indiani siano pienamente consapevoli dell’esistenza di quello che potremmo definire un «momento Stan», e del fatto che esso li stia aiutando a trovare la loro voce profetica? Nel corso della storia la Chiesa cattolica indiana, attraverso i suoi vari ministeri e le prese di posizione assunte, quando è stato necessario, si è battuta per la dignità dell’uomo, i diritti umani e l’affermazione dei valori costituzionali. In questo senso, l’arresto di p. Swamy e la risposta della Chiesa non rappresentano un caso isolato; tuttavia la situazione è molto particolare, perché ciò accade in un momento in cui l’India sta attraversando cambiamenti senza precedenti, in cui la diversità e la pluralità – che finora sono stati valori indiscussi della nazione – vengono minacciate e, probabilmente, si è giunti a un bivio, segnato dalla preoccupazione che sia in gioco l’idea stessa dell’India[3].
La vocazione profetica della Chiesa
La Chiesa svolge la sua missione di annuncio del Vangelo e di celebrazione dei sacramenti, ma per molti indiani essa coincide esclusivamente con le opere di carità e di servizio. La maggior parte delle persone ne ammirano e apprezzano l’azione nel campo dell’istruzione, in quello sanitario e nelle opere sociali. Tuttavia, l’opinione pubblica reagisce diversamente quando esponenti della Chiesa, in particolare sacerdoti e religiosi, si dedicano ad attività di promozione della dignità umana e dei diritti umani. Sono iniziative che possono contrariare la mentalità di quanti sostengono e perpetuano la scala gerarchica e traggono beneficio da strutture sociali ingiuste. Promuovere gli adivasi, i dalit e altri come loro è rischioso, e p. Swamy lo fa da decenni.
In queste circostanze, la Chiesa cattolica è chiamata a trovare la sua voce profetica. Tutti i cristiani, per vocazione, sono chiamati a essere profeti. Ma quando avviene che essi consapevolmente crescano nell’azione profetica, la Chiesa può certamente riconoscere che si tratta di un momento opportuno, un kairos. Si potrebbe, a giusta ragione, sostenere che l’esempio e la missione di p. Swamy abbia risvegliato il dibattito tra ampie fasce di cattolici in India sull’impegno e la disponibilità di ogni battezzato a correre rischi nella propria vita in nome della fede in Gesù. In altre parole, se una parte dei cattolici indiani, specie alcuni membri del clero e i religiosi, inizia a riflettere e dice: «Perché non ero accanto a Stan?», e: «Da ora in poi mi impegnerò a stare dove è stato lui», si può dire che l’impegno di p. Swamy abbia generato discorsi teologici e spirituali ispiratori e stimolanti. Sebbene sia importante innalzare cartelli con la scritta «Io sto con Stan», probabilmente c’è bisogno di maggiore coraggio ed energia spirituale per affermare che «Io sono Stan» o «Io sarò Stan». Innalzare un cartello che riporta la prima affermazione è certamente apprezzabile, ma condividere la seconda richiede convinzioni più profonde: impegno e disponibilità a correre rischi nella vita, proprio come ha fatto p. Swamy.
Quando si ascoltano le voci o si leggono gli scritti di altre persone, ci si accorge che questo impegno di p. Swamy ha generato un dibattito molto significativo tra ampie fasce di cattolici nel Paese. Ha cominciato ad aiutare i cattolici a trovare la propria voce. Alla luce della vita e della missione di p. Swamy, il discorso ha iniziato a precisarsi su tre fronti: 1) le persone che serviamo; 2) i collaboratori che scegliamo; 3) i poteri che siamo destinati ad affrontare e a cui opporci.
P. Swamy ha scelto di servire gli adivasi, che, secondo Harsh Mander, sono «i più oppressi tra gli indiani». Non ha cercato in essi dei potenziali convertiti. Li ha portati sotto uno stesso ombrello e li ha aiutati a scoprire la dignità loro conferita da Dio e a rivendicare la libertà e i loro diritti. Li ha spinti a rendersi conto che Dio ci ha creati tutti per la libertà e che qualsiasi catena, imposta a chiunque, va spezzata.
Forse non tutti hanno adivasi nel proprio quartiere o nella propria circoscrizione, ma di sicuro non mancano persone che si trovano in situazioni analoghe. L’impegno di p. Swamy aiuta i cattolici a prendere coscienza del fatto che esistono persone e contesti simili, e a vedere ciò che le trattiene in quella condizione e ciò che va fatto per liberarle. Questo suo prodigarsi, inoltre, fa sì che un maggior numero di cattolici apra gli occhi e veda che cosa sta accadendo nel Paese e che cosa sta succedendo al Paese.
Il fenomeno non è del tutto sconosciuto, ma abbiamo bisogno che qualcuno lo mette in luce affinché il quadro risulti più chiaro. P. Swamy ha parlato di «processi» che oggi cercano di riplasmare l’India, basandosi su un progetto molto diverso da quello che avevano in mente Gandhi, Nehru, Patel, Tagore e da ciò che avevano previsto Ambedkar e gli altri estensori della Costituzione indiana. C’è bisogno di una fede e di una speranza più forti che mai per credere che Dio è più grande e più potente delle forze oscure del mondo che oggi stringono questo Paese, e che la volontà e l’immaginazione collettiva delle persone certamente prevarranno. È il momento di ricordare gli iconici occhiali di Gandhi. Insieme agli altri indiani, i cattolici del Paese possono decidere di indossarli.
Copyright © 2020 – La Civiltà Cattolica
Riproduzione riservata
***
STAN SWAMY’S ARREST. The need for a prophetic church
In India, the Church is appreciated for its action in the fields of education, health care and social work; however, public opinion reacts differently when Church leaders, especially priests and religious, engage in activities promoting human dignity and human rights. This is the case of Stan Swamy, an 83-year-old Jesuit, who for decades has dedicated himself to defending the rights of the Adivasis, who are «the most oppressed among the Indians», and for this reason he has recently been arrested. Stan’s example can fire the imagination of the Catholic Church and allow it to discover its prophetic vocation.
***
[1]. «Adivasi» è il nome di una minoranza tribale indigena: significa «abitanti originari», aborigeni; tuttavia in India la gente e i governi utilizzano più abitualmente il termine «tribali».
[2]. Deshdrohi significa «antinazionale».
[3]. Cfr G. Sale, «L’India di Modi: tra tradizionalismo induista e coronavirus», in Civ. Catt. 2020 II 457-470.