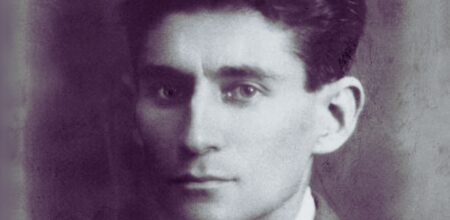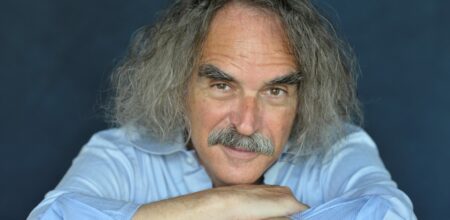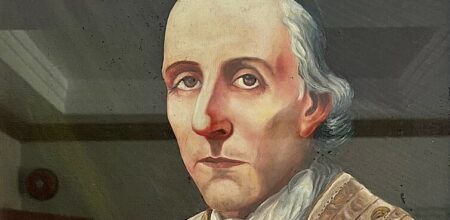Siamo a un secolo di distanza dalle prime elezioni fasciste dell’aprile 1924, che legittimarono non solo il nuovo governo guidato da Benito Mussolini, ma anche il «dominio» del fascismo sull’Italia e sulla vita degli italiani. Da quel momento nacque il cosiddetto «partito-Stato», che per vent’anni identificò le sue sorti con quelle della patria. Mentre Mussolini, con la Marcia su Roma del 1922, andò al potere con una sorta di pseudo-colpo di Stato, approvato dal re e da gran parte della classe politica liberale, il fascismo si impossessò delle leve del Paese, utilizzando uno strumento tipico delle democrazie liberali: le elezioni politiche. In questo modo guadagnò, anche con l’uso del sopruso e della violenza contro gli avversari politici, la fiducia di gran parte degli italiani, e diede al nuovo ordinamento una verniciatura di legittimità formale.
Dopo l’approvazione della nuova legge elettorale, la cosiddetta «Legge Acerbo», votata dal Parlamento italiano il 18 novembre 1923, tutto sembrava ormai predisposto per l’indizione di nuove elezioni generali[1]. Infatti, i maggiori attivisti politici si attendevano che Mussolini da un momento all’altro chiedesse al re lo scioglimento della Camera e del Senato regio, tanto più che egli non aveva richiesto la proroga dei pieni poteri concessagli un anno prima.
Sebbene Mussolini avesse imposto che la nuova legge elettorale adottasse un quorum molto basso – il 25% – per guadagnare la maggioranza dei seggi in Parlamento, non intendeva certamente accontentarsi di una vittoria così «risicata» per governare il Paese. Il semplice raggiungimento del quorum indicato dalla Legge Acerbo sarebbe equivalso per lui a una mezza sconfitta davanti all’opinione pubblica italiana e internazionale. Ciò che il duce voleva raggiungere nella successiva consultazione elettorale era invece una vera e propria investitura popolare del suo mandato di governo: questo lo avrebbe liberato dalle manovre dei partiti di opposizione o da quelle ancora più insidiose della Corona, e avrebbe oltremodo rafforzato la sua posizione di leader indiscusso all’interno di un partito turbolento e portato alla radicalizzazione dello scontro politico, quale era quello fascista.
Mussolini non desiderava che le elezioni si riducessero a una semplice «conta» dei voti fascisti, ancora modesti. Voleva invece che gli elettori fossero chiamati a pronunciarsi – quasi con un voto plebiscitario – sulle attività svolte dal suo governo in un anno e mezzo di vita. Egli insomma intendeva rivolgere il suo appello non soltanto ai fascisti della prima o dell’ultima ora, ma anche a tutti i moderati del Paese,
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento