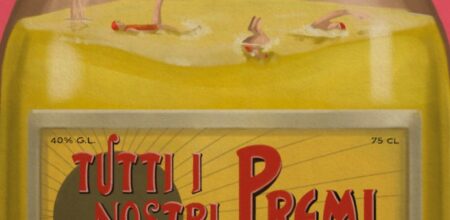È uscito in questi mesi un corposo volume di Evandro Agazzi, che può essere considerato un punto di arrivo delle molteplici ricerche e interessi della sua vita personale e accademica[1]. Qualche parola di presentazione dell’autore può forse aiutare ad apprezzare il valore del libro che ci accingiamo a esaminare.
Evandro Agazzi (1936), dopo la laurea in filosofia (Milano) e in fisica (Salerno), ha continuato gli studi specializzandosi in filosofia della scienza (Oxford) e in logica matematica (Münster). È stato in seguito docente di filosofia teoretica, filosofia della scienza e logica matematica (Milano), matematica, geometria e logica (Genova), logica simbolica (Pisa), bioetica (Città del Messico). Poi ha insegnato queste discipline in diverse altre università sparse per il mondo (Friburgo, Düsseldorf, Berna, Pittsburgh, Ginevra, Stanford), svolgendo nel contempo molti altri incarichi. Anche la sua produzione è estremamente ricca; possiamo menzionare solo gli ultimi titoli in lingua italiana: L’oggettività scientifica e i suoi contesti (2014), L’uomo nell’era della tecnoscienza (con G. Bellini, 2020), La conoscenza dell’invisibile (2021).
Il progressivo sbriciolarsi dell’identità umana
Impossibile rendere conto della ricchezza dei contenuti presentati nel libro, che può considerarsi una vera e propria summa sul tema, entrando in merito alle problematiche più diverse (metafisica, storia della scienza, evoluzionismo, neuroscienze, intelligenza artificiale, etica, morte, rapporto teologia-religione), svolte con chiarezza e competenza.
Il titolo del libro appare a prima vista perlomeno curioso. C’è davvero bisogno di dimostrare l’esistenza dell’uomo? In realtà, questo è ciò di cui tutti abbiamo esperienza. Ma fin dai primi capitoli del libro ci si rende conto che questa cosa non è affatto paradossale.
La copertina del volume di Agazzi.
L’ipotesi di fondo della ricerca è che l’antropologia attuale abbia conosciuto una sorta di regressione rispetto al pensiero dei primi filosofi – quella che egli chiama «la fase pre-socratica» –, che hanno concepito l’uomo in termini naturalistici, non considerando la sua dimensione spirituale, che invece emerge in maniera chiara a partire da Socrate[2]. Ma gli autori di quel tempo, essendo agli inizi del sapere filosofico, non avevano tematizzato tale dimensione; l’epoca attuale tende invece a escluderla in maniera più o meno esplicita, trovandosi però nell’impossibilità di dare risposta a una serie di problematiche fondamentali che riguardano la morale, il significato della vita, la speranza, la morte, la sessualità, la dignità dell’uomo. Ma, soprattutto, si scontra con la difficoltà di rispondere alla questione di fondo: cosa o chi è l’uomo? Si tratta di una domanda irrinunciabile, sulla quale ci
Contenuto riservato agli abbonati
Vuoi continuare a leggere questo contenuto?
Clicca quioppure
Acquista il quaderno cartaceoAbbonati
Per leggere questo contenuto devi essere abbonato a La Civiltà Cattolica. Scegli subito tra i nostri abbonamenti quello che fa al caso tuo.
Scegli l'abbonamento