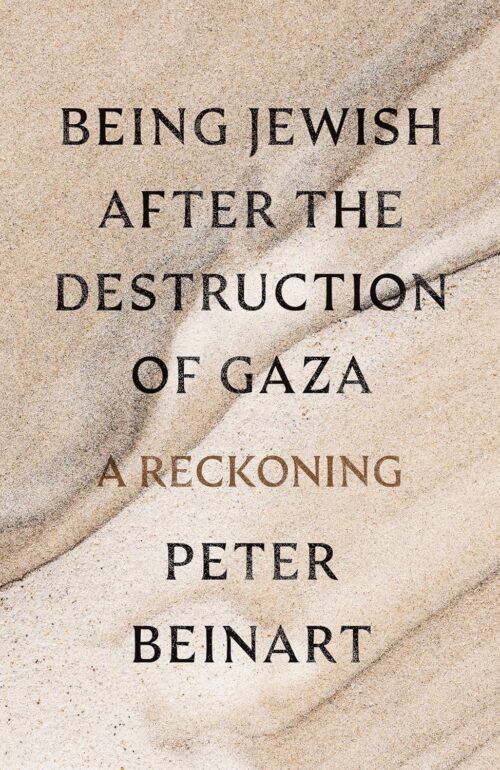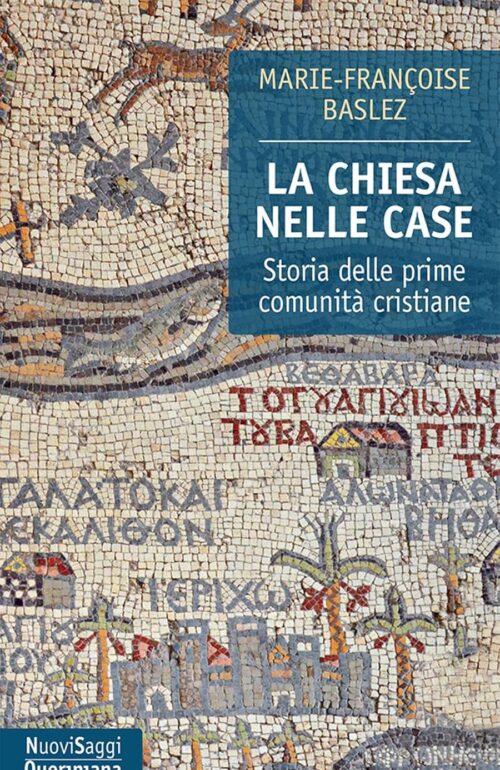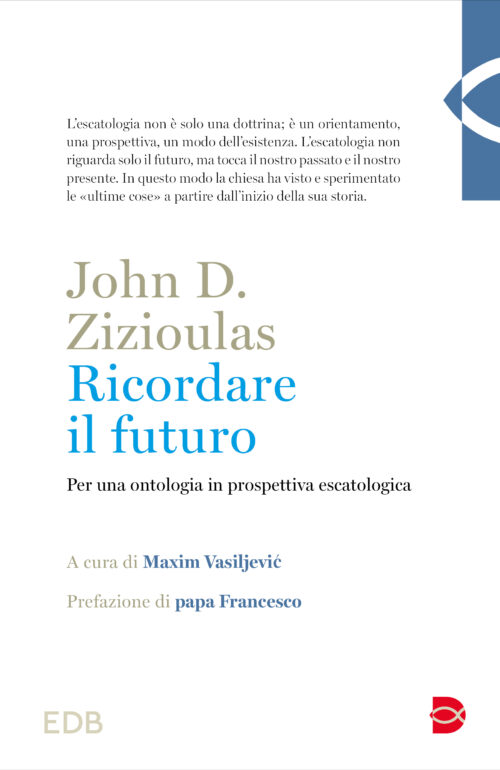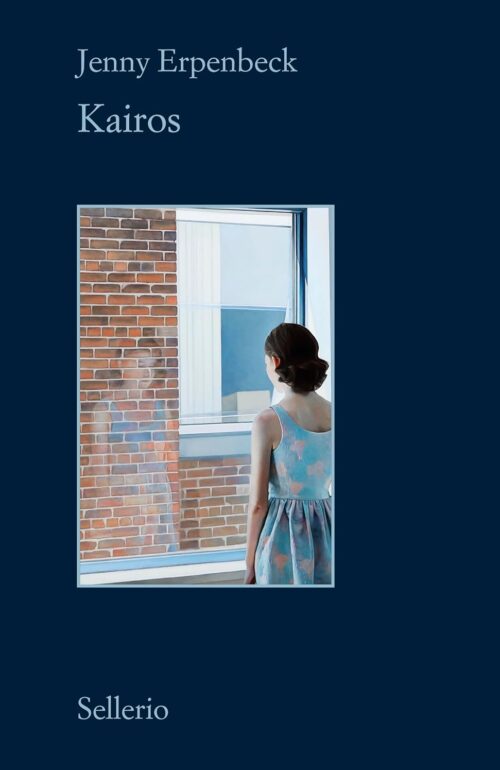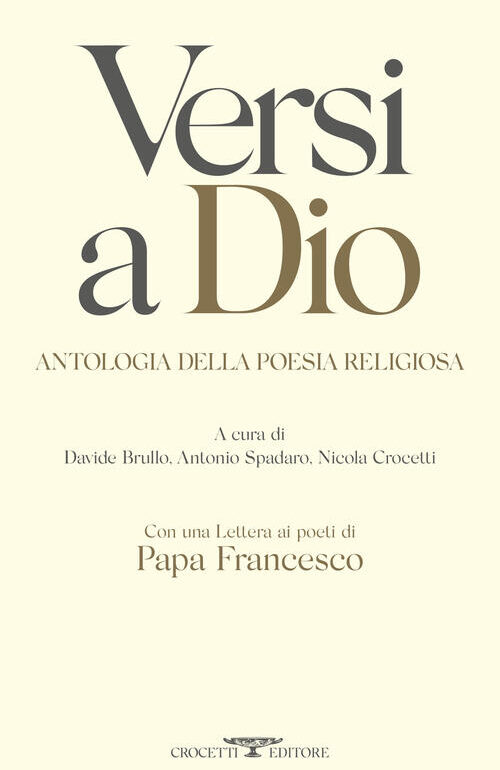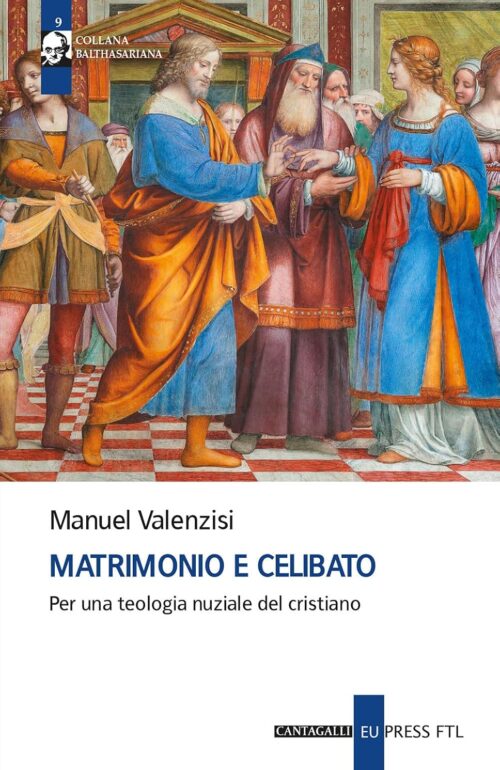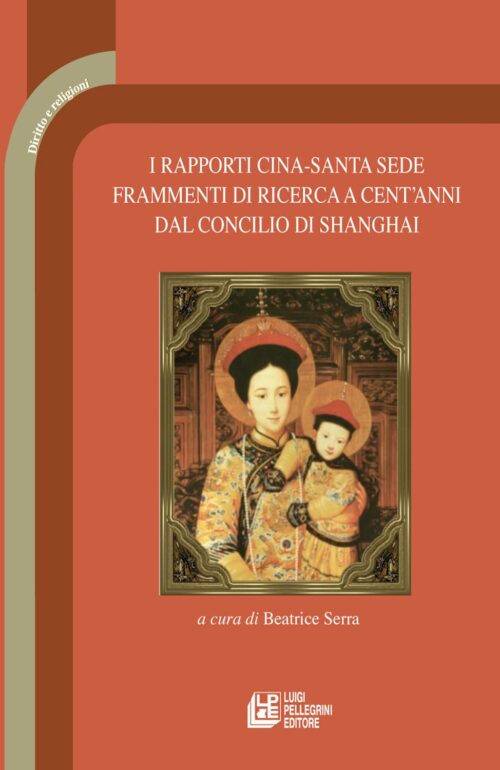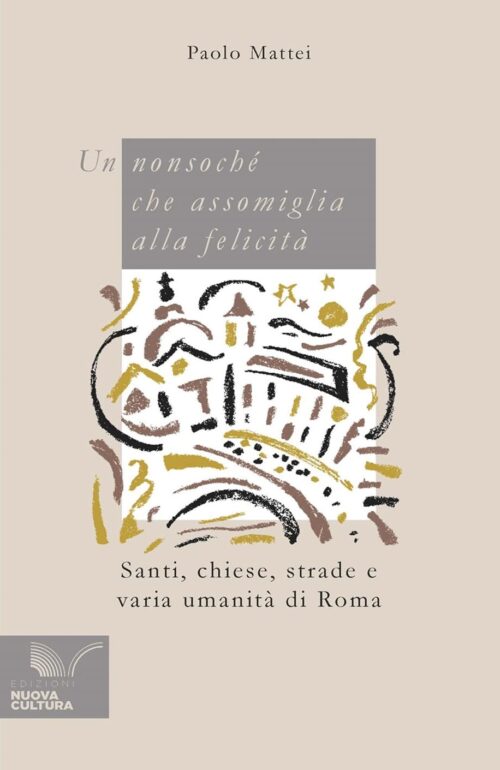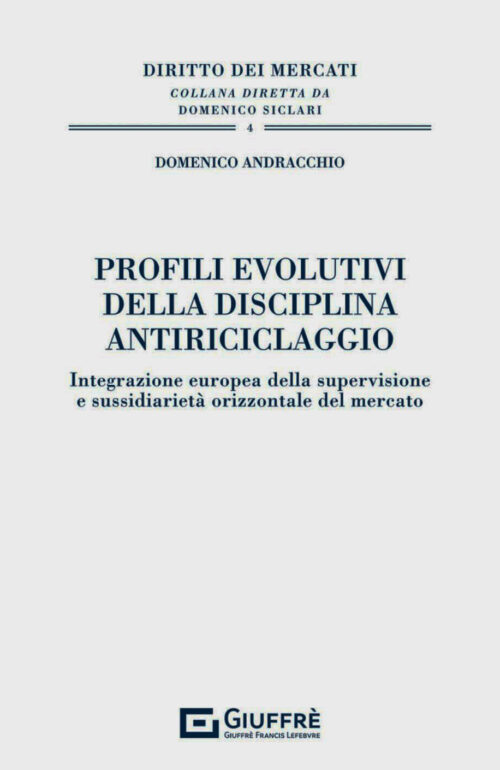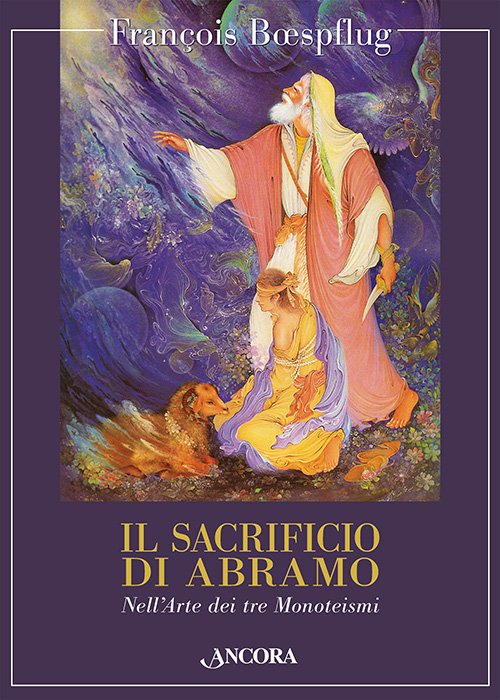Vivere nella speranza significa attraversare l’esperienza dell’assenza. L’ultimo film di Ferzan Özpetek, Diamanti, sembra muoversi in maniera osmotica tra le due dimensioni della presenza e dell’assenza, di ciò che resta al nostro fianco e ciò che resta dentro di noi.
La storia si svolge su due livelli, tra un presente e un passato: nella contemporaneità compare lo stesso regista che discute del film con i suoi «diamanti», che sono le protagoniste di una storia ambientata nella Roma degli anni Settanta, nella sartoria delle sorelle Canova, punto di riferimento per il cinema e il teatro dell’epoca. I due livelli di narrazione aiutano a svelare la magia propria del cinema, perché, mentre la sceneggiatura viene discussa attorno a un tavolo nella casa del regista, ci si ritrova poi già calati nel vivo della pellicola, in un contesto che, tuttavia, sta ancora al di qua della cinepresa, negli ambienti della sartoria. Qui i colori caldi, le luci morbide, spesso soffuse, rendono il luogo uno spazio affascinante, nel quale gli abiti prendono forma, più che dai bozzetti, dall’interiorità che ciascuna sarta riesce a intessere in ogni dettaglio.
Capire cosa l’abito deve significare, quali valori debba trasmettere, fa di esso un varco attraverso il quale l’attore entra per tra-vestirsi nel personaggio. Dal vuoto inizia il moto creativo che mai si arresta, quando è alimentato da supporto, sinergia, ammirazione e fiducia. Un gruppo di donne presenti l’una per l’altra, ma mai invadenti, che si lasciano trasportare da chi guarda più lontano e tocca corde più profonde, dà prova allo spettatore di come si possa mettere in atto un circolo virtuoso di collaborazione. La competenza delle sarte va oltre la tecnica, abbraccia la sfera dell’ascolto e dell’interpretazione, del guardare oltre e dell’immedesimarsi; ancora una volta è una questione del sentire. Qui si impara che gli abiti, le forme, la sostanza delle cose hanno il potere di creare una distanza, più o meno lunga, tra le persone; è un linguaggio anch’esso e, in quanto tale, può essere denso di significato o tristemente sterile.
È un film al femminile, dove la stessa femminilità viene superata nel momento in cui l’io lascia spazio al noi. Può dirsi un inno alla capacità di stare insieme, di collaborare e cooperare, nonostante le difficoltà, le preoccupazioni e la dura quotidianità, che si svolge tra violenze, lavoro incessante, cura della famiglia e l’inevitabile bisogno di leggerezza.
L’assenza ha un peso, un valore, una vera e propria consistenza; così la perdita di una figlia, di un amore, del lavoro, della libertà si incarna, a suo modo, in ogni personaggio. Eppure conoscere l’assenza fa parte del percorso di gloria: nell’«assenza» si scorge la «risurrezione». È il sepolcro vuoto – la cui rivelazione è stata affidata sempre alle donne – che sconvolge e trasforma la memoria degli uomini in memoriale e la paura in fede. Le donne, probabilmente, riescono a cucirsi in dosso e a portare questa assenza meglio di chiunque altro. Di questa peculiarità femminile Özpetek fa una questione del sentire.
Tutto si snoda attorno alla creazione di un abito in particolare, da realizzarsi per la protagonista di un film ambientato nel Settecento. Questo abito diventa l’oggetto catalizzatore del vissuto di tutti, delle forze e delle debolezze. Esso deve veicolare lo sguardo delle donne, che è quello che si slancia verso l’alto, verso ciò che non si può vedere, ma che si sente. La forza con cui questo costume deve manifestare l’invisibile è la stessa che si osserva nella «Madonna del Parto» di Piero della Francesca, opera nella quale l’abito acquisisce una valenza precisa, di custodia della Vita.
La capacità di sentire la vita Özpetek l’affida alla familiarità che le donne hanno con il cielo, «con le stelle». Ecco dove l’«assenza» diventa «presenza», per trasformarsi in «comunione»: nell’aspirazione verticale, quel desiderio di trascendenza, che si ravvisa tanto nella silenziosa commozione quanto nella ruggente determinazione che contraddistingue il fare delle donne.