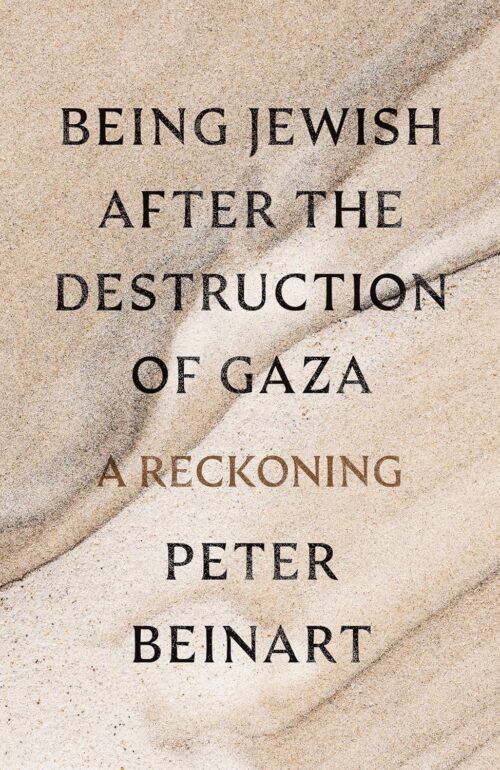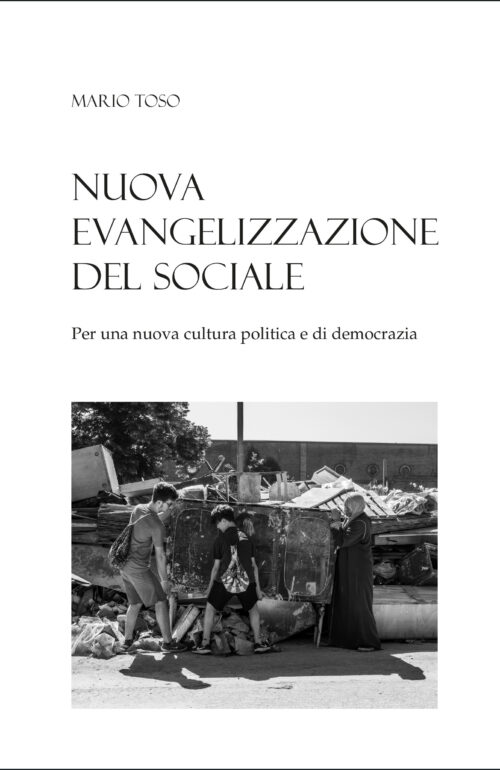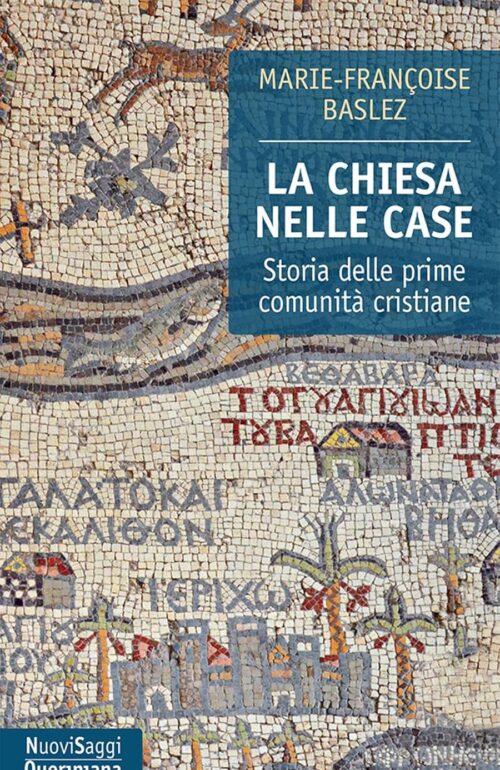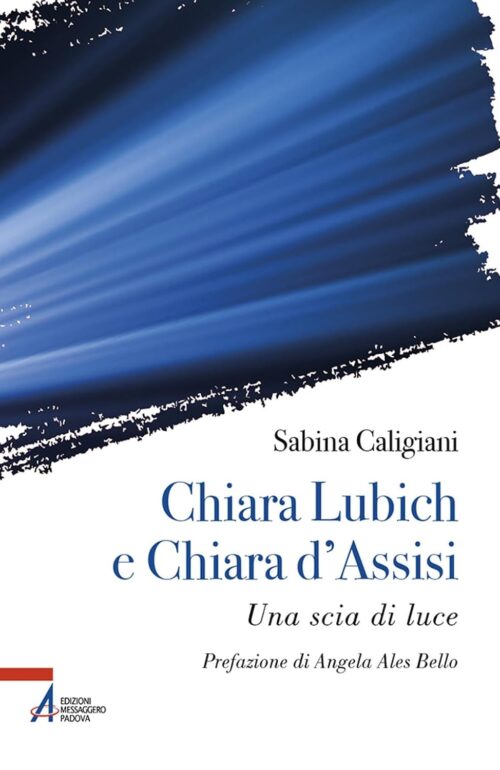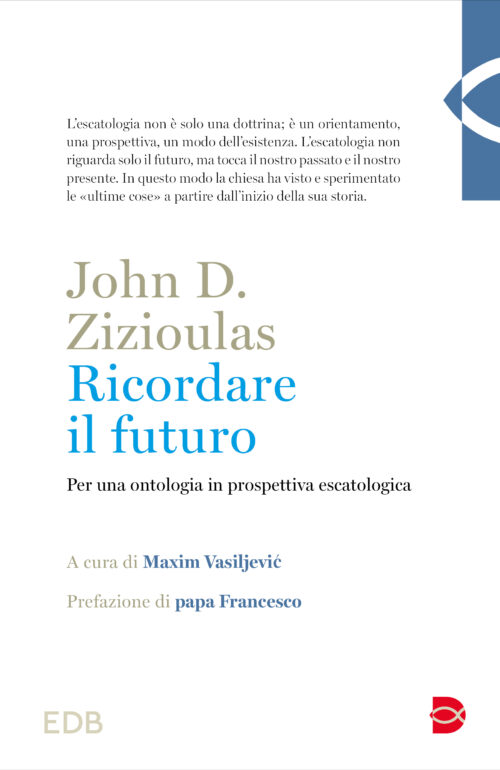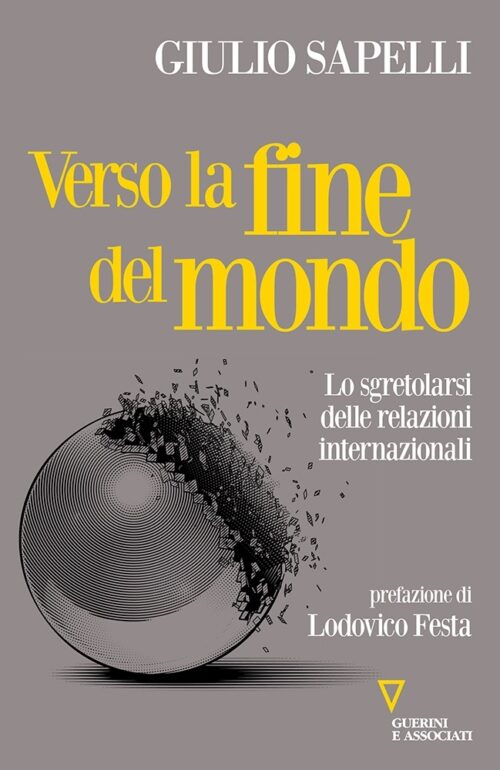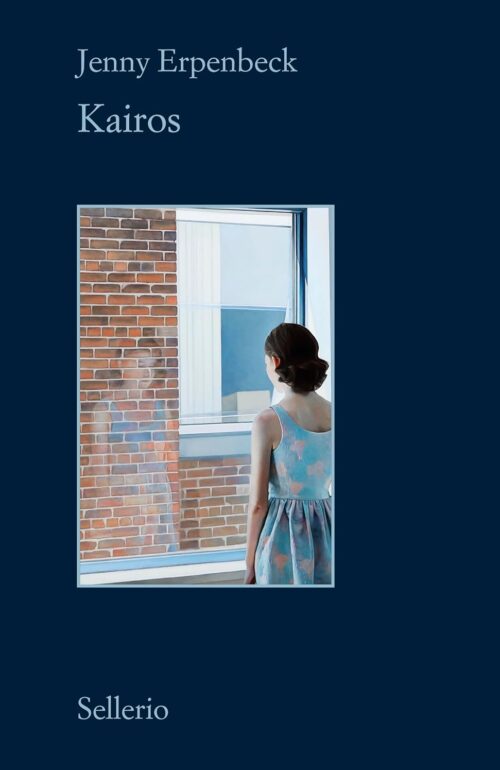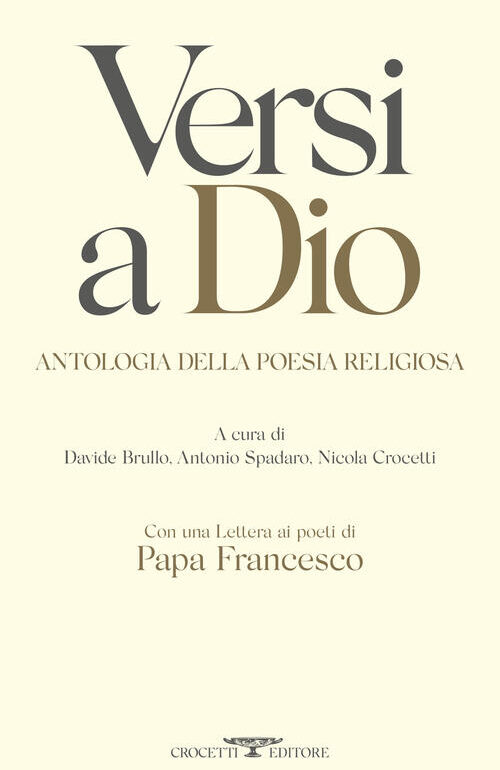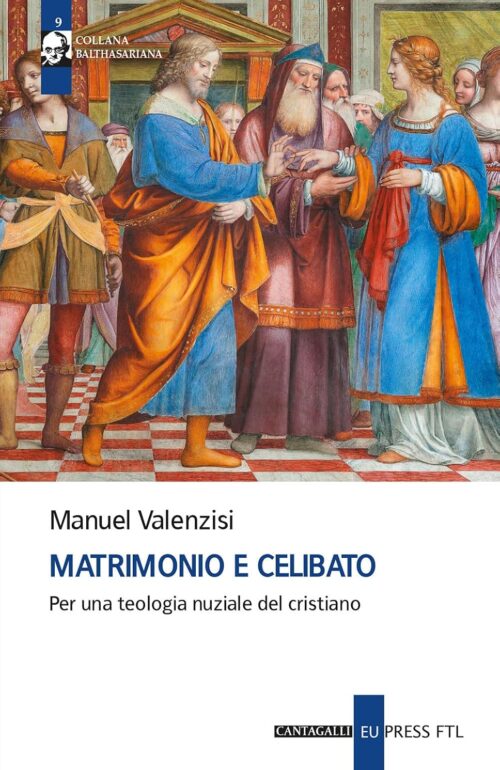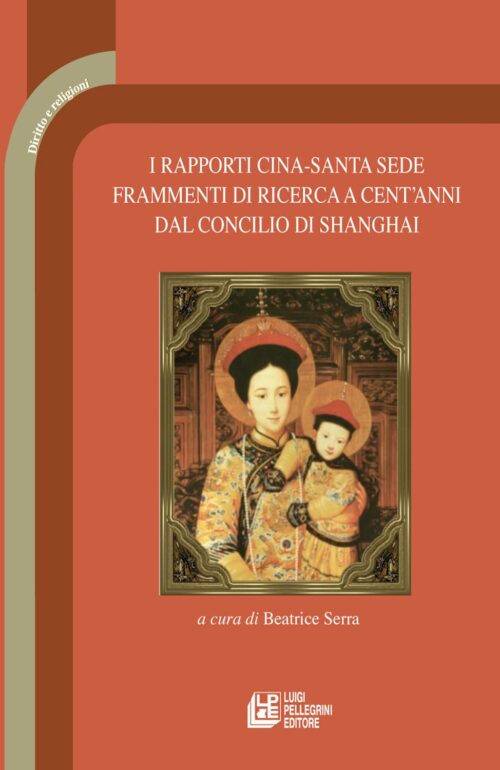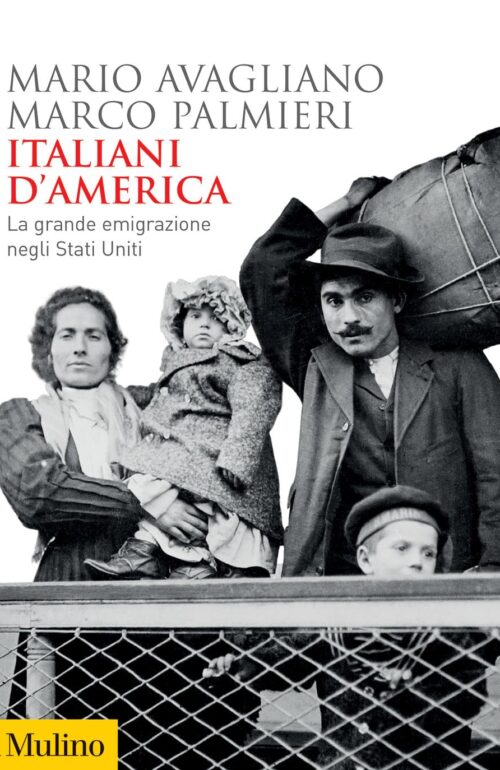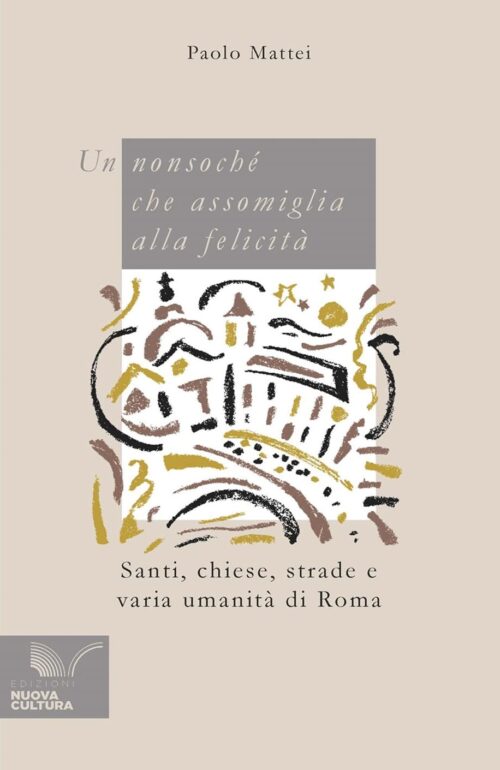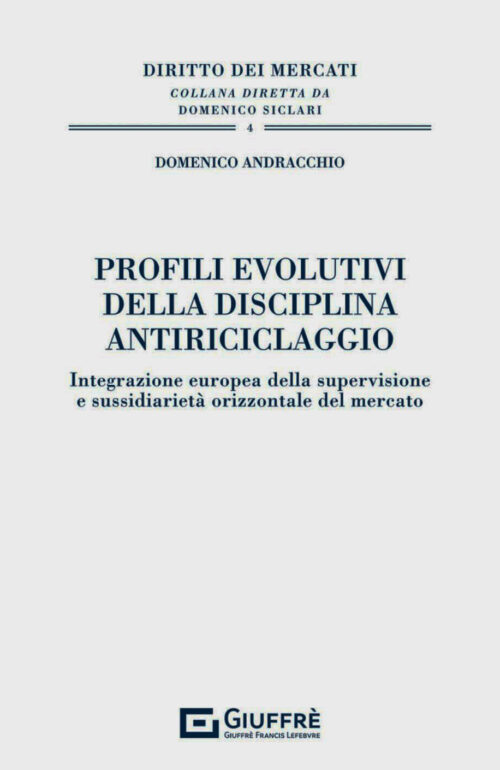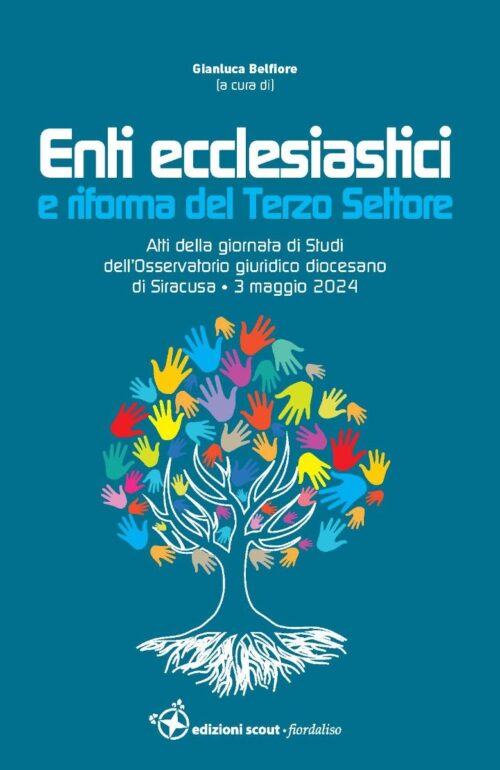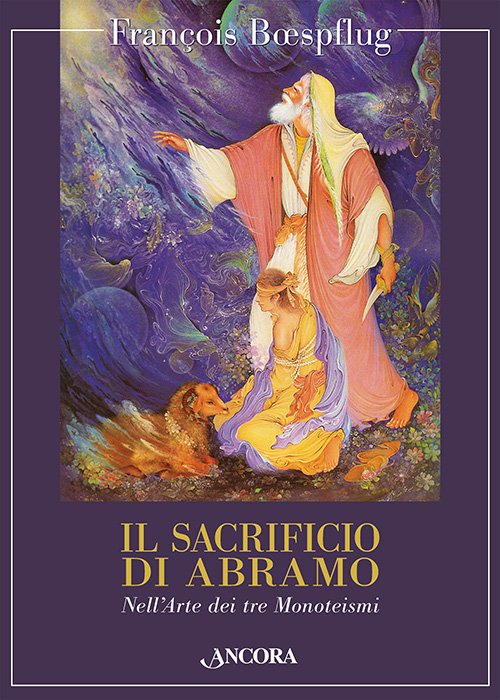«Capire i parassiti, in fondo, è capire l’equilibrio tra le creature viventi, la reciproca dipendenza che ci lega gli uni agli altri, nessuno escluso. È probabilmente la lezione più preziosa che si possa apprendere dall’osservazione della natura». Scrive così Laura Imai Messina nel suo libro Tokyo tutto l’anno (Torino, Einaudi, 2020, p. 84), quando racconta di aver portato i suoi figli a visitare il Museo parassitologico di Meguro, con la «speranza che siano contagiati da una visione del reale non preconfezionata, di renderli curiosi» (p. 83).
Contagiata da questa curiosità, ho cercato l’invisibile, l’essenza del mondo, nella mostra Elogio della diversità, presso il Palazzo delle Esposizioni, a cura di Isabella Saggio e Fabrizio Rufo, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo e curata da Sapienza Università di Roma, realizzata sotto lo sguardo esperto di un comitato scientifico di eccellenza, fra cui troviamo il premio Nobel Giorgio Parisi.
Il titolo scelto è eloquente: in questa mostra le opere sono animali, scenografie e pannelli interattivi che raccontano del valore della biodiversità attraversando realtà lontane. L’essenza dell’esposizione sta nel sensibile equilibrio che li collega gli uni con gli altri, a prescindere dalle distanze di spazio e tempo. Creature della terra, dell’acqua, dell’aria, specie in aumento e a rischio, sono i principali «compagni di viaggio» del visitatore. Tuttavia la diversità cui fa riferimento l’intera mostra abbraccia la vita nella sua complessità: si affrontano i temi del cibo, della linguistica, della genetica, dell’inquinamento e dei progetti concreti da realizzare in città. All’entusiasmo con cui si disvela la varietà degli esseri viventi si accompagna l’amara consapevolezza dell’impatto violento che l’essere umano ha.
Il vantaggio di questa esposizione si ritrova poi nella possibilità di calarsi in habitat lontani, ponendosi nel ruolo di osservatori e ascoltatori: ci si immerge nelle profondità del mare; lì si ascolta la comunicazione degli animali, fatta di suoni e vibrazioni con cui sostengono il proprio equilibrio vitale, e insieme l’inquinamento acustico generato dall’uomo, che naviga i mari con mezzi pesanti, fa scoppiare bombe e utilizza trivelle.
Ciascuno di noi, indubbiamente, è consapevole di essere su un pianeta ricco di specie, eppure è difficile ricordarsi nel quotidiano che la propria vita è il risultato di questa connessione profonda, frutto di una coabitazione. Tutto, in realtà, ci parla del nostro vivere; è curioso ritrovare, nei comportamenti di animali e vegetali, capacità che noi umani inseguiamo con fatica. I tardigradi, piccoli invertebrati, ad esempio, sono l’emblema della resistenza: sopravvivendo persino alla caduta di un asteroide, ci ricordano la potenza della vita, più forte e duratura di quanto si possa credere. Nei tronchi degli alberi, invece, si può osservare la «forma» della longevità, fatta di linee ascendenti e discendenti.
Al nostro continuo rumore il pianeta, in crisi, risponde con il silenzio assordante, tangibile negli strumenti realizzati con legni non più disponibili in natura, che divengono prova di un «suono» che non potrà ripetersi. La scomparsa di materie prime, allora, ha un effetto non solo sulla produzione, ma anche sulla nostra sensibilità.
L’uomo è chiamato a trasformare il suo impatto, e ciò è possibile abituando lo sguardo all’inclusione e al non conflitto con il creato. A questa consapevolezza è chiamata la coscienza attraverso le poche domande, disposte nelle sale, fino ad arrivare all’ultimo quesito con cui si mette in discussione tutto il percorso. A questo punto, la visione limitata, antropocentrica ed egotica si dilata guardando alla ricchezza del creato; la comunione cui siamo chiamati a vivere è un richiamo troppo forte, davanti al quale è difficile rimanere impermeabili. La mostra, dunque, ha, sì, un sapore dolceamaro, ma offre spiragli di possibilità, educando i visitatori a vivere da «amministratori responsabili», così che la trasformazione possa avvenire ancora.