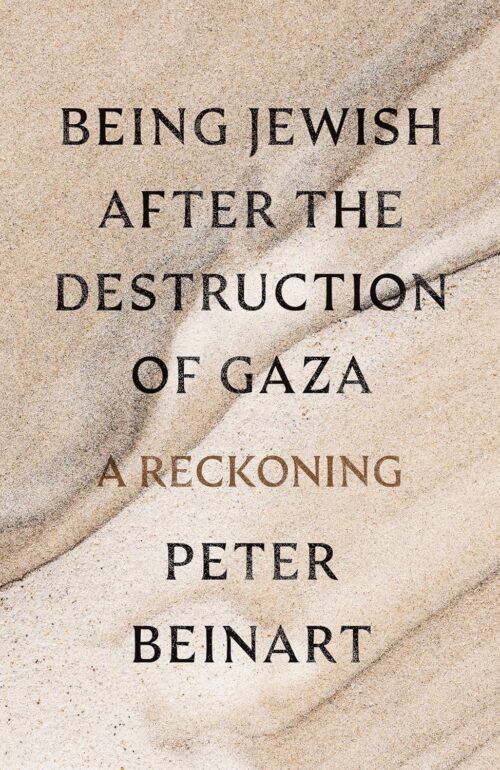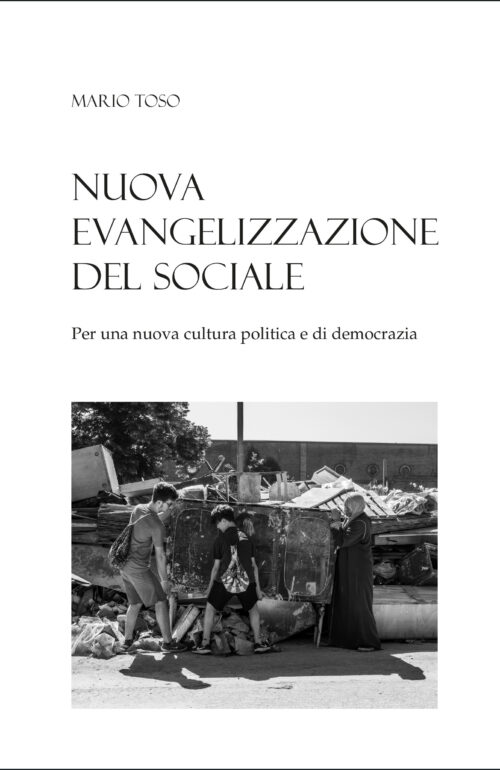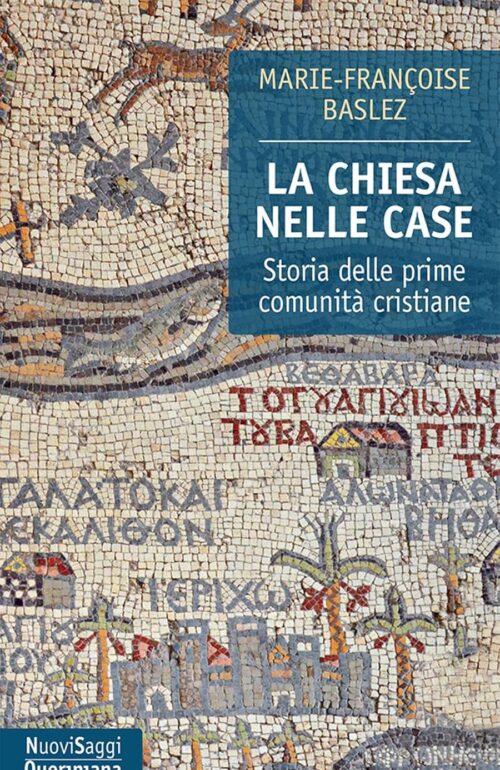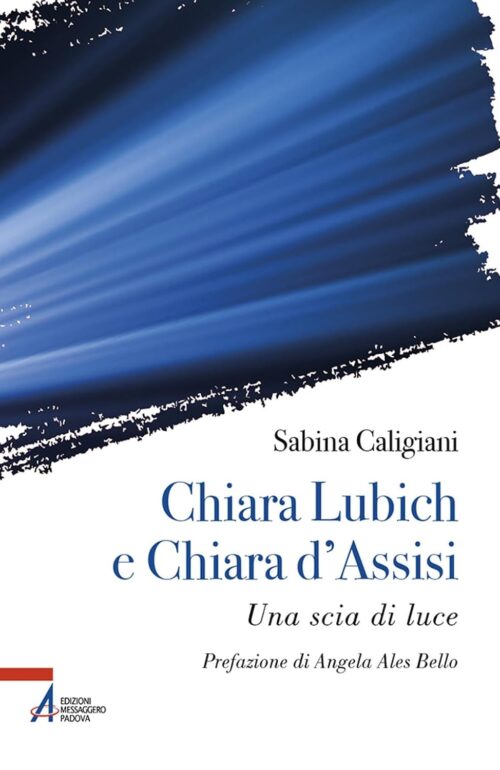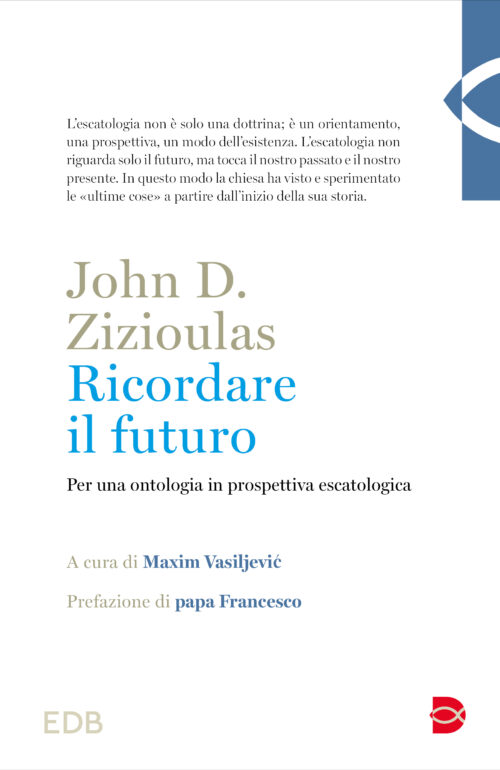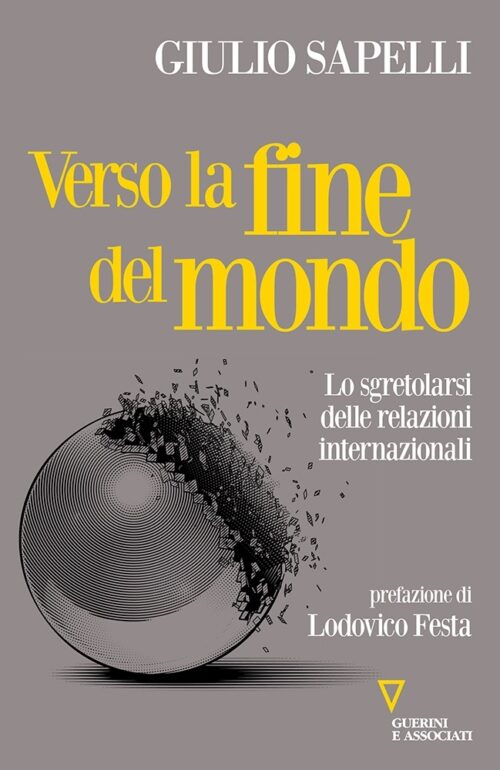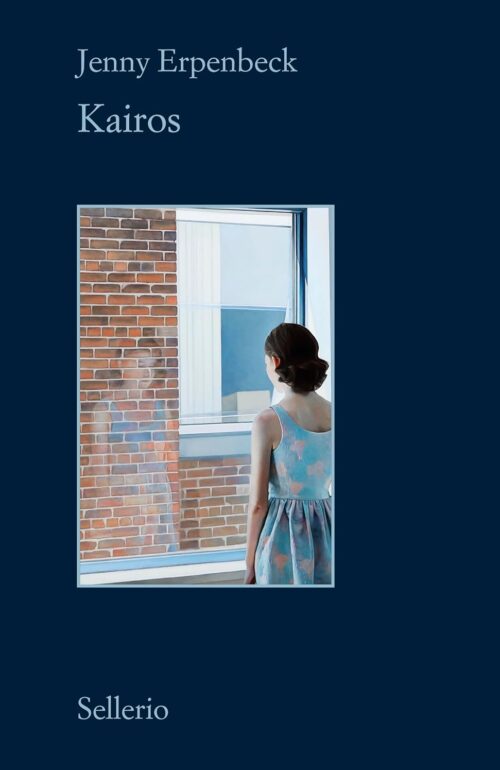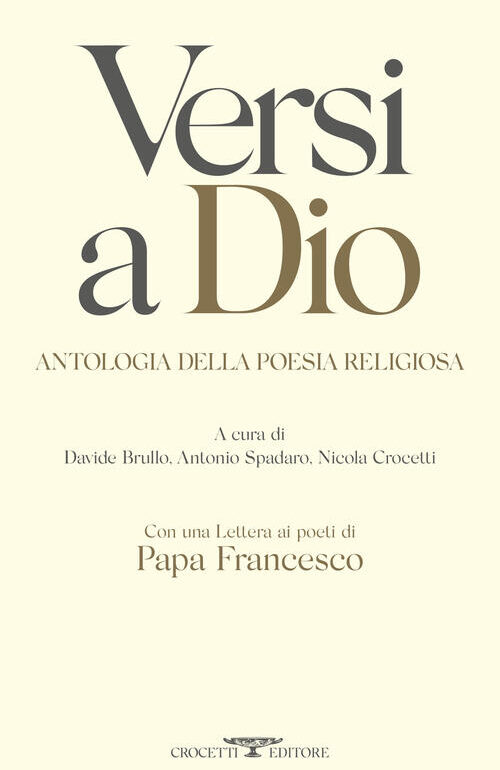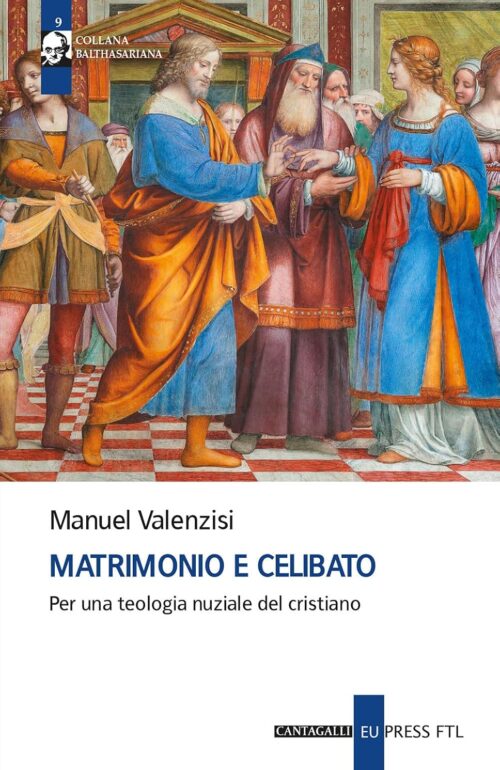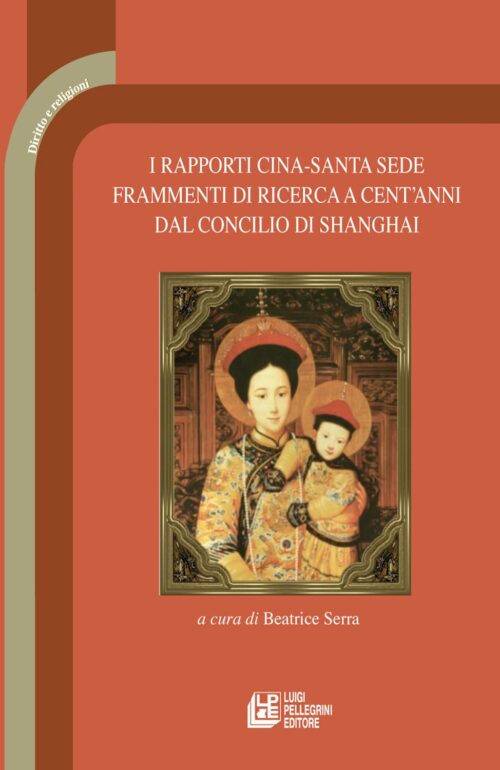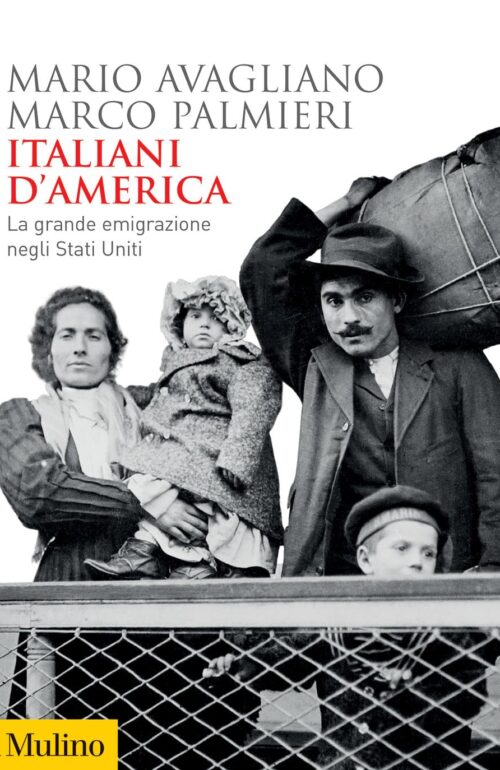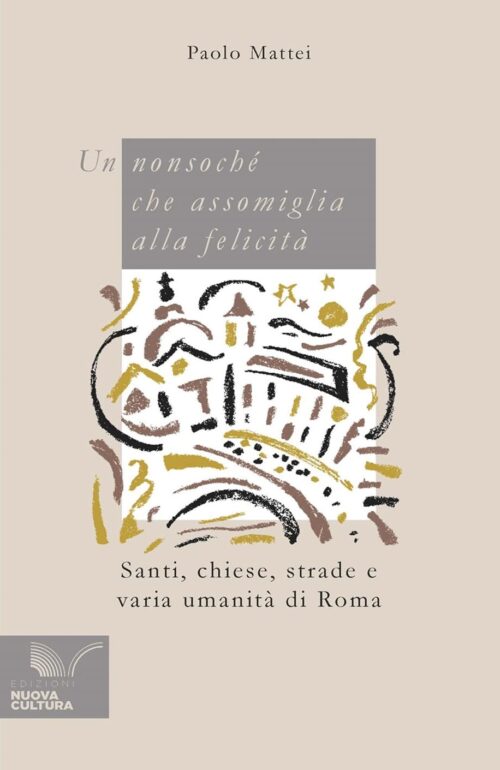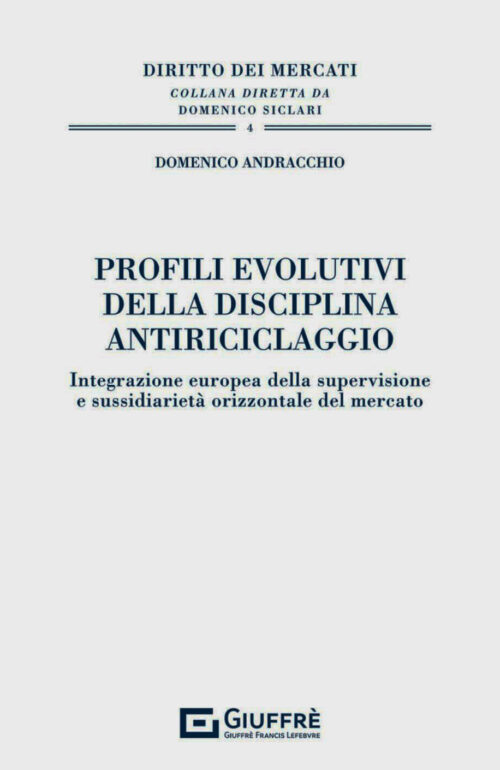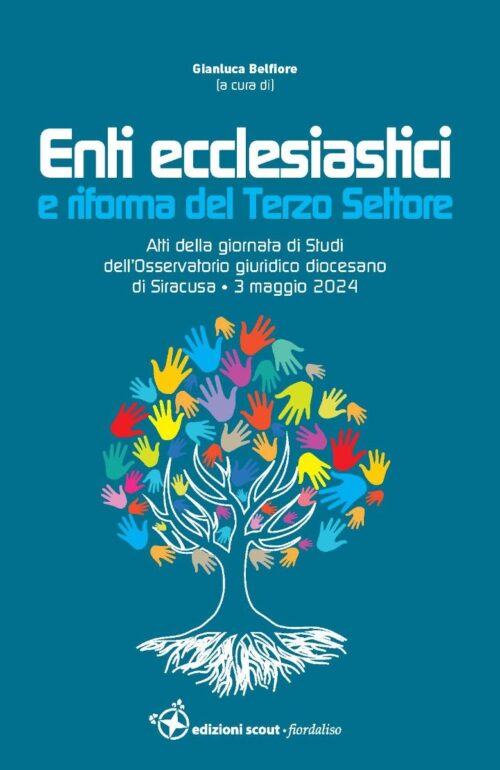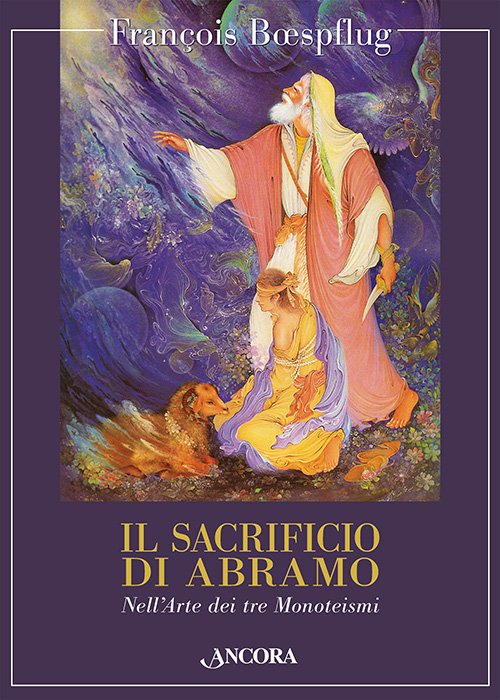The Return – il titolo originale del film – tratta del ritorno di Ulisse a Itaca. La storia è ben nota, ma il regista Uberto Pasolini vuole sondare quella parte di gap narrativo che Omero ha lasciato nell’Odissea; perciò immagina il sentire dell’eroe greco (nel film interpretato da Ralph Fiennes) quando ritorna a Itaca esausto e invecchiato, e quali sentimenti la sua lunga assenza, durata 10 anni per la guerra di Troia e altrettanti a causa del suo peregrinare, ha suscitato nell’animo di Penelope (Juliette Binoche) e del giovane Telemaco (Charlie Plummer).
Il tempo, una clessidra ormai agli sgoccioli per l’insistenza arrogante dei Proci – che stanno occupando il palazzo di Ulisse con tracotanza e violenza, chiedendo che Penelope scelga al più presto uno di loro come marito – sta per terminare. Se le mani di Penelope di giorno guidano abilmente il fuso, che ricorda una barca stilizzata in continuo movimento (quella che lei sta infinitamente attendendo), di notte, disfacendo la tela, ne allungano il tempo, e dunque la speranza di un ritorno. Il tempo tuttavia lavora: erode la memoria dell’eroe nel palazzo, indebolisce la speranza che Ulisse possa realmente tornare. Telemaco, per il quale ogni giorno è uguale a sé stesso, vede i contorni della sua famiglia sbiadire, di fronte a una madre che egli non riconosce più e a un padre che, di fatto, non ha mai visto. Così anche il popolo è privo di un sovrano che lo guidi, che lo faccia vivere dignitosamente e, soprattutto, che lo difenda dai popoli che giungono per depredarlo.
La guerra di Troia non solo ha distrutto la città di Ilio, massacrato gli abitanti e violentato donne, ma ha completamente annientato Ulisse, che vediamo inizialmente steso sulle coste di Itaca, nudo e semicosciente a causa del naufragio. Il suo corpo è segnato dalle cicatrici della guerra, il suo animo ottenebrato da ciò che ha compiuto e visto. Lui, unico superstite di quel gruppo di compagni partiti da Itaca per diventare eroi, prova un senso di colpa nei confronti delle loro famiglie, dei suoi cari e della sua terra amata e desiderata e ora occupata e violata. Dunque, un Ulisse ben differente da quello visto dalla tradizione dantesca come colui che segue «virtute e conoscenza», e da quello omerico, astuto e assetato di vendetta.
La terra di Itaca è l’altra grande protagonista del film: gli spazi aperti, vasti, con una natura che resiste indipendentemente dalle vicissitudini umane, si contrappongono alle mura del palazzo reale, luogo di reclusione e oscurità per Penelope e Telemaco. La terra, in una sequenza incisiva, è ciò che Ulisse mangia avidamente con le mani, una volta che ha ripreso conoscenza, ospitato dal porcaro Eumeo (Claudio Santamaria). Ulisse ha ancora fame, non di conoscenza, non di guerre e neppure di avventure: questa volta ha fame della sua terra, del suo passato e della sua famiglia. La nostalgia è il sentimento del ritorno – in greco, νόστος, da cui deriva il termine italiano «nostalgia» –, che gli permette di voler ricostruire di nuovo un luogo dove abitare, lottando non solo contro i Proci, ma soprattutto con il senso di colpa, che gli mostra come in questi vent’anni tanto sia cambiato, forse troppo per poter riedificare ciò che egli ha tragicamente perduto.
La guerra, la lontananza e l’assenza hanno trasformato Ulisse non solo fisicamente, ma soprattutto nell’animo; il suo sarà un cammino di conversione agli affetti, al rispetto, alla dignità, non senza ancora un’ultima drammatica battaglia. Parimenti, per Telemaco sarà un cammino di riconoscimento di sé e del padre; e per Penelope, stanca di attese, di guerra e di sangue, un cammino per riscoprire la persona che le sta a fianco. Ognuno dovrà risignificare sé stesso e la propria vita dopo aver vissuto il proprio dramma dentro e fuori Itaca. E forse, dopo il finale del film, rimangono ancor più evocativi gli ultimi versi della poesia Itaca di Costantino Kavafis: «E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. / Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso / già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare».