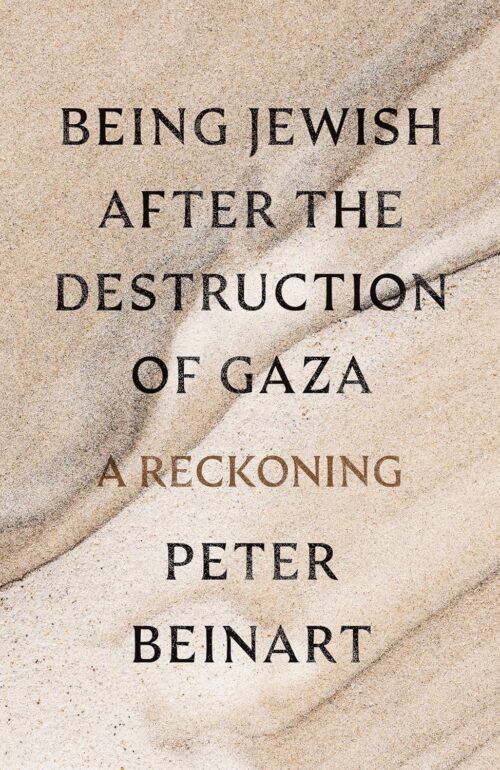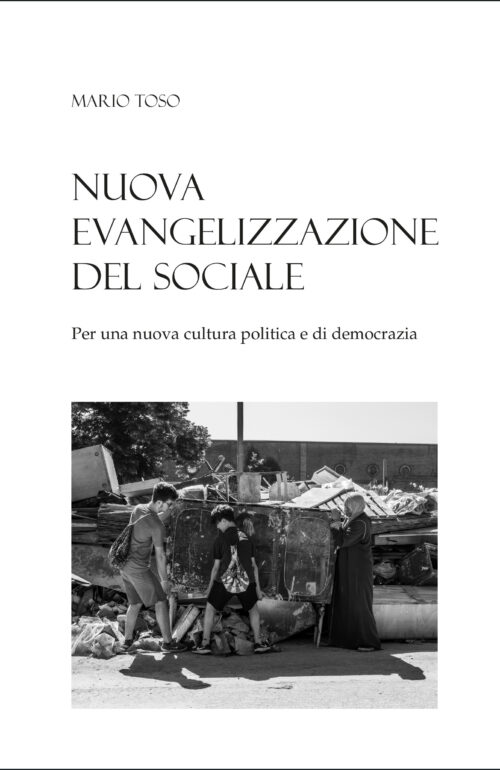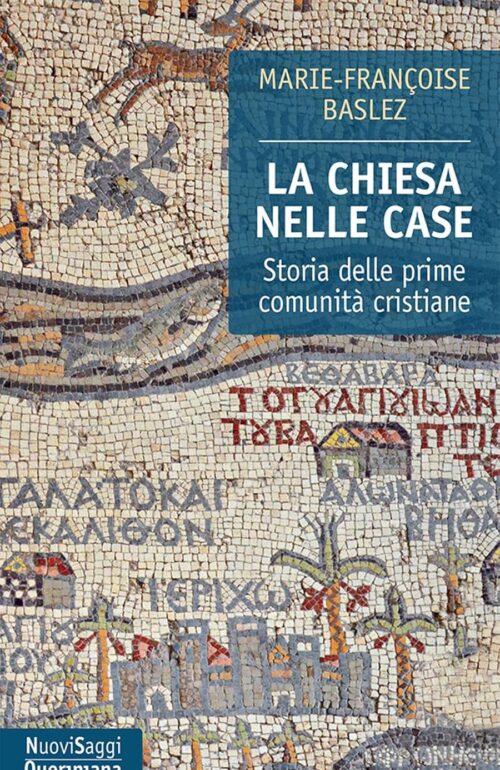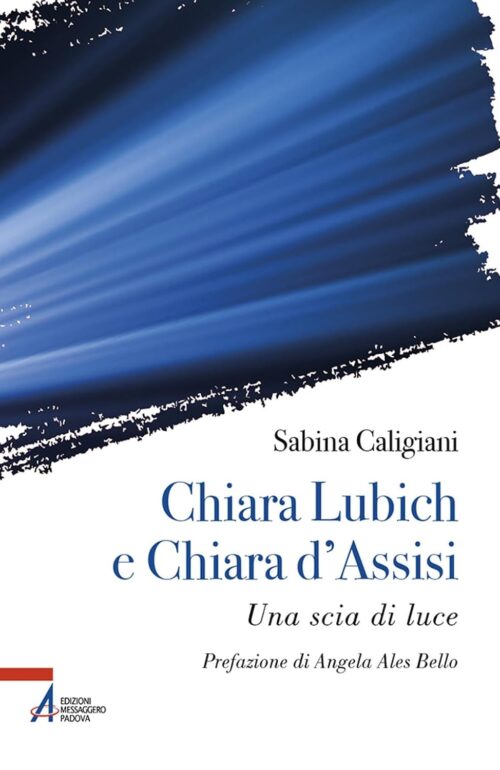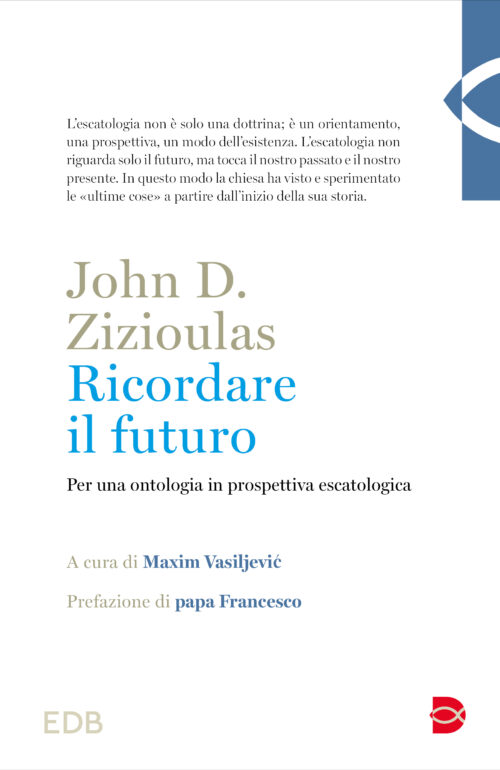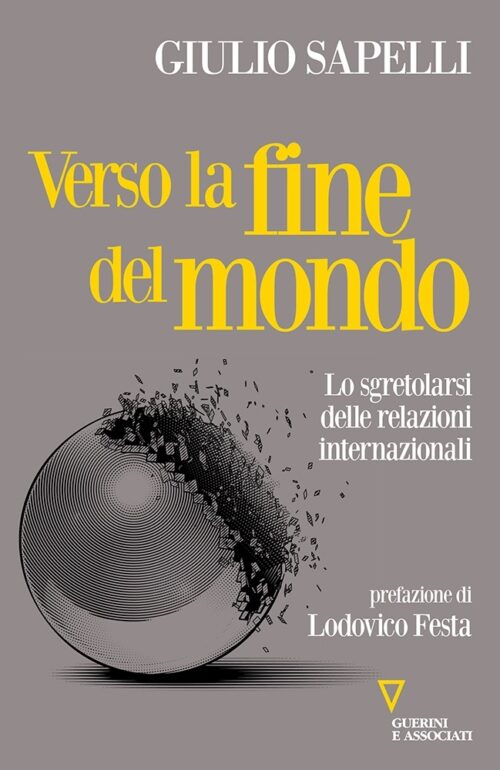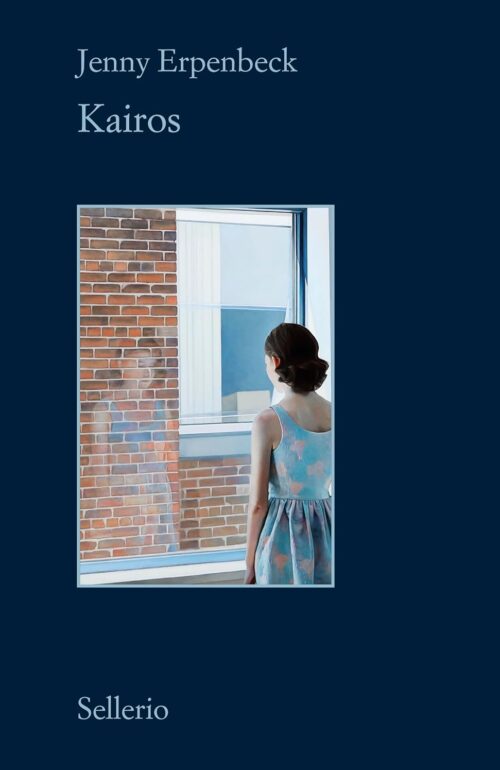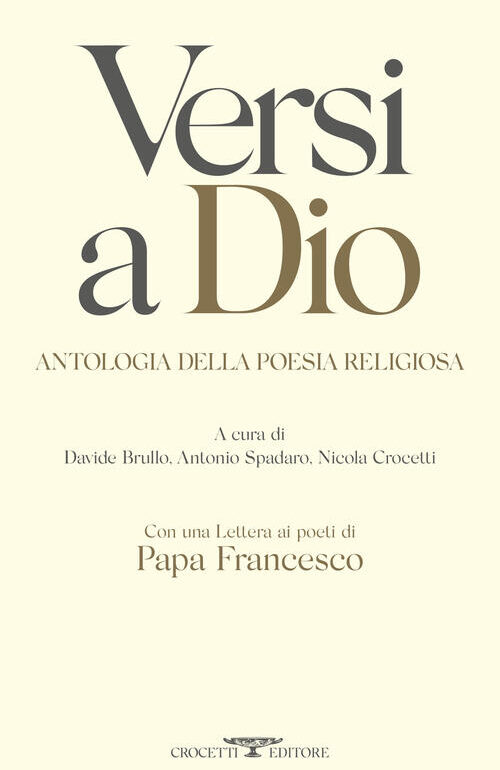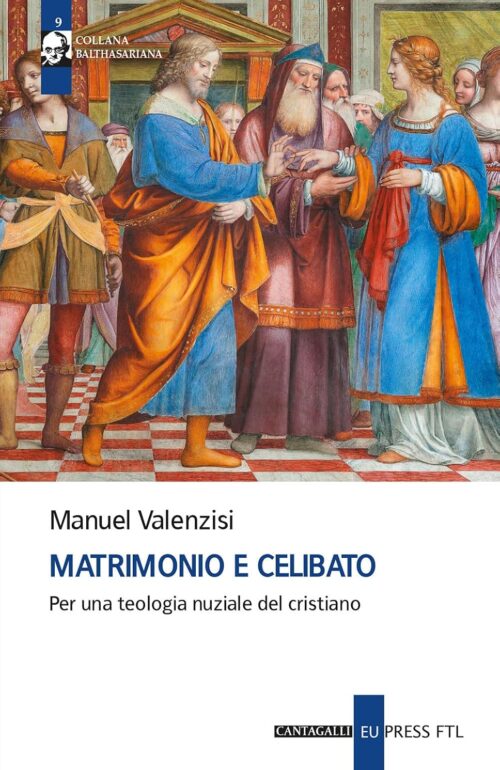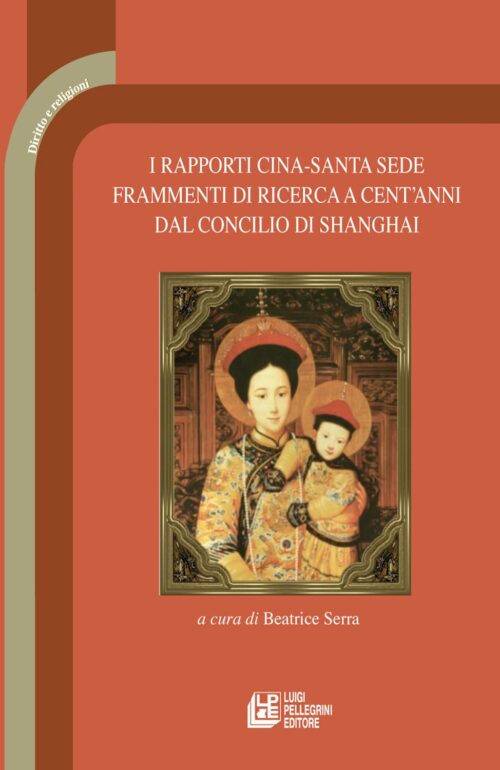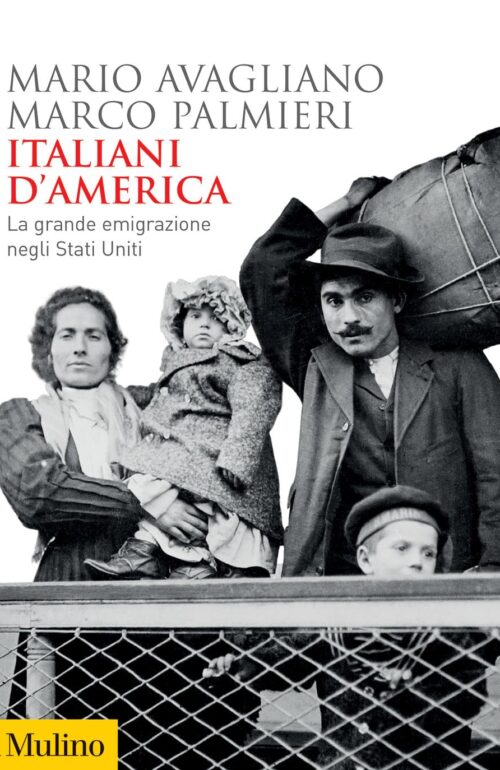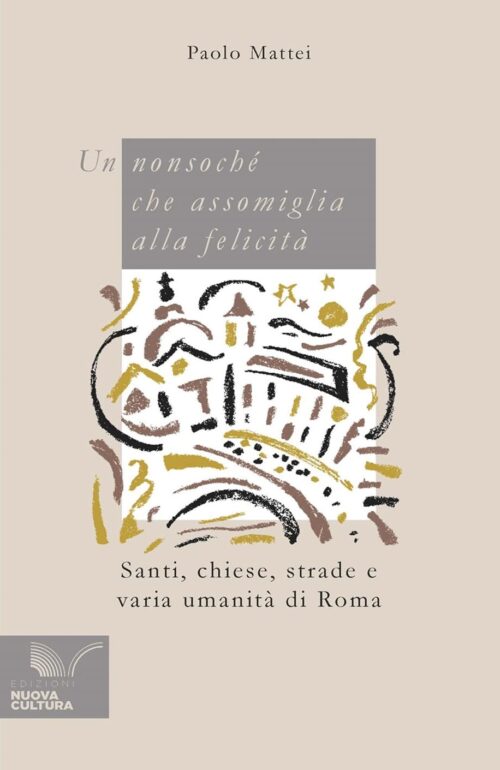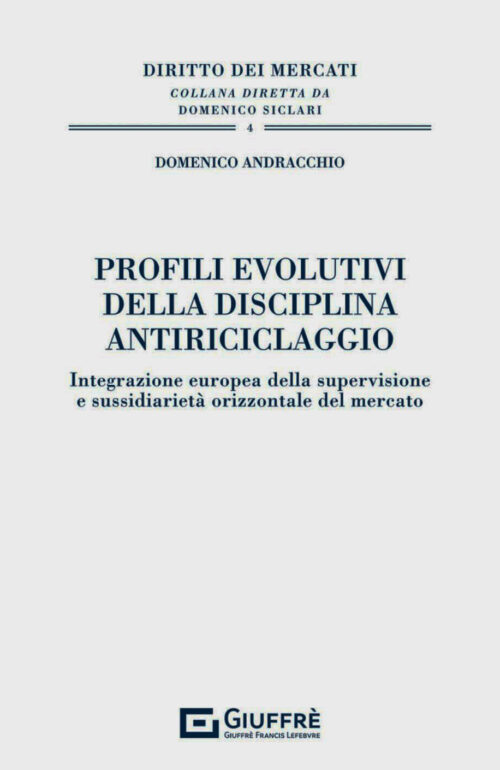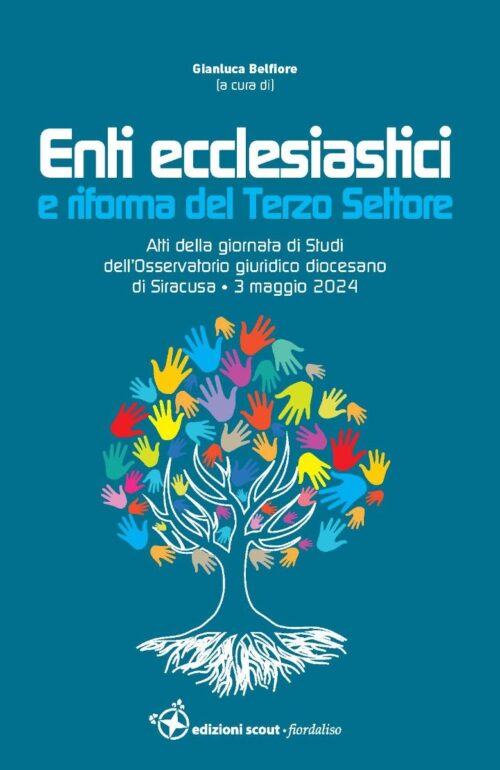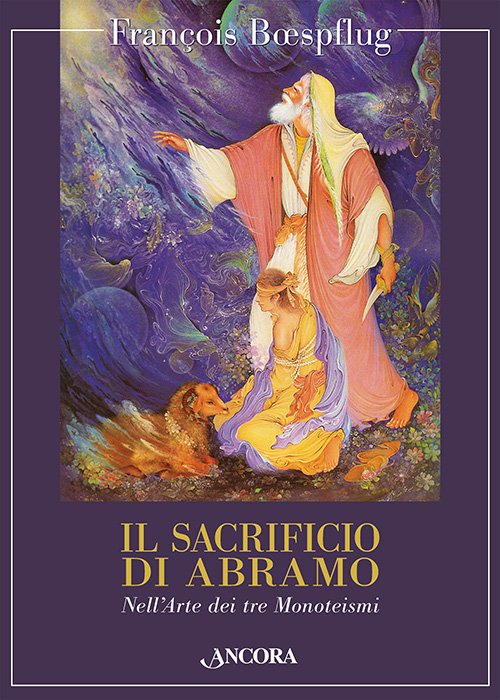«L’Italia unita, come nacque?». «Da un abbaglio», sostiene Andò. L’universo pirandelliano scandagliato nella sua opera filmica precedente, La Stranezza (2022) – gioiello narrativo e produttivo che propose per la prima volta sul grande schermo la triade attoriale Toni Servillo e Ficarra & Picone –, è dietro le spalle per far spazio qui a un episodio della storia nazionale certamente noto, ma forse meno «sentito» a livello popolare: l’impresa dei Mille, di cui mente e leader fu Giuseppe Garibaldi, l’«eroe dei due mondi». Lo interpreta un incisivo Tommaso Ragno, che ci ha ormai abituati a personaggi forti, netti nel bene e nel male o nelle infinite vie di mezzo.
Due gli intrecci che scorrono paralleli, per poi riunirsi verso la fine del film. Da una parte, la coppia di siciliani inconsapevoli – gli «antieroi» Domenico Tricò (Ficarra), contadino emigrato al Nord, e Rosario Spitale (Picone), giocatore d’azzardo baro e in fuga dai debiti di gioco – diserta non appena sbarca a Marsala, avendo come unico obiettivo il ritorno a casa e la personale sopravvivenza. Dall’altra parte, le truppe garibaldine – con a capo il colonnello Orsini (Servillo), che si autodefinisce «un uomo libero, al servizio della libertà, ovunque sia necessario difenderla» – affrontano l’esercito borbonico in evidente inferiorità numerica. Solo un piano ingegnoso di Garibaldi riuscirà a ribaltare le sorti della spedizione dei Mille in procinto di fallire ignominiosamente.
Il regista, come già sperimentato in La Stranezza, alterna il registro comico, affidato al duo Ficarra-Picone – simbolo del riscatto disilluso di due «poveri diavoli» sorpresi, a loro insaputa, nelle grandi maglie della Storia –, e quello drammatico di Servillo, con il suo sguardo acuto e lucido sul Sud, nonché sulla condizione umana. Nel tessuto sociale della Sicilia, Orsini vede specchiarsi la radice dell’unità nazionale genuina, ovvero la disillusione più profonda – «I siciliani non credono più in niente» – e la fine dell’illusione per una qualunque possibilità di autentico riscatto ed evoluzione. Cos’è la giovinezza, se non la speranza di cambiare il mondo, che il colonnello riconosce nell’integro tenente Ragusin (Leonardo Maltese), cui rivolge il monito: «Voi siete giovane, tenetevela stretta!»?
Ma le «perle» dell’opera di Andò sono nell’affresco dei paesini siciliani con i loro abitanti, i «poveri diavoli» di Sambuca, i quali, pur vivendo in condizioni non dissimili dalle capre e dagli asini, hanno mantenuto intatti e alti i sentimenti umani di dolcezza e di pietà. La Sicilia è qui terra di frontiera, tanto che lo stesso regista ha definito il suo film un «western», con scene di battaglia in cui si innesta una pluralità di tematiche: patriottismo e sacrificio del colonnello, individualismo e disillusione dei due siciliani disertori, «visione» militante e strategica di un’Italia libera dal giogo borbonico e finalmente unita da Garibaldi, al netto di luci e ombre, delle miserie dei singoli; e infine la realtà «meschina» – il dialetto siciliano è un pregio del film – di baroni, briganti, contadini, picciotti e donne, madri e mogli che piangono mariti e figli caduti.
Lo schema dualistico di comicità-drammaticità, eroismo-codardia non sostiene sempre una riflessione di spessore pari all’analisi teatrale-letteraria di La Stranezza. L’affresco storico-politico del Risorgimento italiano è ora più ambizioso e ampio nel respiro «umano», reso esplicito, talvolta didascalico, da Servillo. è nel microcosmo della piccola comunità che la Storia, così come la «miseria» degli antieroi, trova un’opportunità reale di risorgere. Per salvare il prossimo, gli abitanti di Sambuca, anche due individualisti, diventano eroi per un giorno. Questa è l’Italia, e alla fine vince chi è disilluso. Andò, dopo La Stranezza, rimane a metà: film a tesi o «opera aperta»?