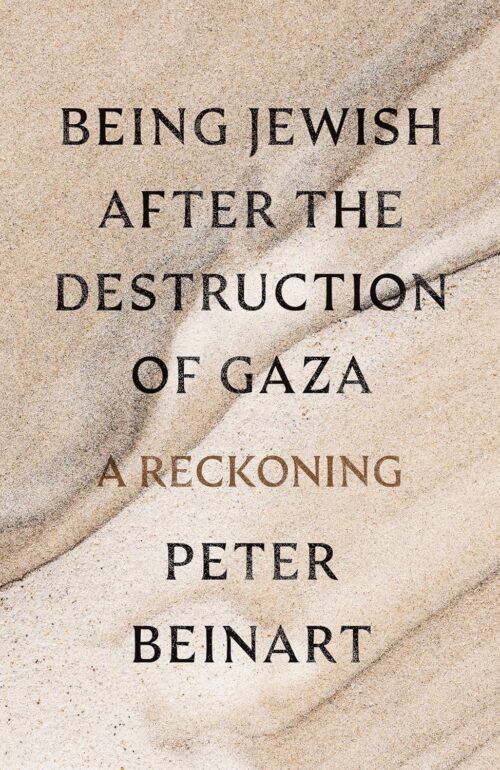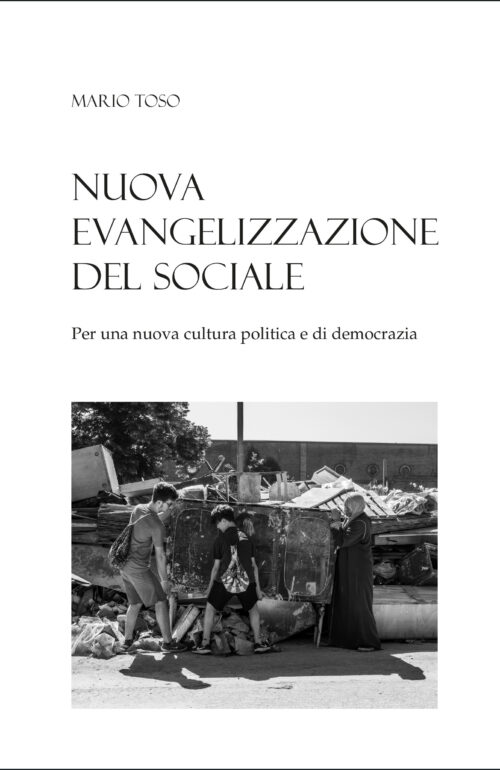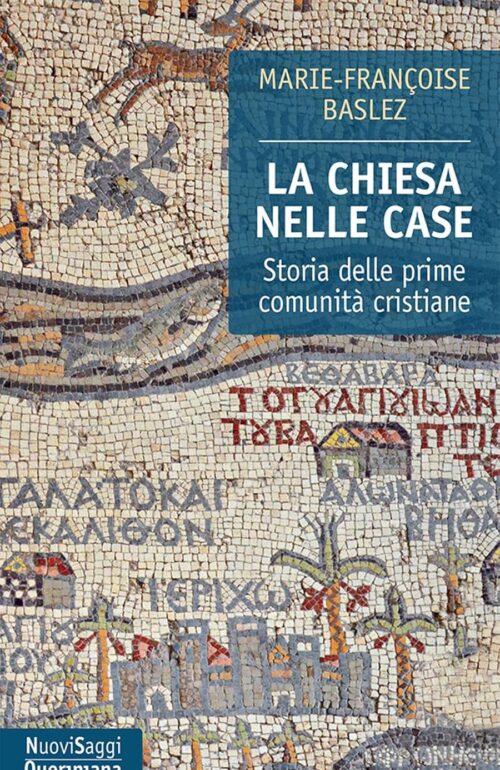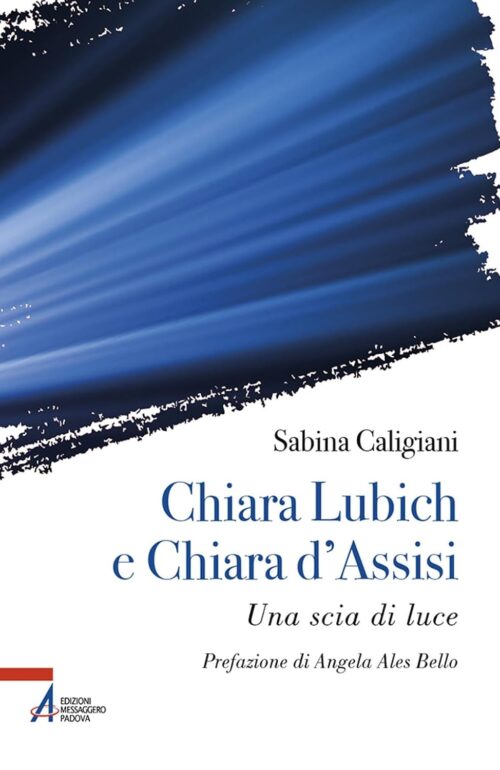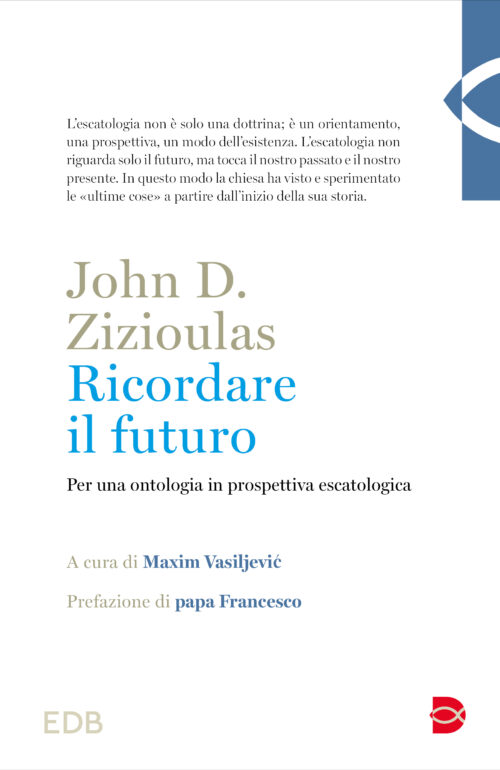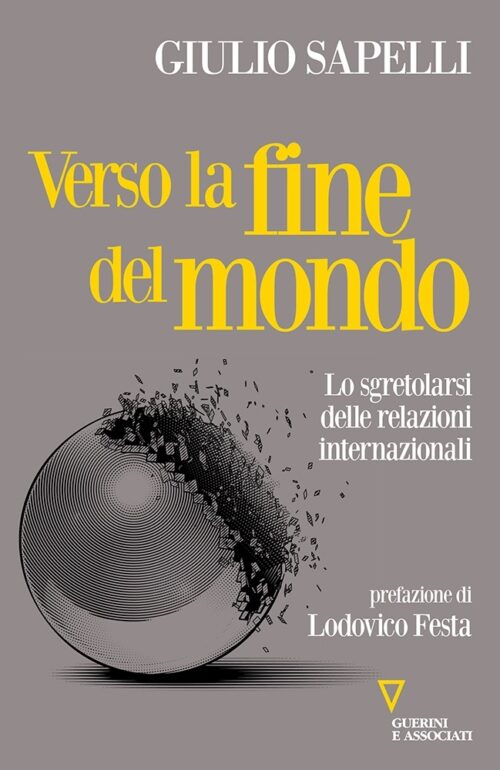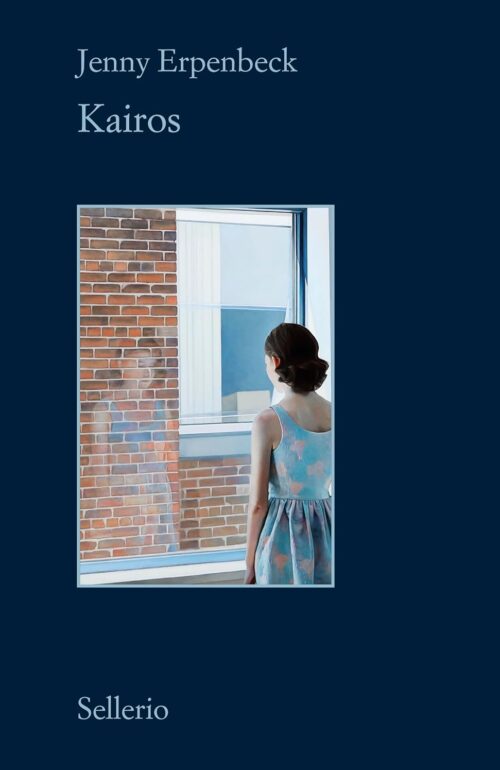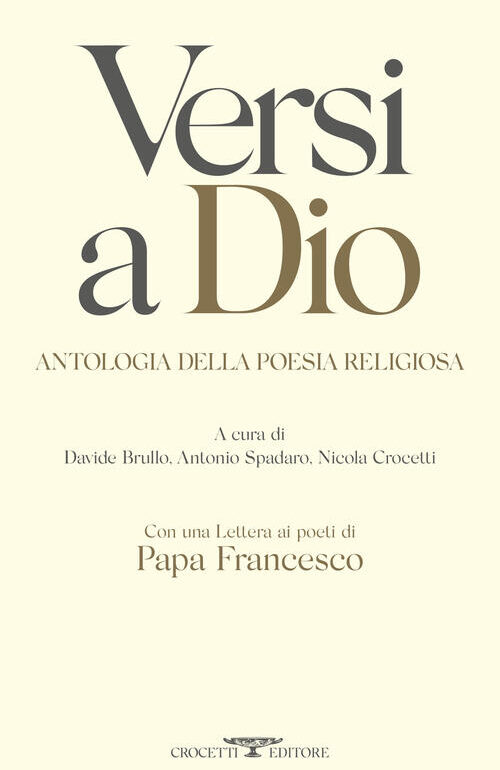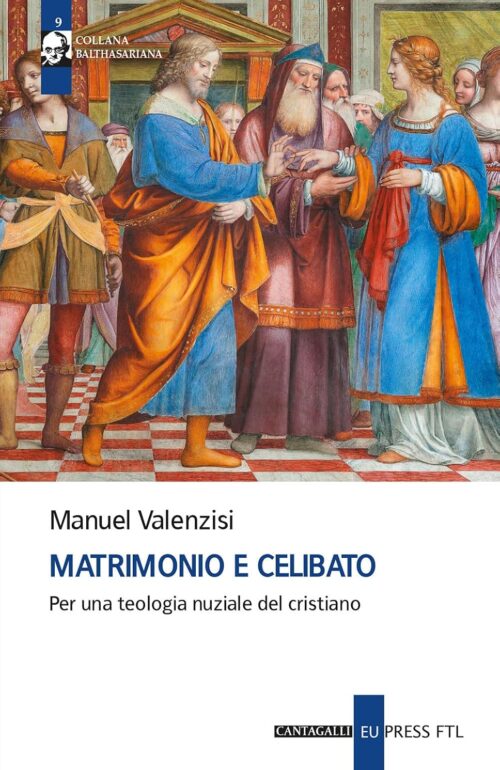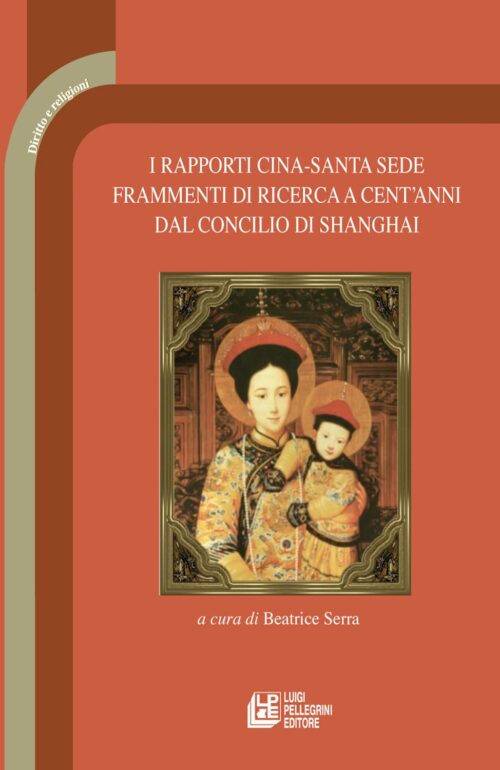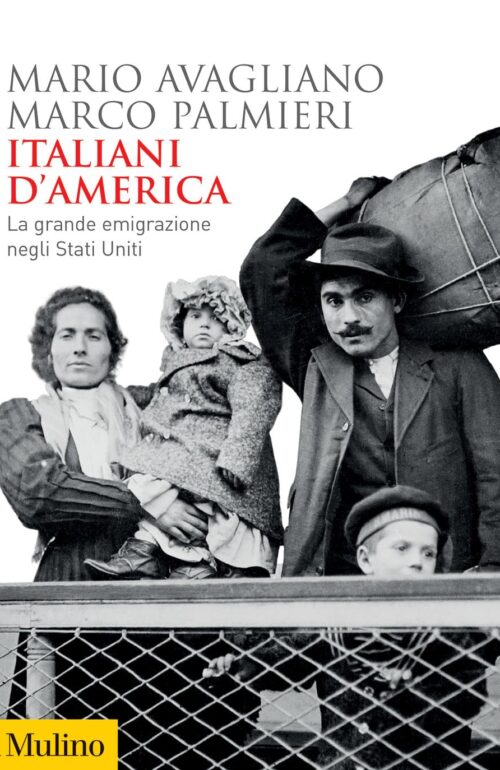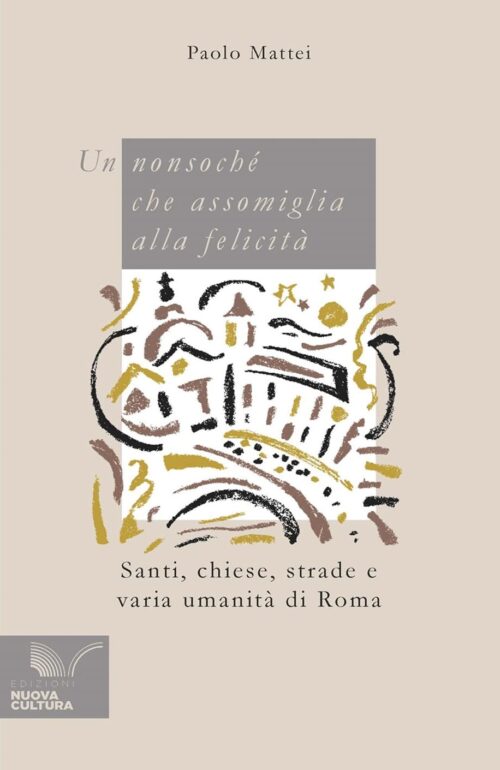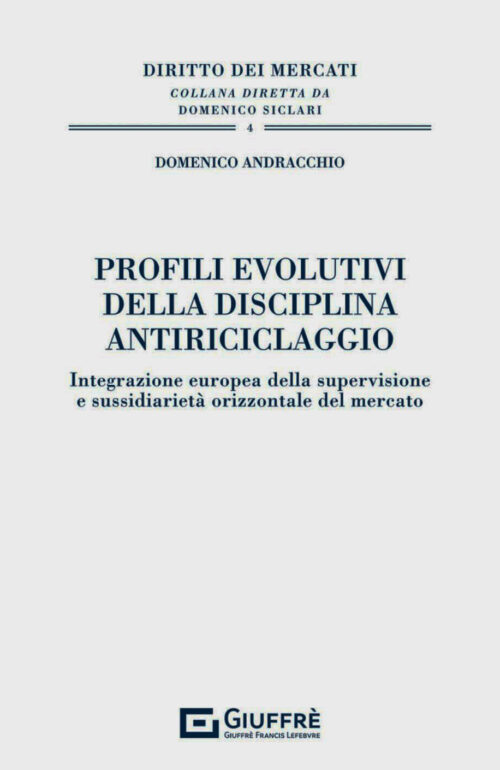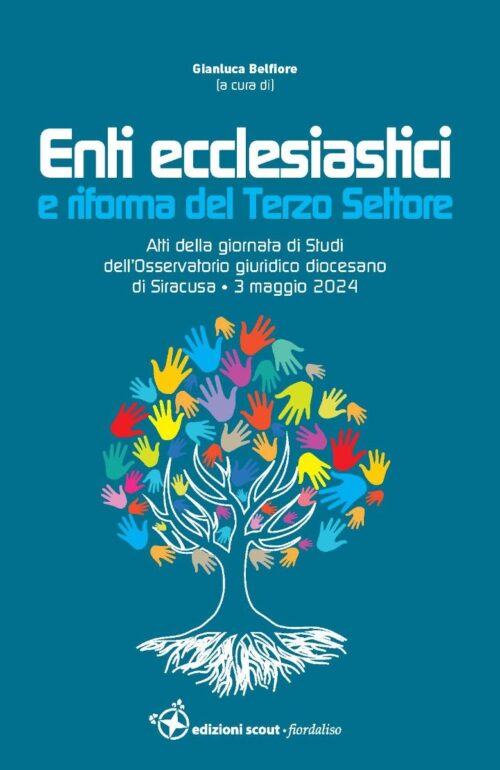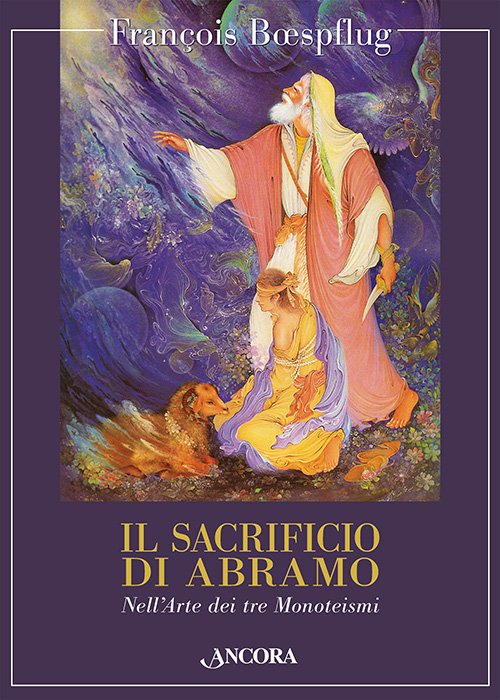Palazzo Braschi dà finalmente volto e voce a 56 diverse artiste che dal XVI al XIX secolo hanno vissuto e operato nella Roma Capitale delle Arti. Il titolo Roma pittrice richiama l’epiteto molto usato nella storiografia sei-settecentesca e vuole sottolineare l’importanza del talento artistico femminile, a lungo rimasto nel silenzio.
L’esposizione, a cura di Ilaria Miarelli Mariani (Direzione Musei Civici Sovrintendenza Capitolina) e Raffaella Morselli (Sapienza, Università di Roma), con la collaborazione di Ilaria Arcangeli (PhD Università di Chieti «G. D’Annunzio»), fa emergere questa presenza artistica attraverso un percorso cronologico e tematico di circa 130 opere, alcune inedite o esposte per la prima volta. Può sorprendere il fatto che qualche artista sia rappresentata da un numero esiguo di opere, nel caso di Giustiniana Guidotti addirittura da una sola. Ma proprio quell’unico esemplare assume qui una valenza enorme: la scarsa documentazione e l’errata attribuzione delle opere, spesso confuse con quelle di maestri e di familiari, fanno sì che di molte di loro non si conosca ancora la reale produzione.
Grazie al codice QR presente in alcune didascalie, le artiste stesse si raccontano al visitatore, narrando le sfide che hanno dovuto affrontare, in primis le rigide limitazioni sociali e culturali, come ad esempio il potersi dedicare inizialmente solo ad alcuni generi (la miniatura, la natura morta, il ritratto) e non ad altri (la pittura di storia), oltre alla difficoltà di entrare a far parte delle accademie accreditate, come quella di San Luca, dell’Arcadia o dei Virtuosi al Pantheon.
La prima voce che si incontra è quella di Lavinia Fontana, «Pontificia pittrice» del Cinquecento, che ci fa immergere in una realtà comune per l’epoca, la bottega del padre, luogo in cui spesso si muovevano i primi passi del proprio percorso artistico. Il ruolo della figura paterna risulta cruciale per molte artiste: a volte vero sostegno e scudo per la carriera, a volte nemico silente.
Nella ritrattistica di Lavinia emergono con forza gli aspetti psicologici ed emotivi dei personaggi, senza però che siano tralasciate le «imperfezioni», come nel Ritratto di giovane nobildonna (1590-1600 ca.), dove si intravede una peluria scura sopra le labbra.
Le protagoniste per eccellenza in Artemisia Gentileschi sono invece le figure femminili, molto intense e drammatiche, prima fra tutte Giuditta, che riprende dal padre, ma con toni molto più cupi, forse segno indelebile della ferita subita nel corpo e nell’anima.
Oltre ai ritratti, sono presenti anche finissime nature morte seicentesche che testimoniano la perizia dell’esecuzione da parte delle artiste in questo particolare genere, tanto che una di esse, Laura Bernasconi, fu soprannominata «dei Fiori».
Viene dato spazio anche all’arte incisoria con Laura Piranesi, figlia del noto Giovan Battista, e all’architettura con Plautilla Bricci, «l’architettrice» che progettò l’ormai perduta Villa Benedetta a forma di vascello.
Attraverso le parole della nota pittrice internazionale Angelica Kauff-mann si entra nel vivo del Settecento. La sua casa-atelier in via Sistina divenne presto crocevia per le migliori menti dell’epoca. A «Miss Angel» fu inoltre concesso dal cardinale Acquaviva di dipingere nel giardino di Villa Malta, attuale sede de La Civiltà Cattolica, dove pare abbia incontrato più volte il famoso scrittore Johann Wolfgang Goethe. Nella mostra, la sua Speranza (XVIII secolo) rappresenta una giovane dallo sguardo intenso che si appoggia a un’àncora, si può osar dire di salvezza, che le valse l’ammissione alla prestigiosa accademia di San Luca.
Sempre del XVIII secolo è il fenomeno dei grandtourists che aveva determinato un aumento delle commissioni di copie, anche a carattere religioso; ne è un esempio la brulicante Cena in casa del fariseo (1748) di Maria Felice Tibaldi, la prima opera di una artista vivente a essere acquistata da papa Benedetto XIV per la Pinacoteca Capitolina.
Ma, oltre alle donne figlie di pittori, vanno ricordate quelle costrette dentro le mura dei conventi, come Maria Luisa Raggi, prima pittrice di paesaggio nota in Italia, che si dedicò alla pittura per tutta la vita.
L’Ottocento vede tra le numerose protagoniste la «pittrice e patriota» Emma Gaggiotti-Richards, la cui passione per le armi spicca in tutta la sua veemenza nel suo Guerriero (1865), dallo sguardo di fuoco e le mani frementi, pronte a sguainare la spada, testimone silenzioso delle tante lotte che l’autrice, e come lei molte altre, hanno dovuto intraprendere.
La mostra non termina dentro le mura di Palazzo Braschi, ma prosegue «itinerante» per la città, grazie a una mappa cartacea messa a disposizione dei visitatori, che indica le opere delle artiste presenti in altri luoghi pubblici accessibili.
Un ulteriore pregio è l’attenzione riservata alle persone ipovedenti, che possono accedere alla fruizione tattile di alcune opere, gustando così questo patrimonio poco conosciuto. L’esposizione si rivela sicuramente un buon punto di partenza per stimolare l’interesse nei confronti di artiste spesso trascurate, dando così valore a una alterità, quella femminile, che non è «migliore» o «peggiore» di quella maschile, ma semplicemente diversa, da scoprire e accogliere.