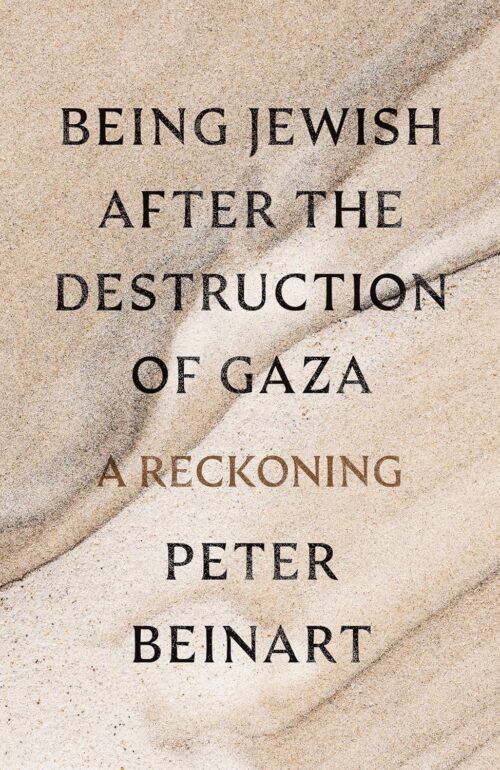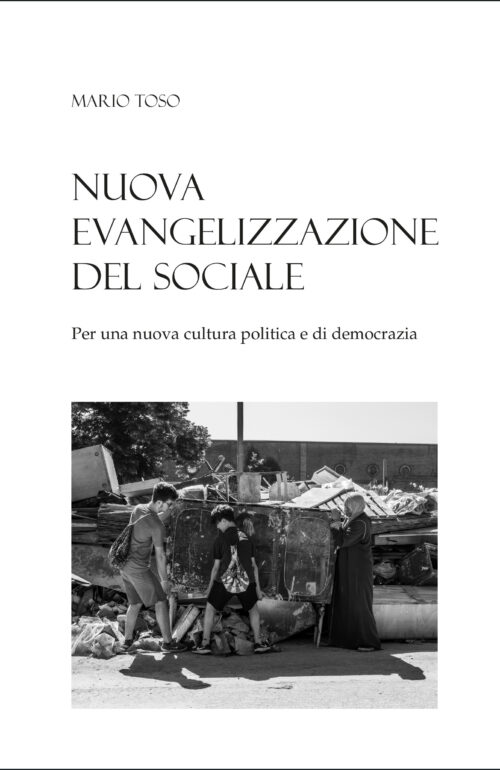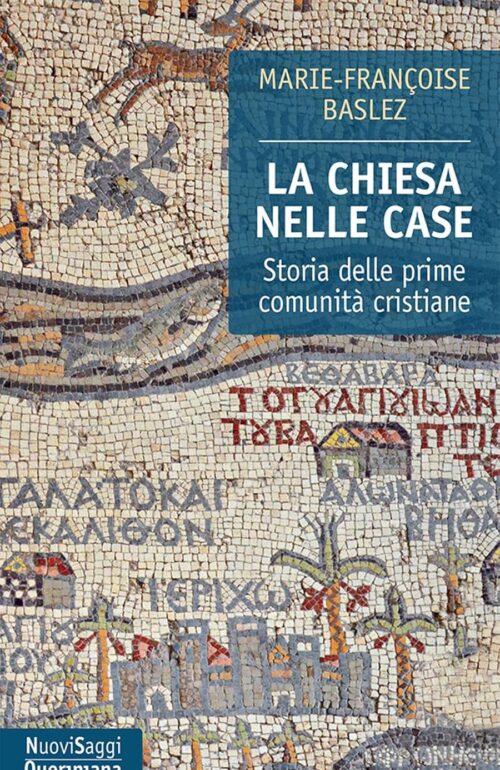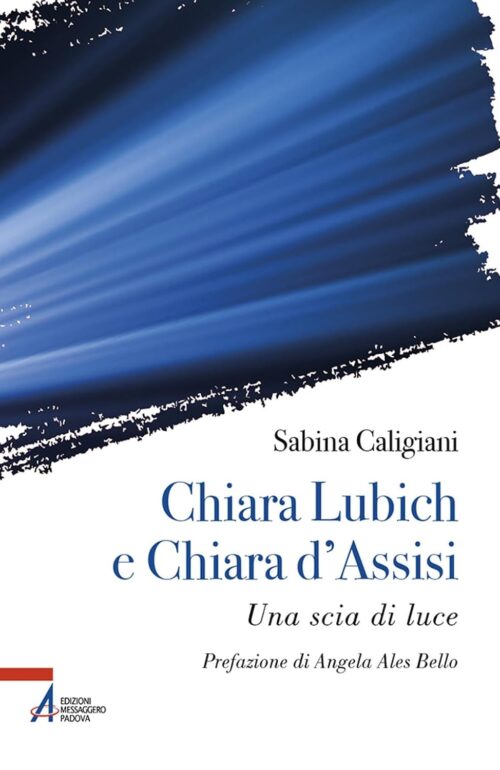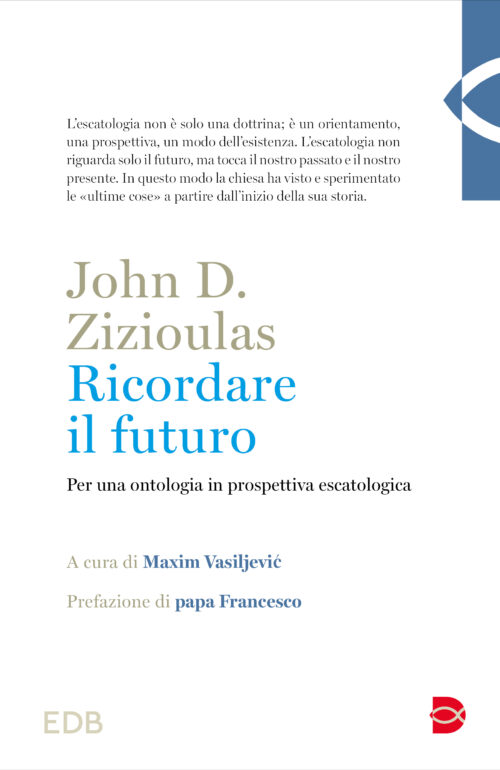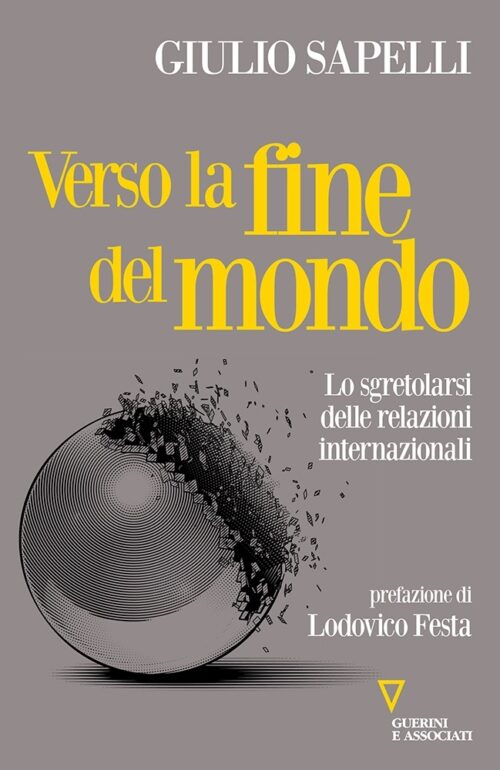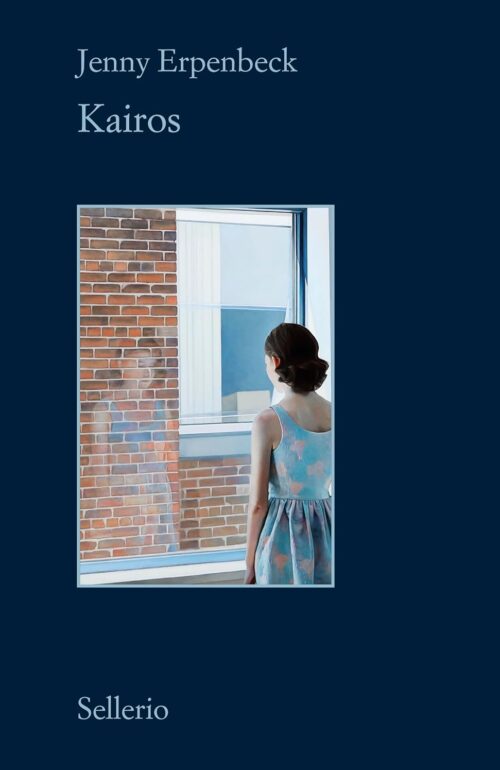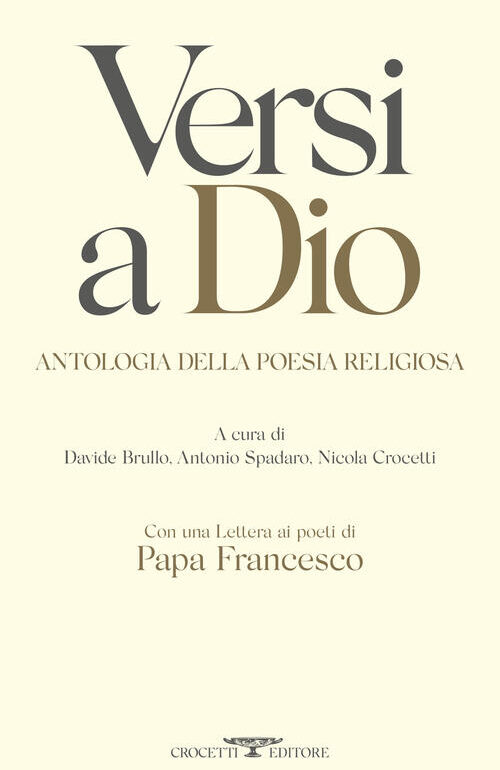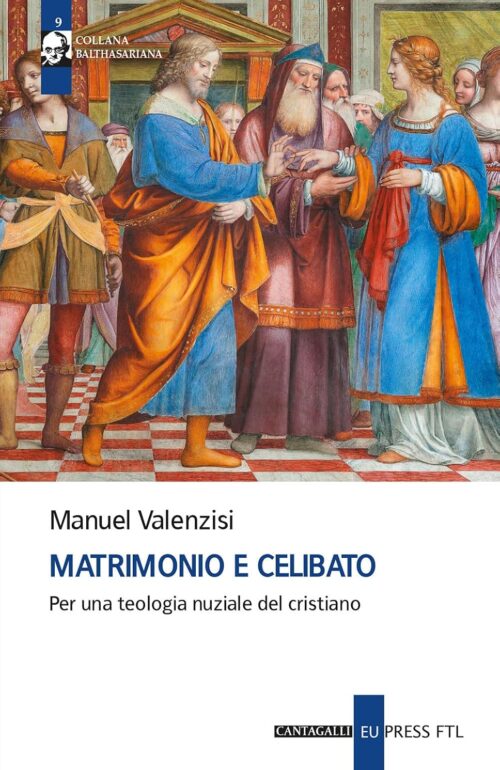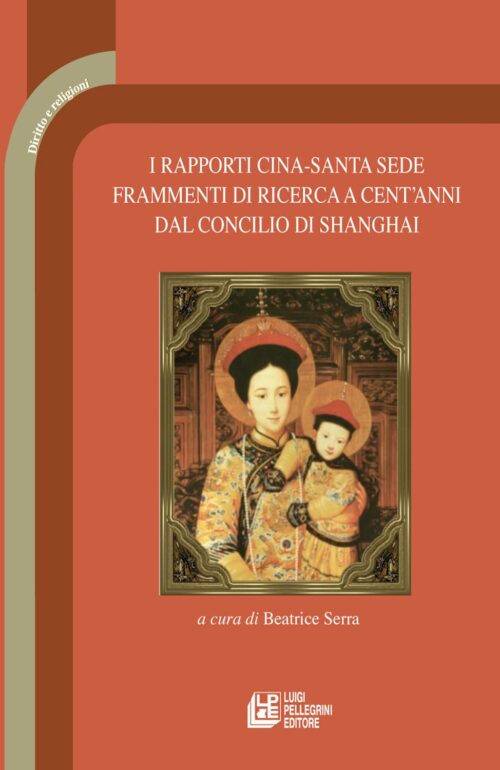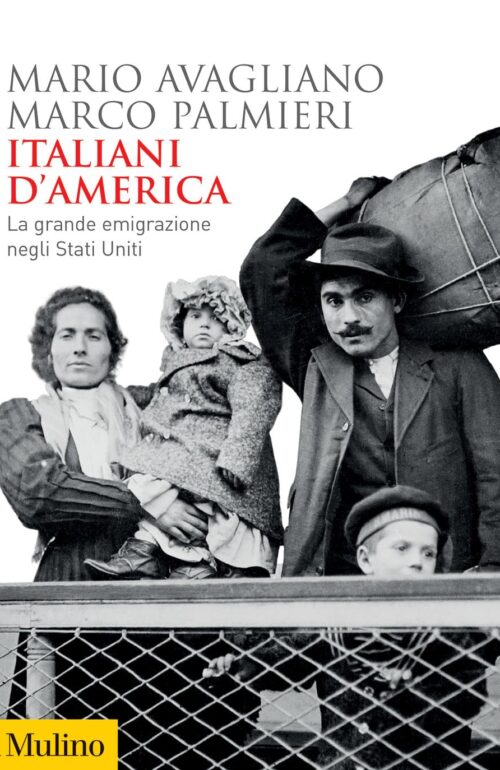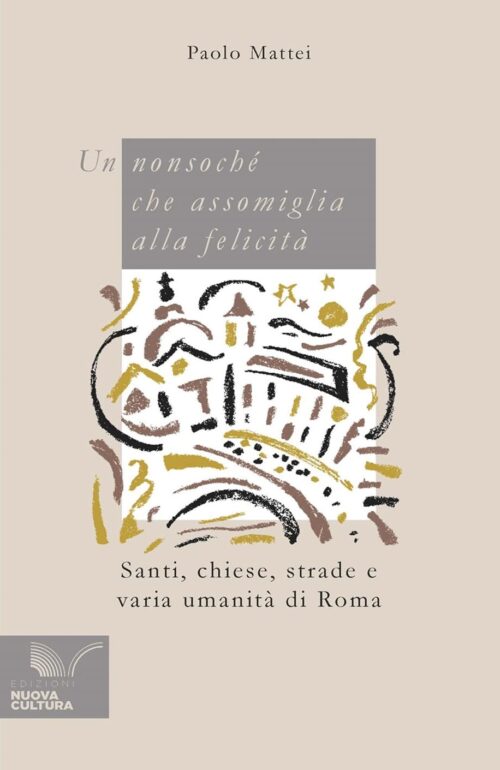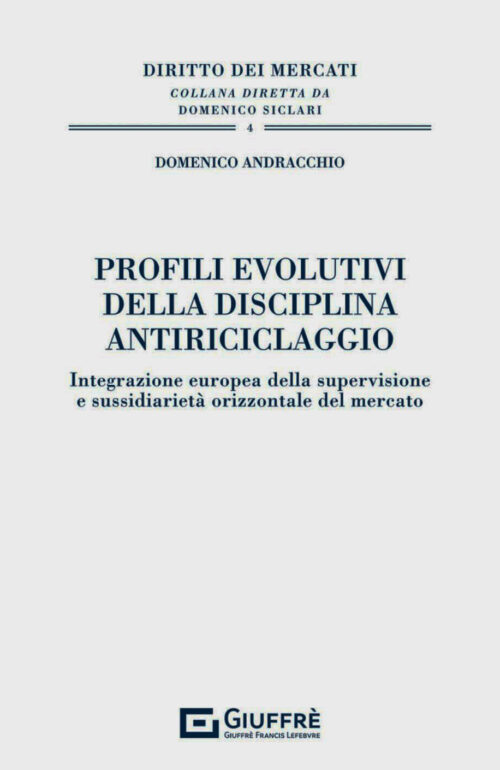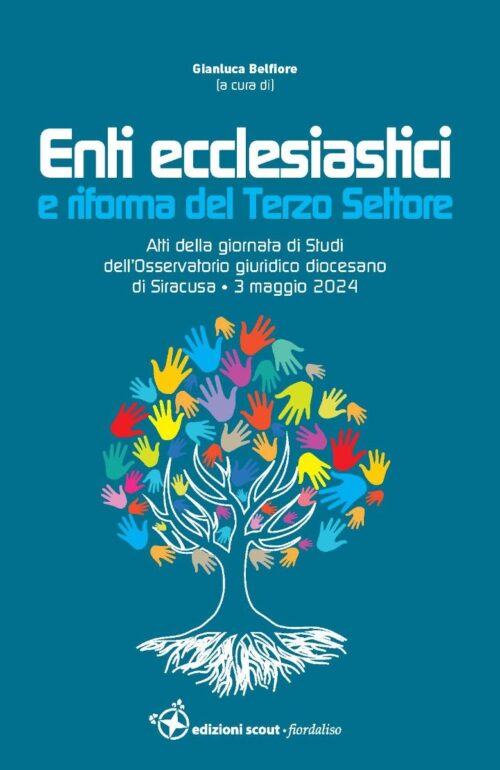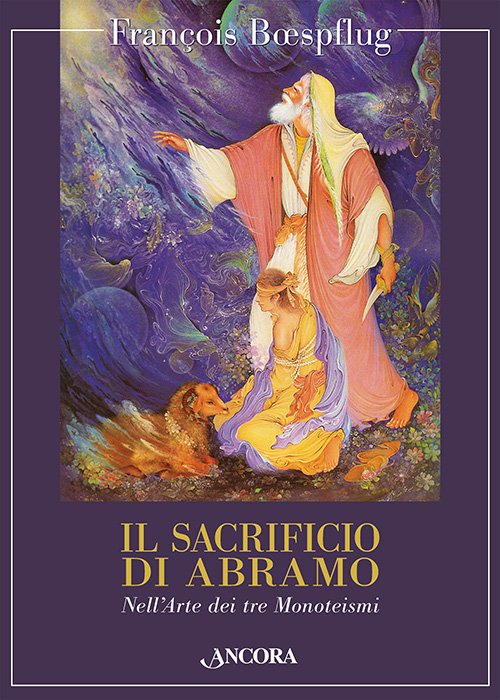La mostra Tony Cragg. Infinite forme e bellissime, curata da Sergio Risaliti e Stéphane Verger, si svolge in due contesti: tre sculture sono state inserite nel tessuto urbano della città di Roma (nelle piazze di San Silvestro e San Lorenzo in Lucina); altre 18 hanno trovato collocazione nelle suggestive sale del Museo nazionale romano delle Terme di Diocleziano. L’assenza di qualsiasi apparato descrittivo – fatta eccezione per il pannello di presentazione – costringe il visitatore a lasciarsi interrogare dalle sculture di Tony Cragg in maniera estremamente libera. Uno sforzo, questo, proprio dell’arte contemporanea, la cui interazione e comprensione è demandata al tempo e all’ascolto di ciò che l’opera d’arte suscita in chi la osserva.
L’artista, nella sua ricerca scultorea, vuole risignificare la materia con un’attitudine quasi profetica; infatti, il suo impegno è tutto rivolto alla conoscenza e al superamento della stessa. Liberare la materia dai limiti, dimostrare le infinite possibilità trasformative che l’uomo può mettere in atto in un processo creativo è il suo desiderio principale. Quasi inaspettatamente, all’interno delle alte mura delle Terme dioclezianee tutto acquisisce un senso: i panneggi delle sculture, i sarcofagi, i mosaici antichi lì conservati dialogano perfettamente con le opere dell’artista britannico; come loro antenati, sembrano assistere alla loro naturale evoluzione.
Ciò che contraddistingue l’arte di Cragg è la sua capacità di rendere la materia esplosiva: basta osservare Spring, per constatare come il legno si liberi della sua verticalità, in una forma che ricorda il felice irrompere della primavera. L’artista è capace di compiere un’effettiva metamorfosi, grazie alla quale il metallo, la pietra e il legno sono in grado di perdere la propria riconoscibilità, manifestandosi nella loro essenza, nuova e sorprendente. Il modo di scolpire di Cragg diventa allora un monito per ricordarci di andare al cuore delle cose. La sua non è solo una metamorfosi della materia che trova il culmine con la realizzazione dell’opera, ma la trasformazione continua nell’occhio dell’osservatore, che elabora nella mente linee, forme e colori. È lo stesso impatto visivo, la stessa velocità che si ritrova, ad esempio, nel Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini. È la potenza della tridimensionalità, propria della scultura, che è manifestazione di un dinamismo, di una fugacità, e possiede un ritmo musicale, fatto di pause e accelerazioni che risuonano dentro ciascun osservatore. Sono le stesse sensazioni di cui ha scritto Winckelmann per l’Apollo del Belvedere, stupito dal «continuo passaggio d’una forma nell’altra e la morbidezza dei tratti che come onde si sollevano, si abbassano e si confondono» (J. J. Winckelmann, Il bello nell’arte, Torino, Einaudi, 1943, p. 115). I pieni e i vuoti, le dolci curve e gli acuti spigoli che ritroviamo nelle opere di Cragg richiamano le stesse sensazioni.
Le sculture dell’artista britannico sono velate da un senso misterico, talvolta tragico, eppure sono sempre animate da una spinta verticale, che supera la tensione drammatica. La scultura ha sempre a che fare col «togliere»: la materia da cui si parte viene modellata andando a togliere il superfluo. Fare scultura è portare alla luce qualcosa che è nel profondo, che va liberato; è scoprire la luce dentro di noi. Si potrebbe quindi dire che l’atto di scolpire ha a che fare con la Trasfigurazione di Cristo. La metamorfosi, infatti, è costitutiva dell’evento trasfigurativo: ciò che cambia è la forma, non la materia; è materia rivestita di nuova luce. Cristo, trasfigurandosi, non ha cambiato la sua materia, ma ha visto e ha fatto vedere cosa c’è oltre, la promessa di cosa sarà. Allo stesso modo, le sculture di Cragg raccontano di una promessa, lasciandosi condurre dalle linee; alla musica delle sue forme, si viene trascinati oltre, lontano, in uno spazio dove si può essere migliori.