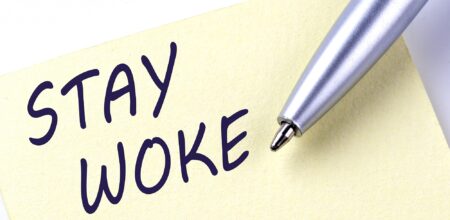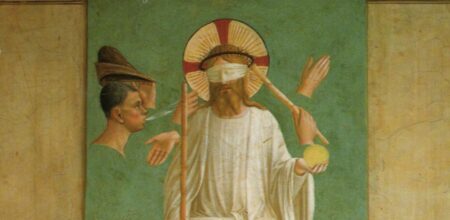Il James Webb Space Telescope (JWST) è partito dal sito di Kourou (Guyana francese). Un lancio che la comunità di astronomi e astrofisici stava aspettando dal 1996, anno di presentazione del primo concept di questo telescopio, che sia dal punto di vista ingegneristico che scientifico, presenta sfide completamente nuove per le agenzie spaziali NASA, Agenzia Spaziale Europea e Canadian Space Agency che si sono impegnate a realizzarlo.
Il lancio del JWST, tramite il razzo Ariane 5, è avvenuto alle 09:20 am EST del 25 dicembre 2021: è possibile seguire gli aggiornamenti e lo sviluppo della missione direttamente sul sito della Nasa.
For years, we’ve been answering the question: When will #NASAWebb launch? This morning, we answered that for the last time! Next up: Where is Webb? We’ve got an answer for that, too!
See where Webb is on its million mile journey to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/EZC60K56YN pic.twitter.com/edQ2XxNqyn
— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021
Una volta lanciato il telescopio porterà avanti delle manovre per arrivare nel «punto L2», situato a 1,5 milioni di km dalla Terra. Le attività scientifiche e di ricerca inizieranno dopo qualche mese, visto il complesso meccanismo di apertura del telescopio. La prima immagine è attesa per l’estate.
James Webb è uno tra gli strumenti scientifici più complessi mai costruiti dell’uomo e data la grande distanza che lo separerà dalla Terra, rispetto al predecessore Hubble, in caso di problemi di apertura o negli strumenti non sarà possibile intervenire. I rischi più temuti sono principalmente tre: le basse temperature alle quali dovrà operare, le vibrazioni della fase di lancio che potrebbero danneggiare la strumentazione e la difficoltà delle operazioni previste per il dispiegamento dello specchio.
Indicato da anni proprio come il successore designato di Hubble, il suo lancio è stato rimandato più volte nel corso del tempo, anche a causa della pandemia degli ultimi due anni. Bisogna anche dire che nel frattempo i costi del progetto sono lievitati dai 400 milioni di dollari iniziali agli attuali 12 miliardi di dollari, circa.
JWST sarà in grado di aprire una nuova porta nello studio dell’astronomia e dell’astrofisica. Uno dei suoi obiettivi più affascinanti è legato allo studio dell’universo primordiale: questo sarà possibile grazie agli strumenti che permetteranno a James Webb di studiare, tramite lo spettrografo, la luce infrarossa emessa dalle prime stelle e dalle prime galassie che si siano formate nell’universo. La missione sarà parte di un processo di conoscenza che abbraccerà anche lo studio delle atmosfere di esopianeti lontani e la comprensione dei meccanismi di evoluzione dei sistemi planetari. Alcuni si attendono anche prove, i cosiddetti «biomarcatori», dell’esistenza di pianeti in grado di ospitare vita extraterrestre.
Le missioni come JWST non sono solamente una potenziale incredibile fucina di scienza e ricerca, ma aiutano a costruire un immaginario connesso allo spazio e alla sua percezione del nostro posto nell’universo.
Le aspettative sono dunque tantissime. Ma faremo davvero nuove «scoperte»? È possibile ed è auspicabile. Ma come ha annotato l’astronomo p. James Kurzynski, sul sito dell’Osservatorio Vaticano, diretto dal gesuita Guy Consolmagno, c’è il rischio che la parola «scoperta» contribuisca ad alimentare quella mentalità di dominazione che l’ha spesso accompagnata, anche nelle missioni spaziali. Sarebbe molto più opportuno, in una prospettiva di relazione, parlare di «incontro».
(aggiornato il 27 dicembre 2021)