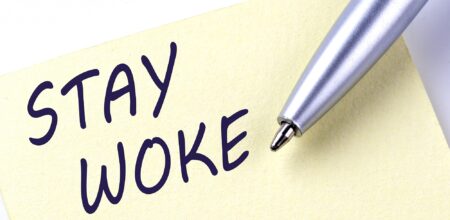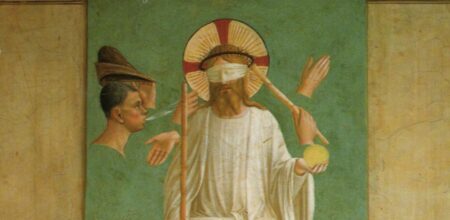La comunità scientifica appare ormai concorde nell’affermare che l’universo in cui viviamo è nato quasi 14 miliardi di anni fa con un evento cosmologico che convenzionalmente chiamiamo «Big Bang», usando un’espressione coniata in senso dispregiativo da Fred Hoyle. Subito dopo l’universo ha subìto un’espansione esponenziale, nota come «inflazione». Circa 400.000 anni dopo il Big Bang, l’universo ha emesso la sua prima luce, e poi, a poco a poco, si sono formate tutte le strutture.
📌Acquista e scarica il volume!
Prima di giungere alle attuali teorie, lo sviluppo storico della concezione dell’universo è stato ricco di tappe e grandi dispute: dalla visione «piatta» assiro-babilonese a quella aristotelica, seguita durante tutto il Medioevo e ripresa anche nella cosmologia e teologia di san Tommaso d’Aquino; dalla intuizione tolemaica alla rivoluzione copernicana, e poi via via i contributi di Keplero, Newton, Kant, Laplace e Olbers fino alla cosmologia relativistica, ispirata da Einstein.
Albert Einstein è a ragione considerato lo scienziato che, più di tutti gli altri, ha dato contributi fondamentali alla fisica del XX secolo. In particolare, intuì le implicazioni che le nuove teorie della fisica dei quanti potevano avere in tutti i campi della scienza, ma anche della filosofia, ossia della comprensione della realtà a tutto tondo. «Il problema quantistico – disse in un’occasione – è così straordinariamente importante e difficile che dovrebbe essere all’attenzione di tutti». D’altra parte, nel 1954, due anni prima della sua morte, Einstein scrisse in una lettera al fisico americano David Bohm: «se Dio ha creato il mondo, non possiamo dire che si sia preoccupato molto di facilitarne la comprensione».
Sappiamo che Einstein non si riferiva a un Dio personale, ma piuttosto a un’Entità superiore e onnisciente, che garantisce la regolarità delle leggi della natura. In ogni caso le domande ancora oggi aperte sono: come si è formato l’Universo? C’è qualcuno o qualcosa che fa funzionare così le cose? Ed è sostanzialmente su queste domande, e sulle possibili risposte, che la ricerca scientifica e la religione si incontrano e si scontrano da secoli. Fin dall’antichità è esistito uno stretto connubio tra cosmologia e religione. Tuttavia i contrasti ci inducono a pensare che il giusto approccio sia quello della separazione fra il piano teologico e quello scientifico. Ciò però non impedisce a qualcuno di vedere nell’armonia e nell’ordine dell’universo una bellezza che rispecchia l’impronta del Creatore e l’Amore con cui Egli ha creato e intessuto l’universo. Tanto che nel 1951 Pio XII affermò la compatibilità tra il Big Bang e il racconto della creazione del mondo nel libro della Genesi.
Comunque, nonostante tutti i progressi fatti nella scienza, e in particolare nella cosmologia attuale, certamente va sfatato il mito di una scienza «precisissima», senza alcuna ombra. La verità invece è che anche i modelli scientifici di cui siamo oggi in possesso e di cui ci serviamo per descrivere la natura hanno dei limiti, e quindi non possiedono affatto quel carattere di infallibilità che lo «scientismo» dogmatico vorrebbe attribuire a essi.
Questo volume, il numero 15 della nostra collana monografica digitale «Accènti», nasce così all’incrocio di una serie di questioni e di «fenomeni»: il rinnovato interesse per il cosmo animato dalla ricerca spaziale, con la recente missione su Marte della Nasa e le iniziative di alcuni tycoon privati come Elon Musk; una sempre più profonda curiosità per i concetti della fisica contemporanea, specialmente per la meccanica quantistica; e, infine, un anniversario significativo: esattamente 100 anni fa Albert Einstein riceveva il premio Nobel «per i contributi alla fisica teorica, in particolare per la scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico».
Nella prima parte del volume sono raccolti alcuni saggi che provano a circoscrivere il campo della domanda religiosa sulle questioni cosmologiche. Innanzi tutto, due articoli di Paolo Beltrame. Nel primo, prendendo spunto da una celebre disputa tra Einstein e Bohr, si mostra come la meccanica quantistica, pur costituendo la migliore e più accurata teoria scientifica, sia una finestra su una realtà sconcertante, contraddittoria ed enigmatica, che si fonda sulla casualità e sull’indeterminazione. Ciò deve essere paradossalmente un incoraggiamento per la teologia e la spiritualità cristiane a conoscerne le implicazioni e ad accoglierne la visione del mondo, dentro una realtà come la nostra che è essenzialmente concepita come relazione. Nel secondo, si riflette sul grande mistero della vita sulla Terra che, da un punto di vista cosmologico, è frutto di una condizione estremamente delicata, quasi «miracolosa». Questo è noto come «il problema del fine tuning cosmologico». L’articolo mostra che la presenza di un Creatore non è un limite per la ricerca di spiegazioni naturali sempre più profonde, bensì un’ispirazione e uno stimolo a indagare scientificamente e coraggiosamente la verità. A seguire, Gabriele Gionti analizza innanzi tutto lo sviluppo storico della concezione dell’universo, per poi presentare una teoria per i primi istanti dell’universo e mostrare come il concetto cristiano di creazione sia completamente diverso da quello del dio-demiurgo degli scienziati. Guy J. Consolmagno illustra poi il lavoro di ricerca che si svolge in un osservatorio astronomico, con il suo significato non soltanto scientifico ma anche spirituale; e spiega come il lavoro dell’astronomo sia in stretta relazione con le tre virtù cardinali, e quindi altamente qualificante anche per un religioso. Infine, un saggio di Giandomenico Mucci descrive il contributo di Ian Barbour, fisico e teologo, alla dimostrazione dell’infondatezza del conflitto tra fede e scienza, piuttosto vedendo nel dialogo e nell’integrazione la giusta via praticabile per l’interazione delle due realtà e dei saperi che ne derivano.
Nella seconda parte del volume, ci concentriamo su alcune questioni cosmologiche ancora aperte. «Siamo soli nell’universo?». Ancora con p. Mucci ci soffermiamo su una ipotesi assai discussa a metà del Novecento, poi dimenticata e di recente riemersa, riportando anche le questioni cristologiche che questa ipotesi apre. Seguono due saggi co-firmati da Gabriele Gionti e Alfredo Sgroi. Nel primo affrontano alcuni aspetti dello sviluppo storico del concetto di infinito, partendo dall’età classica fino alle antinomie di Kant sull’estensione spaziale dell’universo (finito contro infinito) e alla relativa critica del matematico Cantor. Nel secondo si immergono nella teoria del tempo, mostrando con Husserl l’attualità del pensiero di sant’Agostino su questo argomento. Ciò che gli autori intendono dimostrare è che la scienza potrà magari chiarire un giorno come il tempo è, ma certamente non perché esso è. Con un articolo di Giuseppe Koch ci addentriamo poi nel campo delle onde gravitazionali, modificazioni della struttura dello spazio-tempo, che possono darci informazioni sui primi momenti dell’universo. Il volume si chiude con una riflessione di estrema e rinnovata attualità, a cura di p. Consolmagno, sulle opportunità e i rischi legati alla ricerca e all’utilizzo delle risorse del sistema solare. Dobbiamo riconoscere i benefici delle esplorazioni spaziali per l’umanità; ma, come ci ricorda l’enciclica di papa Francesco Laudato si’, dobbiamo essere anche consapevoli che essi comportano costi sociali e aprono a potenziali nuove forme di disuguaglianza.
Ecco, dunque, il nostro Universo. Ringrazio il dott. Felice Di Basilio e il dott. Simone Sereni per il lavoro a questo mosaico che qui offriamo. Come si è compreso, questo volume di «Accènti» vuole essere un aiuto al lettore perché si interroghi sui grandi problemi cosmologici, ma intende anche testimoniare un’attenzione specifica della nostra rivista nei confronti dei temi scientifici.