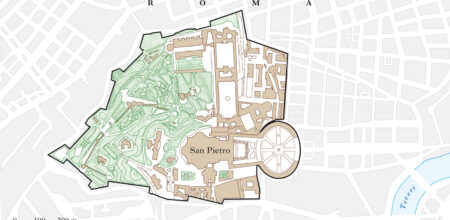|
|
Quando si parla di Shoah, il pensiero e la memoria mettono in fila soprattutto alcune immagini e alcuni contesti storici: la Germania nazista, la Polonia occupata, l’Italia fascista con la sua adesione alle leggi razziali, campi di sterminio e, in generale, l’antisemitismo covato ed esploso nell’Europa in balia di dittatori e totalitarismi artefici di una guerra che ha devastato nazioni e popoli. Ma c’è un aspetto della tragedia vissuta dal popolo ebraico meno noto e divulgato nella storiografia, che vede protagonista un Paese, la Cina, lontano dal teatro bellico, e in particolare una città che si è distinta per l’accoglienza data. Tra il 1933 e il 1941, Shanghai aprì le porte a oltre 18.000 ebrei, per lo più tedeschi e austriaci, che cercavano di salvarsi dalle persecuzioni naziste in Europa.
Una storia poco conosciuta, che racconta l’eccezionalità di una scelta a fronte di una «politica» comune fatta di restrizioni all’immigrazione imposte dalla maggior parte degli Stati. «Nel 1939, il transatlantico tedesco Saint Louis, con a bordo 944 ebrei, che avevano ottenuto a fatica il visto americano, si vide rifiutare l’ingresso nel porto di New York: il governo americano voleva costringerli ad aspettare in mare le “quote” dei due anni successivi. Come è noto, la Saint Louis chiese aiuto ai porti di Cuba, Santo Domingo, Panama, Inghilterra, Francia, Spagna e Portogallo e ottenne finalmente soccorso dopo sei mesi di vagabondaggio. […] Shanghai aprì loro la porta d’ingresso» (p. 29).
Una storia che, a distanza di 80 anni, diventa un paradigma attraverso il quale leggere anche l’attualità, le scelte politiche in materia di accoglienza, e misurarne errori e miopie. Negli anni drammatici del Secondo conflitto mondiale, Shanghai, chiamata «la Parigi d’Oriente» per la sua vivacità culturale e il profilo cosmopolita, divenne così la cornice di un’esperienza complessa ed esemplare di integrazione: migliaia di rifugiati trovarono asilo all’interno del ghetto di Hongkou, dove vissero a contatto con la popolazione locale, sperimentando la dinamica del confronto e della crescita, economica e culturale, comune. «Basta guardare la Shanghai degli anni Trenta e Quaranta per sapere che le ostilità interne, i massacri e le guerre non risolvono i conflitti di interesse, e che gli uomini hanno bisogno di collaborazione e di convivenza pacifica» (p. 43).
Al termine della guerra, il numero dei sopravvissuti era così elevato da far parlare di «miracolo di Shanghai». Attraverso i contributi storiografici raccolti nel libro, a cura di Elisa Giunipero, il lettore scopre un capitolo di storia, rimasto per lo più nell’ombra, importante per conoscere e comprendere la tragedia della Seconda guerra mondiale e della Shoah, in tutta la loro estensione.
Non solo, ma accanto alle vicende collettive, nei testi proposti dal libro si trovano le testimonianze e le vicende personali di chi ha contribuito con le proprie coraggiose scelte a rendere «miracolosa» quella esperienza: la famiglia di Sonja Mühlberger, nata a Shanghai nel 1939, da genitori ebrei tedeschi arrivati lì grazie a un visto, e la storia esemplare del console cinese a Vienna Ho Feng Shan, il quale, opponendosi ai suoi superiori, concesse il visto di espatrio a molti ebrei in fuga dal Terzo Reich.
«Il console cinese si trovò davanti a una scelta: fare il bene della Cina o fare il bene degli ebrei? […] Qual era il vero bene della Cina? La difesa del carattere morale della nazione o la salvaguardia di un interesse politico contingente, come poteva essere appunto la relazione con un Paese potente [la Germania]?» (p. 71). Ho Feng Shan fece la scelta più rischiosa; la «compassione provata per le sofferenze degli ebrei ha fatto la differenza», e «la sua coscienza personale è diventata per qualche mese la coscienza del suo Paese che ha aperto le porte ai perseguitati» (p. 74). A dimostrazione che nella storia «è la resistenza del bene possibile la diga più importante nei confronti di un qualsiasi progetto totalitario che vuole rendere superflua l’esistenza di una categoria di esseri umani» (pp. 75 s).
L’esempio del console cinese, secondo la visione di Moshe Bejski – l’artefice del «Giardino dei Giusti» di Gerusalemme –, consente di «scoprire che in ogni essere vivente esiste sempre una potenzialità per resistere al male» e riconciliarsi con le contraddizioni di questo mondo, continuando a costruire ponti di pace per il futuro.
Ebrei a Shanghai. Storia dei rifugiati in fuga dal Terzo Reich
a cura di ELISA GIUNIPERO
Milano, O barra O edizioni, 2018, 96, € 14,00.