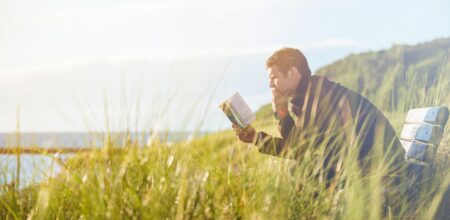|
|
La vasta area che va dal Marocco al Turkestan orientale e giunge a lambire tanto l’India quanto la Cina, e che si estende dai Balcani allo Yemen, comprendendo anche la regione situata tra la Libia e l’Afghanistan, va assumendo una sempre maggiore centralità nell’ambito degli equilibri e delle relazioni internazionali. La sua storia tende così a identificarsi gradualmente con quella del mondo intero, e ogni riflessione che la riguarda non può non interessarci dal momento che – presto o tardi – saremo costretti a tenerne conto.
Convinto che non si possa comprendere il presente se non si ha un’idea chiara del passato, e giunto ormai alla soglia dei settant’anni, il politologo Robert Kaplan ha scritto questo libro, assemblandovi elementi di storia, geografia, viaggi, reportage e memorie in relazione ad alcune porzioni del Grande Medio Oriente. Intenzionato a non lasciarsi suggestionare dalle prime impressioni, ha cercato di combinare libri letti e voci udite, in modo da rendere l’analisi lucida e penetrante, capace di individuare nessi inattesi e di stimolare la curiosità del lettore, di cogliere aspetti suggestivi e riferimenti degni di nota.
Oggetto della sua indagine è appunto il Grande Medio Oriente: un territorio desertico e pianeggiante, abitato da popolazioni in gran parte di religione islamica, che egli scopre a poco a poco, strato dopo strato, avvalendosi anche di un cospicuo numero di contributi redatti da storici, antropologi, politologi, filosofi, sociologi e diplomatici. Kaplan rievoca epoche e paesaggi, muovendosi agilmente tra contesti complessi sulla base di una sola certezza: «Attraversare un paese, annusarne gli odori, guardare come si comportano le persone, non offre risposte definitive, ma aiuta. Permette di toccare con mano il terreno, per non lasciare che i luoghi reali si dissolvano e diventino astratti» (pp. 134 s).
Lo studioso non manca di mettere in rilievo, in primo luogo, la frammentazione che ha avuto luogo in questi territori nel periodo successivo alla fine del colonialismo e alla conclusione della «guerra fredda»: un fenomeno del quale dovremmo essere consapevoli, visto che Paesi come la Siria, l’Iraq e l’Afghanistan non sono riusciti a integrare le loro efficienti società tradizionali – le quali funzionano da tempo immemorabile senza regole troppo rigide – nelle strette maglie dei moderni sistemi statali concepiti e messi a punto dall’Occidente. Appare poi chiaro come una simile frizione implichi grandi cambiamenti, che vanno a sommarsi a quelli verificatisi nel corso della prima e della seconda età moderna: più il tempo passa, però, più il Medio Oriente sembra sopraffatto dall’intensità dell’integrazione.
In termini generali, occorre osservare che lo sguardo di Kaplan si rivela fecondo, capace di riflettere su eventi e scenari, millenni e dinastie, caos e imperi. Egli rivolge la propria attenzione in particolare all’Egitto, all’Etiopia, all’Arabia Saudita, alla Siria, all’Iraq e all’Iran, Paesi riguardo ai quali sviluppa un’analisi che lo induce a porsi alcuni pressanti interrogativi: «Quale direzione prenderà il corso delle cose? Quali dimensioni politiche assumerà questa vasta regione che occupa gran parte della fascia subtropicale tra l’Europa e l’Estremo Oriente? Riuscirà a tirarsi fuori da decenni di instabilità e malgoverno e a trovare un compromesso tra la tirannia da un lato e l’anarchia dall’altro?» (p. 24).
Interrogativi che dovremmo prendere in seria considerazione, alla luce di un’epoca caratterizzata dal disordine globale, dalla mancanza di potenze capaci di intervenire ovunque, dalla presenza di medi attori desiderosi di imporre la propria egemonia – sebbene in un ambito circoscritto –, dal moltiplicarsi delle aree e dei focolai di crisi, dalla persistente incertezza del contesto economico-finanziario.