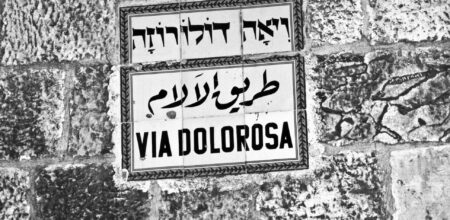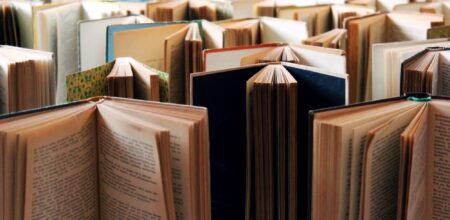|
|
«Raggiungere quell’alto silenzio in cui non si sente più neanche la musica poiché essa è silenzio, raggiunger il muto fervore dello spazio» (p. 5): con questa citazione di Georges Braque, Stefano Esengrini introduce il volume da lui curato. Cosa può voler dire l’espressione «il muto fervore dello spazio»? Lo spazio – da intendersi in modo ampio, come quella «dimensione in cui ha luogo l’esistenza dell’uomo» (p. 8), nella sua quiete, nel suo silenzio, nel suo «mutismo» – possiede, inaspettatamente e in modo raccolto e preservato, quella fervida pace che è armonia, nella quale tutte le cose cominciano a entrare in dialogo tra loro, presentandosi in tutta la loro freschezza sorgiva.
Questa dimensione misteriosa e silenziosa delle opere artistiche dell’A. attraversa le tredici significative conversazioni sull’arte che egli ha tenuto dal 1928 al 1963 e che compongono questo volume. In un contesto storico-artistico, nel quale si avverte la tendenza a ridurre la straordinaria rilevanza dell’opera di Braque al contributo da lui fornito, insieme a Picasso, alla fondazione del cubismo, attraverso un approccio diacronico e, per certi aspetti, metafisico, questa antologia di testi ripercorre, con una visione prospettica più compiuta, il suo cammino figurativo e umano.
Precedute ciascuna dalla riproduzione di uno specifico dipinto, le tredici conversazioni affrontano queste tematiche: I. «L’emozione e la regola» (1928); II. «Pittura e realtà» (1935); III. «Il pittore e il suo tempo» (1939); IV. «Il conformismo in arte» (1947); V. «La poesia in arte» (1950); VI. «Il senso dell’arte moderna» (1954); VII. «Il mio cammino» (1954); VIII. «La potenza del mistero» (1957); IX. «L’avventura dell’arte» (1959); X. «Sul cubismo» (1961); XI. «Continuità e rinnovamento» (1961); XII. «La vita raccolta delle cose» (1963); XIII. «L’arte e la vita» (1963).
Da queste conversazioni si ricava l’idea che Braque ha dell’arte. «Amo la regola che corregge l’emozione» (p. 19), egli afferma nella prima conversazione, riprendendo così l’antico dibattito circa l’inizio dell’opera d’arte. Nel 1935 aggiunge che l’arte è «un fuoco che agisce non si sa con quale ampiezza e in quale direzione», e che la «sua azione sfugge all’artista che ha creato l’opera» (p. 27); essa poi si «sviluppa nelle facoltà sensitive e nell’attività spirituale dell’artista» (p. 26).
Ma dov’è, o cos’è, questa sorgente dell’arte che sembra tenere insieme artista, mondo e opera? L’A. dichiara che la sorgente, pur rimanendo una forza misteriosa e oscura, «non è un enorme buco nero che attira a sé ogni corpo e annienta la vita, ma piuttosto una fonte che l’alimenta e a cui l’uomo, posto che sia in grado di avvertirne il mormorio, deve la sua stessa possibilità di esistere in modo compiuto» (p. 11). Poi, nel 1939, egli afferma: «Quel che nella creazione può progredire e svilupparsi, si forma in un certo senso indipendentemente dalla volontà. Non si dà abbastanza credito alle forze oscure che ci trascinano, quelle che molti, nella loro messa a punto ottimistica dell’universo, pretendono di ignorare, quelle che, al contrario, bisogna controllare, avanzando con lentezza e ritrovando sempre davanti a noi quel mistero che cerchiamo di respingere» (p. 36).
Il fervido dinamismo muto, oscuro e vitale, racchiuso nello spazio circostante come nell’opera dell’artista, raggiunge il suo climax con gli Ateliers, e soprattutto con gli Oiseaux. Qui il bisogno ancora oscuro che genera l’opera d’arte, impossessandosi dell’artista, conduce al cuore delle cose, consegnando, attraverso l’opera stessa, quella rivelazione che è merito, ricompensa e grazia. La leggerezza del soffio dell’aria e del battito d’ali degli uccelli porta infine la serie tarda degli Oiseaux «alla piena manifestazione di quella dimensione libera e vasta da cui ha origine ogni cosa» (p. 9).
Condividendo l’idea secondo la quale «gli scritti di un pittore non saranno mai altro che l’espressione seconda, se non secondaria, di ciò che il pittore ha da dire. L’essenziale è altrove: sulla tela» (D. Fourcede), riguardo all’opera di Braque è comunque possibile «trarre giovamento dall’andamento disteso e dalla disinvoltura con cui lo stesso artista presenta, nel corso delle diverse conversazioni, le questioni che stanno a fondamento della sua produzione» (p. 6).
Le tredici conversazioni, raccolte qui insieme per la prima volta in italiano, propongono un’osservazione più completa del cammino di maturazione dell’A. come uomo e come artista.
GEORGES BRAQUE
Il muto fervore dello spazio. Conversazioni sull’arte
a cura di STEFANO ESENGRINI
Brescia, Morcelliana, 2017, 168, € 16,00