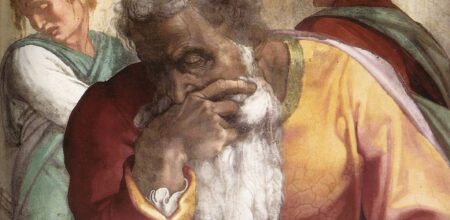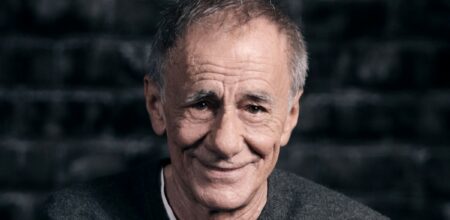|
|
La ricerca storiografica che si occupa dell’Italia contemporanea continua ad approfondire questioni e tematiche a lungo rimosse dalla memoria collettiva. La persecuzione fascista nei confronti dei cittadini di origine ebraica – una pagina tragica della nostra storia recente – rientra appunto fra tali argomenti dal momento che, per decenni, si è considerata non troppo severa la legislazione antisemita varata dal regime mussoliniano e si è ritenuto che responsabili degli arresti e delle deportazioni fossero esclusivamente i nazisti. Grazie al trascorrere degli anni, è finalmente venuta alla luce la radicalità dell’antisemitismo fascista ed è apparso nel suo pieno rilievo il ruolo che vi ha svolto lo stesso dittatore.
Occorre anzitutto osservare come nel 1938 le politiche persecutorie abbiano preso avvio dal settore dell’istruzione – considerato il cardine attraverso il quale sarebbe stato possibile dare agli italiani una nuova mentalità e identità –, nel cui ambito una funzione di fondamentale importanza venne attribuita agli atenei, che avrebbero dovuto contribuire alla formazione di una profonda, salda coscienza razziale.
Lo studio del ricercatore Emanuele Edallo ricostruisce, con meticolosità e rigore, il modo in cui la legislazione antiebraica è stata applicata all’Università di Milano: con uno zelo, cioè, meritevole forse di miglior causa. Un’analisi, la sua, che intreccia la macrostoria con le vicende dei singoli individui, evidenziando nel contempo come, nel dopoguerra, vi sia stata quella sostanziale rimozione degli eventi che travolsero l’esistenza di decine di professori, assistenti, incaricati e liberi docenti, della quale si accennava all’inizio.
Nella Presentazione, a proposito degli intenti perseguiti dalle autorità che avevano approvato le leggi razziali e dato luogo alla cosiddetta «arianizzazione», lo storico Massimo Castoldi scrive: «Colpire la minoranza ebraica era un modo per minacciare tutte le minoranze, politiche, culturali, religiose e linguistiche, per affermare in modo perentorio una logica totalitaria e violenta, che avrebbe di lì a due anni portato l’Italia a combattere una guerra di sterminio al fianco della Germania nazista» (p. IX).
Ma quanti furono gli studiosi colpiti dalla svolta antisemita decisa dal regime? Stando a questa ricerca, il loro numero ammonta a 40. Si trattò, in molti casi, di illustri cattedratici che avevano messo il proprio sapere a disposizione della causa fascista; personalità diverse – tanto per età quanto per esperienze –, le cui vite vennero tragicamente accomunate dalla persecuzione, giacché nessuno dei «dipendenti» dell’ateneo milanese riuscì a sottrarsi all’espulsione.
Dallo statistico Giorgio Mortara al chirurgo Mario Donati, dal giurista Mario Falco al patologo Alberto Ascoli, fino allo storico dell’arte Paolo D’Ancona, va sottolineato come la campagna di stampo razzista abbia privato l’Università del capoluogo lombardo di alcuni tra i docenti più noti e stimati. Una perdita che andò inevitabilmente a ripercuotersi sulla qualità degli ambienti scientifici e culturali della stessa Milano.
L’A. ne ripercorre le vicende, raccontando le loro carriere, l’adesione al fascismo, il rapporto con la cultura e la religione ebraica, ma anche l’allontanamento dall’accademia, l’emigrazione, la partecipazione alla Resistenza e, talvolta, la deportazione. Al termine del Conflitto, molti docenti decisero di riprendere il proprio posto, spesso al fianco di chi li aveva sostituiti, dando così luogo a una sorta di imbarazzante continuità con il passato. Qualcosa di simile fecero gli studenti che, dopo essere stati espulsi dagli atenei, ricominciarono a studiare circondati da quella stessa miscela di indifferenza e ostilità che ne aveva accompagnato le vicissitudini.