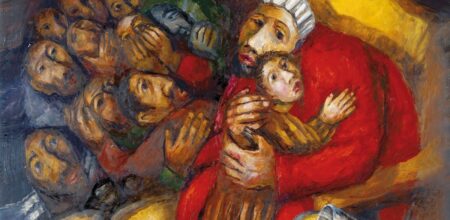|
|
«L’amicizia è una sorprendente scoperta: quella che non siamo soli, che c’è qualcuno che ha gusti, interessi e passioni molto simili ai nostri» (p. 7). Con questa rasserenante dichiarazione Paolo Gulisano introduce il lettore nella sua ultima impresa letteraria, uno di quei libri che molti divoratori di classici avrebbero desiderato scrivere.
Il titolo prende spunto da una citazione: «Ci incontreremo là dove non c’è tenebra». Sono parole attinte dal capolavoro di George Orwell, 1984, che l’autore emblematicamente sembra scegliere con l’intento di definire i contorni di uno spazio inondato di luce, l’amicizia.
Ma cosa succede quando questo tipo di relazione umana nasce tra gli scrittori? Con ordinato criterio cronologico, il saggio presenta le figure di 23 coppie di amici (tanti quanti sono i capitoli di cui si compone il libro), di scrittori tra i maggiori degli ultimi due secoli. In bella prosa piana e distesa egli tesse la trama di una serie di gustosi racconti biografici grazie ai quali ciascuna coppia si trova situata nel rispettivo contesto storico e geografico, a sua volta rapidamente, ma opportunamente tinteggiato.
Scopriamo così che anche per molti di loro l’amicizia non fu solo condividere gusti, passioni, interessi e attività, ma anche scendere insieme nell’abisso del cuore umano (Nathaniel Hawthorne e Herman Melville); che, se l’amicizia è un sentimento che lega il più delle volte persone profondamente affini, può essere vissuta da individui tra loro molto differenti (Giacomo Leopardi e Antonio Ranieri); che talvolta essa ha potuto unire persone di diversa cultura, di diversa religione, di diversa nazionalità (James Joice e Italo Svevo).
È potuto capitare, inoltre, che tra due grandi scrittori l’amicizia sia nata quando, ancora giovani e promettenti, furono invitati a cena da un editore per ricevere la proposta di realizzare un libro (Arthur Conan Doule e Oscar Wilde). Oppure che due amici di infanzia siano cresciuti e maturati insieme, in una piccola città di provincia, diventando entrambi scrittori e ottenendo quasi contemporaneamente il successo (Truman Capote e Harper Lee).
Gulisano ci accompagna anche nel racconto di amicizie mancate, a volte appena sfiorate (come quella tra George Orwell e Graham Green), perché nella galleria di coppie di amici scrittori c’è spazio anche per questo tipo di rapporto.
«Ci può essere poi amicizia tra il diavolo e l’acquasanta? – si domanda un po’ retoricamente l’autore – Tra due esponenti di visioni religiose e politiche diverse, e anzi opposte?». In base all’esempio di François Mauriac e André Gide, Gulisano ci fa riconoscere che ciò è possibile.
Talvolta l’amicizia tra due scrittori può far sì che uno dedichi all’altro una biografia (Elizabeth Gaskell e Charlotte Brontë; Evelyn Waugh e Ronald Knox). Di altri apprendiamo che, oltre a essere stati amici, sono stati anche colleghi (Dino Buzzati e Gaetano Afeltra; Giovannino Guareschi e Carletto Manzoni); oppure che, come spesso accade, hanno condiviso lo stesso tragico destino (Sylvia Plath e Anne Sexton).
Nel saggio di Gulisano leggiamo anche come le amicizie tra scrittori spesso abbiano portato a collaborazioni, a influenze reciproche, a solidarietà e appoggio nel lavoro e nella vita privata, in qualche caso persino a un sodalizio sfociato in pubblicazioni a quattro mani (Carlo Fruttero e Franco Lucentini), o che l’amicizia si sia trasformata in amore vero e proprio, che li ha condotti al matrimonio (Raymond Carver e Tess Gallagher).
Di due coppie di amici, in particolare, si può notare come stiano particolarmente a cuore all’autore: si tratta, da una parte, di Gilbert Keith Chesterton e Hilaire Belloc e, dall’altra, di Ronald Reuel Tolkien e Clive Staples Lewis, «due maestri della narrativa fantastica, due testimoni della fede» (p. 197), per i quali l’autore sospende il rigoroso criterio cronologico per regalarci il proverbiale dulcis in fundo. I primi hanno formato un sodalizio umano così stretto che il polemista e scrittore George Bernard Shaw li ha definiti un tutt’uno, detto curiosamente «Chesterbelloc». Per i secondi, invece, l’amicizia fu l’esperienza di uno stupore: «il riconoscere di avere in comune sogni e speranze, oltre che interessi letterari. [Essi] fecero di questo stupore il nutrimento per alimentare la loro amicizia, il loro talento artistico, la loro fede cristiana» (p. 204).
Ci piace chiudere questa breve presentazione del libro citandone l’explicit: «L’amicizia è […] uno dei doni più belli che si possono ricevere. Come diceva William Shakespeare nel Riccardo III: “In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici”» (p. 206).
PAOLO GULISANO
Là dove non c’è tenebra. Storie di amicizia tra scrittori
Milano, Ares, 2019, 208, € 14,00.