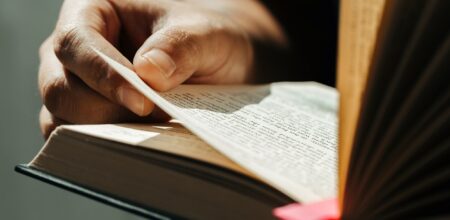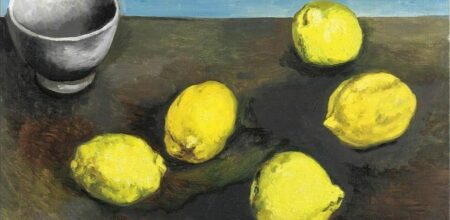|
|
Il cinema è immaginario, visione, racconto e intrattenimento, ricostruzione documentaria e opera di fantasia, luogo di sedimentazione dei sogni, ma anche – in particolare in Italia – sede della memoria storica. Mai come nel nostro Paese il cinema è stato deposito ineludibile della storia nazionale.
Gian Piero Brunetta, storico e semiologo del cinema, professore emerito di Storia e Critica del Cinema all’Università di Padova, dove ha insegnato dal 1970, è l’autore di questo volume sullo stretto connubio tra la settima arte e l’identità nazionale. Firma del quotidiano la Repubblica per oltre 20 anni, ha collaborato a innumerevoli mostre sul cinema e sul pre-cinema (per la Biennale di Venezia, il Guggenheim di New York e il Centre Pompidou di Parigi).
Il volume testimonia un legame necessario tra il cinema e la storia, che sin dal 1905 entra a far parte del racconto cinematografico in Italia per non lasciarlo più, assumendo dunque un ruolo essenziale di costruzione e di rappresentazione dell’identità nazionale. In quest’opera – divisa in 14 capitoli – Brunetta affronta un percorso lungo tre secoli – XIX, XX fino alle soglie del XXI –, proponendo al lettore un racconto esaustivo e intenso di come il cinema italiano, sin dal Risorgimento, abbia intrecciato i due livelli – quello della grande storia e quello della storia quotidiana – e come abbia raccontato la Prima guerra mondiale, i regimi totalitari, il dopoguerra in Italia, fino ai fondamenti dell’identità nazionale nella storia italiana del Novecento.
Attraverso un’accurata selezione e un’analisi documentata e puntuale di opere documentarie, filmati, corti e lungometraggi, l’autore propone al lettore un viaggio di ricerca a ritroso nel tempo (dall’Ottocento ai primi anni Duemila) del «corpo e delle maschere di Mussolini», dell’impatto deflagrante del cinema italiano come ambasciatore nel mondo, grazie anche a capolavori come Roma città aperta, di Roberto Rossellini, e di come la ricerca dell’identità nell’Italia del dopoguerra sia stata potentemente attratta da uno sguardo americano-hollywoodiano, pur presentando chiari temi indigeni specifici, come la famiglia, la casa, la musica e i giovani.
Brunetta mostra anche come la piccola storia quotidiana emerga potente dalle macerie in opere di maestri quali Germi, Monicelli, Risi (Gioventù perduta, 1947; Padri e figli, 1957; I mostri, 1963), senza naturalmente trascurare protagonisti dello schermo a livello trans-nazionale e trans-generazionale, quali Totò o Alberto Sordi. Ci ricorda come il Novecento sia più che mai il secolo degli autori, e quanto il loro «segno» sia stato unico: da Blasetti alle firme internazionali del neorealismo italiano (De Sica, Zavattini, Rossellini), ai nomi inscritti nella storia del cinema mondiale, come Visconti, Fellini, Monicelli, alla nouvelle vague dei registi, tutti tessere di un mosaico complesso ed estremamente articolato: Pasolini, Olmi, Bertolucci, Rosi, Taviani, Ferreri, Zurlini, De Seta, Scola, Bellocchio, Wermüller, Cavani, Taviani, Loy, Montaldo, Vancini, Petri, Amelio, Giordana e Moretti.
Obiettivo dell’autore è dunque mettere a fuoco il cinema italiano come fonte storica di interesse primario, sede di racconto e interpretazione di alcuni momenti cruciali per l’identità nazionale a confronto con quella europea e mondiale, luogo di costruzione di strategie e tattiche di organizzazione del consenso e di forme del divismo, fino all’esplicitazione del problema primario e tuttora aperto per il nostro Paese, ossia quello della «mancanza di una memoria condivisa» (p. 18). In sua assenza, non c’è epos, né unità nazionale.
GIAN PIERO BRUNETTA
L’Italia sullo schermo. Come il cinema ha raccontato l’identità nazionale
Roma, Carocci, 2020, 368, € 32,00.