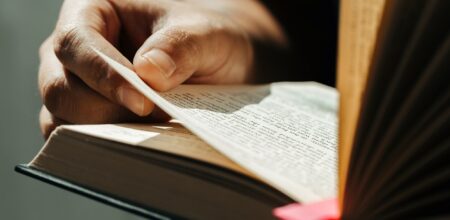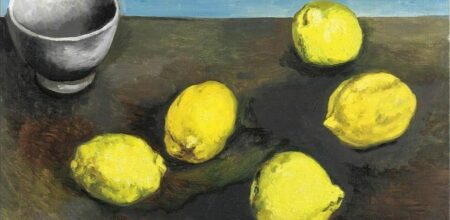|
|
I rapporti tra le comunità politiche (imperi, monarchie e Stati vari) e la Chiesa cattolica costituiscono da sempre una vexata quaestio, soprattutto per quanto riguarda la loro qualità, dal momento che i rapporti in sé sono un dato storico incontrovertibile dall’inizio della Chiesa. È una problematica che si è presentata sempre nel corso dei secoli, anche se con accentuazioni diverse. Del resto, lo stesso Concilio Vaticano II nella Gaudium et spes, nn. 75-76, ha delineato anche il tipo di rapporto che la Chiesa vuole instaurare con le comunità politiche: non una generica e contingente collaborazione, ma una «sana collaborazione», e questo per il fatto che entrambe sono chiamate, anche se a titolo diverso, a servire le stesse persone come individui e nel loro relazionarsi nella società.
Per queste ragioni risulterà senza dubbio arricchente la lettura del volume di Maria Teresa Capozza, docente di Fondamenti del diritto europeo all’Università Lumsa di Roma, sul rapporto tra sacerdotium e imperium nelle Novellae constitutiones, alla luce della cosiddetta «teoria della sinfonia», enunciata da Giustiniano nella praefatio della Novella 6, dell’anno 535. La tematica viene sviluppata nel libro in due parti.
Nella prima parte, si mette in risalto che tra sacerdotium e imperium deve intercorrere una bona consonantia per l’utilitas del genere umano. L’autrice non manca di notare che quanto affermato da Giustiniano è in linea di continuità con quanto sancito dai suoi predecessori, in particolare dalla legislazione del IV secolo. In questa prospettiva, lo studio, partendo da una ricostruzione dogmatica della terminologia adoperata nella praefatio della Novella 6, traccia la distinzione tra sacerdotium e imperium sulla base dei caratteri e delle competenze che contraddistinguono i due poteri.
Nella seconda parte, l’autrice esamina le occorrenze del termine consonantia nel Corpus iuris civilis e del lemma sacerdotium nelle Novellae, al fine di individuare i princìpi che presiedono al rapporto tra potere sacerdotale e potere imperiale. Essi sono improntati alla ricerca di collaborazione. Questa si manifesta, da un lato, nel supporto che il sacerdotium offre all’imperium nell’esercizio di delicate funzioni, al fine di assicurare un’efficiente gestione della res publica: proprio perché coloro che sono responsabili del munus sacerdotalis sono ritenuti un esempio di onestà e trasparenza, vengono loro assegnati specifici compiti di supervisione di quegli organi dell’imperium particolarmente rilevanti dal punto di vista «sociale». Dall’altro lato, l’imperium è attento a che il sacerdotium si comporti con rettitudine, e pertanto Giustiniano promulga, con riferimento a esso, plurimae leges, volte a tutelarne l’honestas, la pudicitia e la puritas. Così l’esigenza che il sacerdotium si renda testimone di una vita onesta e irreprensibile garantisce, nella prospettiva dell’Imperatore, sia la pax communis della sanctissimae ecclesiae, sia la superna pax reipublicae (Novella 42,3.3), e la preghiera assume un rilievo centrale in quanto è volta ad assicurare benefici al popolo (Novella 133,5.1). Tematiche, queste, che mai come oggi è importante recuperare.
MARIA TERESA CAPOZZA
Sacerdotium nelle Novelle di Giustiniano. «Consonantia» (συμφωνία) e «amplificatio» della «res publica»
Torino, Giappichelli, 2018, 200, € 29,00.