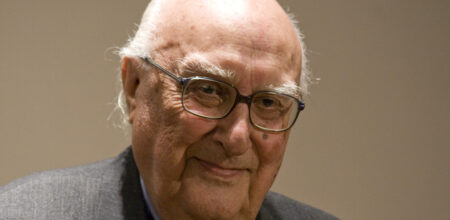|
|
Il libro si propone di affrontare i rapporti tra arte e politica in modo innovativo. Dichiara sin dalle prime battute di non voler parlare di arte come «argomento politico», né di arte nel suo essere oggetto di uso propagandistico, e neppure di strumentalizzazione da parte della politica. L’intento del saggio è quello di dimostrare che si può pensare l’arte dalla prospettiva del «politico», inteso come modo peculiare dell’esistenza umana.
Ma cosa significa pensare dalla prospettiva del politico? La risposta si trova in una nota di Hannah Arendt del 1953: significa «riconsiderare tutte le dichiarazioni filosofiche sull’uomo, supponendo che siano gli uomini, e non l’uomo al singolare, ad abitare la terra». In altre parole, si tratta di porsi tutte le domande di senso – «cos’è l’amore, cos’è l’amicizia, cos’è la solitudine, cos’è l’agire, cos’è il pensare?» – non cercando di definire questi concetti in astratto, ma partendo dal dato di fatto che siamo in molti ad abitare la terra, ognuno con il suo modo di pensare, e che ogni cosa assume un significato condiviso solo nelle interrelazioni che si stabiliscono tra gli esseri umani.
La filosofa tedesca parla di interrelazioni propriamente politiche, in cui gli uomini hanno la capacità di prendere l’iniziativa del tutto spontaneamente, dando vita a qualcosa di nuovo e inaspettato, e il loro agire può provocare effetti imprevedibili. Nell’evidenziare questo tratto, il politico assurge a una dimensione autenticamente umana: dimensione di una libertà che in ogni momento può costruire un mondo o metterlo a repentaglio.
Arendt non ha mai scritto una teoria dell’arte, tuttavia dalle sue opere si possono ricavare spunti su questo argomento. È ingenuo ritenere che il valore dell’arte consista in qualche sua speciale essenza o caratteristica formale. Il suo segreto si cela piuttosto nelle relazioni che gli esseri umani stabiliscono tra loro incontrandosi «nella parola e nell’azione», esprimendo liberi giudizi su di essa, dando vita a quello che spesso viene chiamato «mondo dell’arte».
Il libro spazia dall’estetica alla sociologia e alla storia dell’arte. L’analisi del lavoro di alcuni artisti è svolta su un piano diverso da quello delle teorie tradizionali. Vengono proposte nuove definizioni per diversi termini chiave della lettura formale, quali «medium», «supporto», «scultura», «rilievo». Spesso si ritorna alle teorie di Arendt, quasi per una verifica di metodo.
Il volume si divide in tre parti. La prima è dedicata all’inquadramento del metodo e alla collocazione dell’arte nelle dimensioni della cosiddetta vita activa (secondo Arendt), cioè lavoro, opera, azione: il lavoro, che consente la sopravvivenza e la riproduzione; l’opera, che è la dimensione della produzione di oggetti durevoli che costituiscono il mondo di cose artificiali che ci circondano; l’azione, ossia l’insieme degli atti non finalizzati alla sopravvivenza, con i quali gli esseri umani interagiscono tra loro senza la mediazione di oggetti.
Quest’ultima è la dimensione propria della politica (l’unica che presuppone l’essere in molti), e come tale è contrassegnata dalla libertà, dall’indeterminatezza e dall’imprevedibilità. La politica è il luogo del rischio e insieme della possibilità di dare vita a qualcosa di nuovo. Riprendendo alcuni passi di Arendt, l’autore invita a considerare quella particolare categoria di oggetti che sono le opere d’arte come un qualcosa che si pone a cavallo delle dimensioni dell’opera (nel suo essere oggetto) e dell’azione (come esercizio di libertà, e per la possibilità di provocare effetti imprevedibili).
Nella seconda parte si affronta la questione del giudizio estetico. L’autore riprende la lettura arendtiana di Kant, per dimostrare che il giudizio estetico può essere inteso come specie del giudizio politico. Nel giudizio estetico, infatti, si giudica bello qualcosa non quando semplicemente «ci piace», ma quando il piacere che proviamo è anche «comunicabile», ossia quando possiamo a ragione pretendere che tutti lo possano giudicare bello allo stesso modo. Il giudizio è quindi una facoltà che presuppone la presenza di un consesso di persone e la capacità del giudicante di mettersi con l’immaginazione nei panni degli altri e di vedere le cose dai loro punti di vista. In altre parole, il giudicare è sempre un giudicare insieme, d’accordo o in disaccordo, con gli altri. Pertanto il giudizio estetico è «la più politica delle facoltà» e si esercita in uno spazio per definizione abitato da molti, uno spazio politico.
Nella terza parte si parla del rapporto tra arte e libertà, dove libertà non è semplicemente il fare ciò che si vuole, ma, come per gli antichi greci e romani, quello spazio politico in cui, proprio perché è garantita la parità, ognuno può rendere visibile la propria differenza. Così, in ogni opera d’arte la spontaneità e novità del gesto dell’artista è fondazione di una libertà durevole. In primo luogo, essa realizza qualcosa per lo sguardo di molti, e nell’intreccio dei loro liberi giudizi questo qualcosa può conservarsi per le generazioni future. In secondo luogo, nel suo perpetuo attivare il giudizio degli esseri umani costituisce un continuo appello alla libertà. Alla fine del viaggio, l’arte appare a tutti gli effetti come un fenomeno esemplare del politico, che ci ricorda e mantiene per noi il senso pieno della libertà come reciproco riconoscimento degli esseri umani.
ALESSIO FRANSONI
Teoria politica dell’arte. Riflessioni a partire da Hannah Arendt
Nocera Inferiore (Sa), Orthotes, 2018, 308, € 23,00.